SUL MEDITERRANEO INCOMBE UN’AREA DI BASSA PRESSIONE
Sul Mediterraneo incombe un’area di bassa pressione. Un bel collegio dei docenti convocato con i rispettosi cinque giorni di anticipo e che quindi, legalmente e moralmente, può svolgersi oggi 14 novembre 2015, il pomeriggio dopo gli attentati di Parigi. È difficile ascoltare il preside in una situazione come questa. Parliamo disordinatamente, quaggiù nei banchi in fondo: una collega di filosofia sostiene che ci sia da ragionarci su un po’, oltre la passione del momento, con cautela. Anche se sicuramente, precisa, le ha fatto un certo effetto sentire la marsigliese oggi.
Continua a leggere
«Non riesco a emozionarmi più per niente» commento io.
«Perché tu sei uno freddo» mi risponde Calboni, di matematica e fisica.
Il collega alla mia destra guarda l’orologio e sbuffa, il collega alla mia sinistra parla di elaborazione. Il preside, un ometto piccolo e quasi curioso, aureola di capelli biondi, cravatta celeste, passione per le donne polacche, stringe sotto il braccio le circolari che arrivano dal ministero e alle quali nessuno presta attenzione. L’età media è così elevata che mi porto addosso i miei trent’anni con fastidio e senso di colpa.
«Questa scuola diventerà più giovane, più veloce e più efficiente. È meglio che vi prepariate» dice il preside.
«Mi scusi, preside» interviene il collega di matematica di cui sopra.
«Dirigente scolastico» dice lui.
«Ah, preside non si può più?»
«No.»
«Posso chiamarla doc?»
«No. Può chiamarmi manager.»
«Ok, va bene. Senta, preside…»
«Ho detto dirigente.»
«Sì, è vero. Dirigente-slash-manager-slash-doc: che cazzo vuol dire quello che ha detto?»
«Che o vi adattate o perite. Siamo stanchi di perdere tempo…»
«Scusi, dirigente-slash-manager-slash-doc» riprende lui. «Ma noi chi?»
Il preside lo squadra irritato. «Noi siamo stanchi di perdere tempo in questa bolla di consuetudini e conservatorismo che si chiama scuola pubblica. L’Italia va avanti!»
Una piccolissima parte del corpo docente, laggiù sul lato destro dell’aula magna dal tetto alto e dal pavimento di parquet, dalle sedie verdi e dai corridoi stretti, dalle luci calde e dall’acustica insopportabile, sembra reagire con soddisfazione. Uno si gira a guardarmi, il mio senso di colpa si fa più acuto, mi estraneo dalla discussione, vado fuori a fumare anche se non fumo, il gruppetto del lato destro mi osserva con disapprovazione, la colpa è troppo grande, le spalle troppo strette. Mi guardo intorno, il marciapiede è deserto, il sole sta tramontando, lo scenario è lo stesso dell’ora di ricreazione, quando noi docenti siamo costretti a uscire dai cancelli per fumare: è fatto assolutamente divieto di farlo nei locali della scuola, ivi compreso il cortile, le palestre, i bagni dei docenti (come da circolare del dirigente numero non-ricordo). Mi raggiunge una collega di inglese, e gli insegnanti di inglese sono i nostri nemici naturali. Nostri di chi?
«Quanti anni hai tu?» mi chiede mentre lavora sulla pietra focaia.
«Trenta.»
«Be’, più o meno la mia stessa età. Il futuro della scuola è sulle nostre spalle.»
Della percezione delle mie spalle ho già detto, quindi le scrollo, incapace di formulare un pensiero.
«Cosa insegni tu?»
«Filosofia e storia.»
«Be’, allora dovresti sapere che la nostra è una cultura di pace.»
«Quella scolastica intendi?»
«No, mi riferivo a Parigi.»
Nostra chi-cazzo-chi? Rientriamo che sui muri rimbomba la parola “valutazione”, il preside sta in piedi dietro il banco, una segretaria ingiallita prende gli appunti.
«… e perciò posso dire che in questi mesi, in ottemperanza alle indicative ministeriali, abbiamo realizzato tutto ciò che ci eravamo proposti, abbiamo raggiunto gli obiettivi prestabiliti, siamo entrati di prepotenza nel ventunesimo secolo. Oggi noi mandiamo in soffitta i professionisti del non-ce-la-farete-mai.»
Il gruppetto sulla destra applaude, io penso di avere addosso l’espressione dello stupore più ingenuo.
«Lei» mi dice il preside.
«Io?»
«Sì, lei. Professor…»
«D.»
«Solo D.?»
«Già, solo D.»
«Bene, lei rappresenta il futuro. I giovani, le forze libere dai vincoli di questa società gerontocratica e inadeguata, conservatrice e reazionaria. Lei rappresenta il futuro della scuola, di questa scuola e del nostro Paese.»
«Scusi, preside» replico io.
«Manager» mi corregge.
«Scusi, manager. Ma lei quanti anni ha?»
Mi gela con lo sguardo, la seduta è tolta.
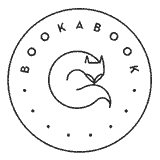



Laura Sini
Un testo mordace (o forse Mordente), ironico e sarcastico, tanto nei dialoghi quanto nello stile e nei contenuti.
Una critica non troppo velata al modernismo dilagante che fa anche della scuola e dei suoi abitanti un bene da mercificare.
Un libro che mi ha fatto divertire e riflettere…
Un grazie a Maurizio perché, tra le pagine, mi ha concesso di rivivere suoni e profumi della tarda adolescenza… Emozionante!