RAZVAN E RAZVAN
Su un punto il suo capo aveva ragione: amava Bucarest. Amava girare a vuoto per le strade della città, annusare gli odori che salivano dai cortili abbandonati, sentire le voci stridule delle donne zigane e le grida roche degli uomini, che parevano sempre ubriachi. Amava le ombre, perché di colori ne vedeva ben pochi. Ciò che non gli piaceva era la centrale di polizia: non sopportava i colleghi e se proprio doveva scrivere un verbale, preferiva dettarlo al telefono a Adina. Da molto tempo non aveva più un ufficio, l’aveva lasciato a Adina e lei lo custodiva nella speranza che lui tornasse il più spesso possibile.
Continua a leggere
Razvan si mostrava in centrale solo quando il capo lo obbligava.Tutto quel mondo gli ricordava l’apparato. Certo, era anche il suo passato, ma un passato che non era servito a nulla. Il passato non è altro che il presente andato a male.Solo che il cibo si può buttare mentre la propria vita non va in discarica. Ti resta addosso, puzzolente. Questo era il suo pensiero.Un uomo non sceglie l’epoca in cui vivere e se avesse potuto farlo, Razvan non avrebbe saputo decidersi. Non era così ingenuo da pensare che l’umanità fosse mai stata migliore. Ogni giorno che trascorreva, si rafforzava in lui la convinzione di essere nel posto sbagliato e nel momento peggiore e che l’unica alternativa fosse il non esistere. Sì, non esistere doveva essere proprio una buona condizione. In molte occasioni aveva avuto la forte sensazione di essere completamente assente al mondo, di guardarlo da un angolo buio, non da sopra ma da sotto. Della città lo affascinava la concretezza, fatta di volumi di pietra scolpiti in stili diversi, che rimandavano a un tempo antico, a persone che avevano sofferto e combattuto. Le trasformazioni moderne, invece, lo infastidivano, con tutti quei palazzi di vetro e la loro finta, ingannevole trasparenza. E le persone? Razvan pensava pocoa se stesso e molto agli altri, quasi sentisse su di sé la responsabilità dell’umanità intera. Le persone erano un’altra faccenda. Nella città gli sembravano un po’ più vere, o forse era solo una sua speranza.
«Non è cambiato niente» gli stava dicendo un insegnante di italiano, un omone con il suo stesso nome. «L’ideologia non significa più nulla, liberali… PSD… partito del popolo… prima si arricchivano dentro l’apparato, con l’arroganza di chi sa di approfittare della posizione di potere; con la democrazia, invece, rubano con la convinzione di essere nel giusto per volere del popolo.»L’ispettore Razvan Ursuleanu taceva, ascoltava, scettico, non tanto perché il suo omonimo non avesse ragione, quanto perché quell’uomo non lo convinceva. C’era qualcosa inlui che riconosceva come una tara del suo popolo, una delle tante. «Mio nonno…» L’insegnante fece una lunga pausa prima di continuare, come se non riuscisse a trovare un verbo adeguato a esprimere quel che voleva attribuire all’avo, che, essendo vissuto sotto il regime, o lo aveva subìto oppure l’aveva appoggiato. Ma di opposizione, a ben vedere, ce n’era stata poca. «Mio nonno dice che, almeno, a quel tempo avevamo un forte senso dello Stato. Oggi, invece, lo Stato è solo un magazzino da saccheggiare.»Il suo amico sorseggiò la birra. Non era proprio un amico. Razvan non aveva amici, non aveva mai avuto tempo per gli amici. Lo aveva incontrato qualche giorno prima alla clinica di oftalmologia. L’altro non aveva problemi agli occhi, aspettava sua madre, che stava facendo una visita; l’ispettore doveva fare il solito controllo, il medico gli aveva confermato l’evidente cecità.

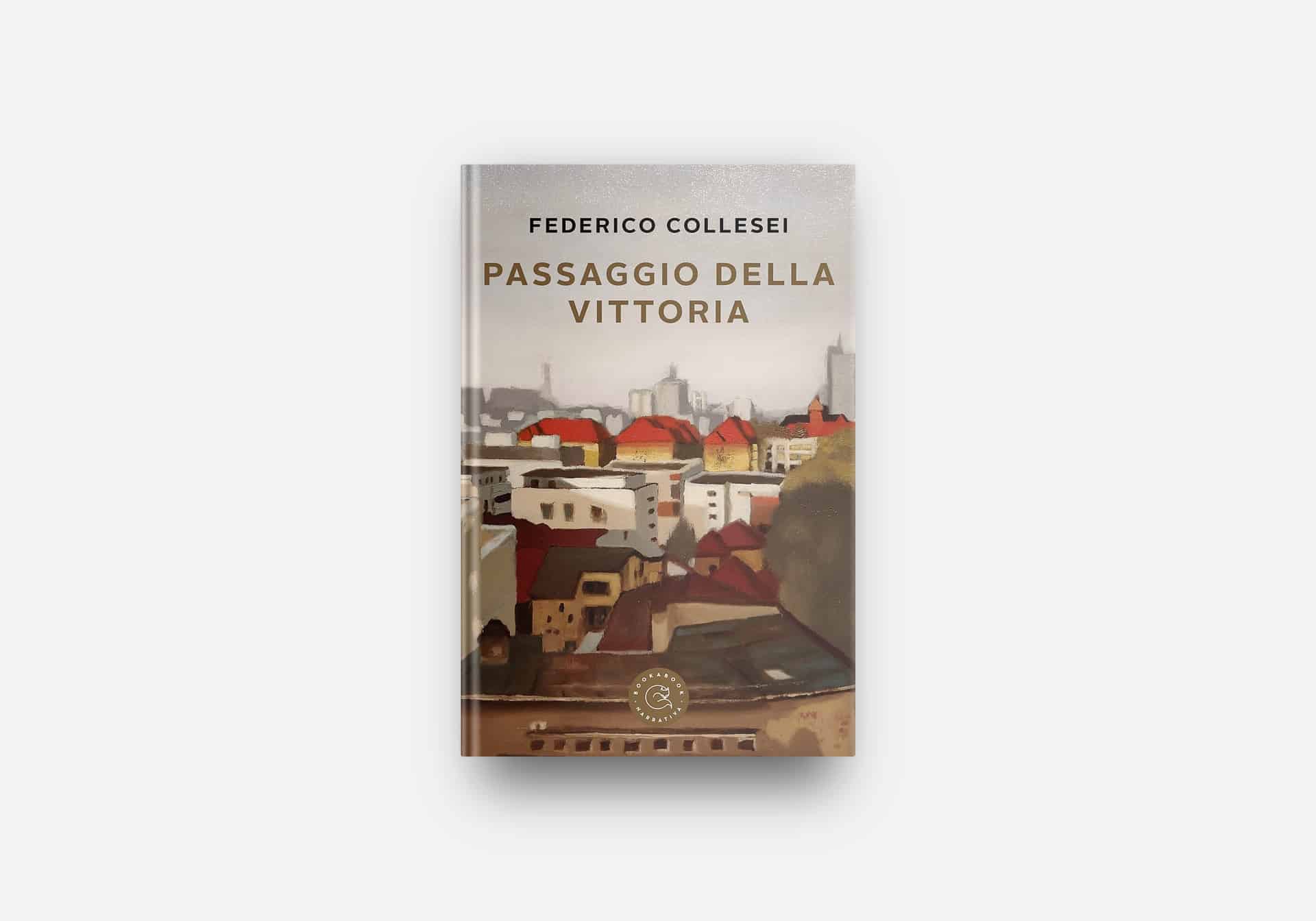

Federico Collesei
Divorato. Avvincente fino all’ultima pagina. Bravo Federico. Resto in attesa del terzo Razvan.
Maria
Federico Collesei
Passaggio della Vittoria molto avvincente e inquietante al punto giusto!!! Bucarest grande protagonista insieme a Razvan Bravo Federico
Elisabetta
Federico Collesei
Letto l’ultimo Razvan.
Scrittura elaborata e matura. Ben limato.
Complimenti Federico.
Max
Federico Collesei
Questa è la prima recensione al mio libro, indovina chi è l’autore?
Caro Federico,
Durante il week-end ho terminato la lettura del “Passaggio…..”: mi è piaciuto tantissimo, non immaginavo. Ammetto di averlo avvicinato con qualche sospetto ed un sottile pregiudizio: mi aspettavo un’opera molto autobiografica ed autocontemplativa, intrisa dell’insopprimibile e narcisistica pulsione all’approfondimento delle esperienze vissute in “partibus infidelium”. Ed invece (a dimostrazione di quanto sia stato sciocco e superficiale il mio pregiudizio) sono stato risucchiato in un viaggio appassionante ed inquietante nello spazio (la Romania a me totalmente sconosciuta), nel tempo (la Romania “risorta” dopo la Dittatura, la Romania di Antonescu, la Romania del Conducator), e nell’ animo umano. La tua è un’allegoria spietata e disperata della banale ineluttabilità del male, e della rassegnata sua accettazione a cui tutti, alla fine, siamo costretti. Mi ricorda un pò, mutatis mutandis, l’epilogo di 1984.
E poi, è scritto in un gradevolissimo italiano, che di questi tempi è un pregio inestimabile.
Spero proprio che tu voglia regalarci in futuro altri simili doni.
Francesco Di Virgilio