«Oggi è un grande giorno,» esordì, una volta che tutti ebbero preso il loro solito posto «un giorno fausto, da ricordare.» Tutti quanti abbozzarono un sorriso, ma nessuno parlò. «Merle,» si rivolse al padrone di casa «portaci da bere, il solito.» Poi si rivolse ai suoi figli: «Ragazzi, guardate i menù, ordinate e andate a lavarvi le mani».
I tre eseguirono alla lettera, iniziando a scorrere con gli occhi tutte le pietanze. Quando Marybeth, la gentile cameriera che da sempre lavorava tra quelle mura, arrivò con una grande caraffa di acqua frizzante, loro ordinarono i soliti piatti di sempre e si alzarono, diretti verso il bagno. Al loro ritorno trovarono i piatti già al tavolo, segno che probabilmente Merle conoscesse fin troppo bene le abitudini della famiglia Graham.
«Come mai ci avete messo così tanto?»
«Scusa, papà,» rispose Eva, la figlia maggiore, che era solita parlare sempre per prima e a nome di tutti «ma c’era fila e ad Ariel scappava.»
«Ariel,» disse il signor Graham, guardando la più piccola dei tre «la prossima volta avvertici, così almeno sapremo quanto aspettare. Hai otto anni, sei una signorina adesso, comportati come tale. Ora, prima di iniziare a mangiare, vorrei che tutti insieme pregassimo e ringraziassimo nostro Signore, e desidererei che a farlo fossi tu,» disse, rivolgendosi al suo secondogenito, l’unico maschio «perché oggi hai compiuto un passo importante, ti sei avvicinato a nostro Signore, hai mangiato la sua stessa carne nella tua prima eucarestia e lo hai fatto da uomo e come tale vai trattato.» Il piccolo lo guardò quasi incredulo, la sua speranza si era avverata e le poche parole che si era preparato da dire ora potevano liberarsi. Lui lo incoraggiò con un sorriso, uno dei pochi che a memoria gli avesse mai concesso. «Forza, comincia, prima che si freddi.»
Il sorriso di rimando di sua madre era come quelli che vedeva sui volti delle riviste che teneva ordinatamente impilati sotto il mobiletto della TV, o come quelli delle ragazze nei poster, quando lei lo portava dalla parrucchiera e lui rimaneva seduto ad aspettare che quelle donne si conciassero la testa, con strani e vorticosi giri di capelli e ciocche adornate da nastri colorati. Quel vezzo sembrava disegnato sul suo viso, tirato con le molle e carico di attesa e tensione, proprio come quello che aveva quando, quella stessa mattina, era stato chiamato per ricevere la sua prima comunione e un attimo prima si era girato a guardarla. Sembrava quasi che stesse per mollarsi e schioccare di botto. Era comunque bella, sua madre, della bellezza che conservano tutte le madri, di quelle che non possono sfiorire nemmeno volendo. Che lascia i figli innamorati e tormentati, sempre con qualcosa di mancato, di non detto, come se fossero costretti a vivere in eterno con un debito troppo grande per essere estinto. La bellezza che le rende le donne più desiderabili del mondo.
«Che questo pasto sia il mio vero primo,» disse, infine «come una persona nuova che muove passi decisi nel mondo e che possa giovare a tutti voi poterlo condividere con me, in questo importante e glorioso giorno di festa, conferma e consacrazione.»
Fu straordinario vedere l’espressione compiaciuta di suo padre, che amava e possedeva il dono della sintesi, e quella contratta della madre, distendersi in un liberatorio moto di soddisfazione. Niente schiocco quindi, solo un disteso sorriso.
«Amen, figlio mio» disse suo padre.
«Amen» fecero eco lui e gli altri alla tavola. Dopo quelle parole, l’unanime lode sembrò quasi suonare meglio delle altre volte.
«Bellissime parole, tesoro,» disse la madre «non è vero, caro?»
«Perfette. Sono state perfette.»
«Sì, è proprio così,» aggiunse Eva, che da sorella maggiore aveva già vissuto quella esperienza e si sentiva quasi in dovere di dire la sua e di spingere anche la sorellina a complimentarsi col fratello «sono state meravigliose, diglielo Ariel.»
«Lo sono state, Luc,» disse sbadatamente «molto belle.»
«Non chiamarlo così» esordì il padre, interrompendo subito quel momento di idilliaca aggregazione che si era creato.
«Mi spiace» disse subito, coprendosi la bocca con le mani.
«Vorresti che ti si chiamasse Ari? Vorresti che il tuo nome fosse mutilato, storpiato e che perda il suo significato? Il suo unico e importantissimo significato? Forza, rispondi» le chiese, ignorando del tutto la mano della moglie sul suo braccio.
«No, papà» rispose lei mortificata.
«Bene. Chiedi scusa.»
«Scusa, papà.»
«Non a me, a tuo fratello.»
«Scusami se ho mutilato il tuo nome,» disse, con matura coscienza, guardando il fratello e manifestando la sua età e sbadataggine l’istante dopo «ma a me piace di più Luc.»
«Non fa nulla,» rispose lui «noi siamo gli unici a cui può succedere, a lei non accade mai» disse, indicando la sorella dodicenne alla sua destra.
«Che posso farci se il mio nome non si può storpiare,» si difese Eva, punta sul vivo, quasi con tono di giustifica «è corto ed è bellissimo così.»
«Lo è,» irruppe il padre, imponendo immediatamente il silenzio «e deve piacerti il suo nome, perché è importante. Tutti e tre avete nomi importanti e meravigliosi. Un uomo è il nome che porta. Una donna è il nome che porta. Il mio nome è Christopher, sapete perché il nonno mi ha dato questo nome? Sapete cosa vuol dire il mio nome?»
«Sì» risposero i tre sommessamente, ma vennero comunque ignorati dal padre, che diventava sempre più incalzante e per la centesima volta si preparava a sciorinare eloquentemente la storia di come il vecchio Abraham Graham gli avesse dato il nome che, con estrema fierezza, portava da quasi mezzo secolo.
«Viene da San Cristoforo. La leggenda narra che fosse un cananeo che portò sulle sue spalle nostro Signore Gesù Cristo quando era un bambino, e gli permise di attraversare un fiume. Un uomo grande e grosso, forte e onorevole. Letteralmente vuol dire “Portatore di Cristo”. Capite, non solo portatore del suo corpo, ma del suo stesso fardello, del peso della sua immensa responsabilità. Dell’impegno preso nel rendere questo mondo, l’unico mondo, il migliore possibile. Fatto di persone pure, ligie, senza peccati. Ecco perché dovete capire che ognuno di voi è importante, indispensabile. Che ognuno di voi» disse, puntando verso di loro la forchetta «ha un compito in questa vita e deve portato a termine. È chiaro?»

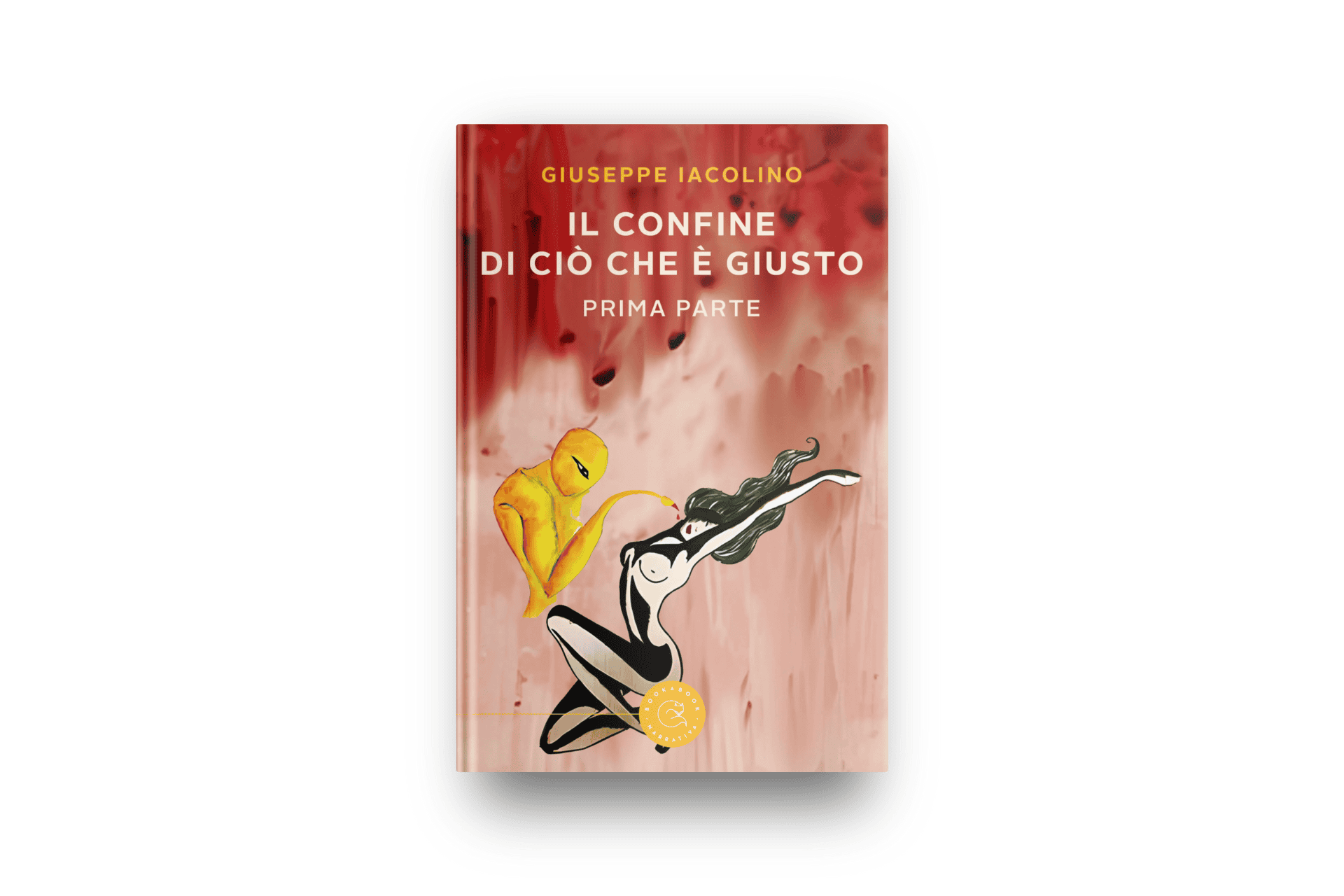



Commenti
Ancora non ci sono recensioni.