Iniziamo col dire che non ho intenzione di trattare in modo esaustivo o analitico la inquantificabile vastità di temi e di sfumature in cui l’AI si declina, né tantomeno di ambire alla persuasione forzata di chi legge, soprattutto di chi si professa “AI evangelist”, aberrante neologismo coniato per qualificare gli invasati di questa tecnologia e della “buona novella” di cui si fanno annunciatori. Quelli presentati in questo breve saggio – è bene specificarlo in modo ben chiaro fin da subito – sono stimoli, provocazioni ed interrogativi per gli approfondimenti che ognuno vorrà intraprendere e per le risposte che ciascuno desidera trovare con l’augurio di usare il proprio cervello anziché chiedere un suggerimento a ChatGPT. E partiamo inoltre dal fatto che quanto esposto abbia contenuti di carattere impopolare che spesso cozzano fragorosamente con la moda dell’attuale pensiero dominante in cui, se non fai qualcosa con la AI, vuol dire che vivi nel Cretaceo e che, alla pari dei dinosauri dell’epoca, meriti compassione ed estinzione.
Sebbene per chi scrive sia già sufficiente e nauseante beneficiare di Alexa nelle sue plurime e risibili potenzialità, la finalità insita in queste righe – ben lontana da ogni possibile accusa di misoneismo – è quella non tanto di porsi come detrattore alle allettanti e strabilianti applicazioni della AI, quanto di fungere da campanello di allerta innanzi alla seduzione smodata, incontrollata, inficiante e mortificante che tale tecnologia può già permettersi di vantare nei confronti dell’essere umano. Nessuna argomentazione di matrice pseudoscientifica quindi, ma spunti sparsi per una seria riflessione (conditi da quella spruzzata di sarcasmo che sostiene la ponderazione) che prende avvio da un punto cruciale, e cioè dall’impatto che l’intelligenza artificiale sta avendo nella sfera dell’acquisizione, dell’assimilazione e dell’elaborazione del sapere e nella modalità in cui esso discende nell’agire umano.
Qui risiede il pericolo più insidioso e la minaccia che riguarda espressamente da vicino bambini, adolescenti e ragazzi. Chi cioè ha più fisiologica attitudine ad avvicinarsi a questa iper-tecno-innovazione, coloro che con ingenua disinvoltura approcciano le sue fenomenali potenzialità e che ne testano l’immediato utilizzo con la logica del prêt-à-porter, senza farsi mezza domanda nel merito di quell’entità digitale che, per pura comodità, stanno chiamando con lo scopo di subentrare alle facoltà del loro intelletto. Il mondo di oggi è quello in cui la tecnoscienza impera e, per parafrasare una nota pellicola dei fratelli Coen, “non è un paese per vecchi”: chi quindi più dei giovani deve essere messo in guardia e salvaguardato dalle tentazioni dell’AI nel processo che darà forma e sostanza alla loro conoscenza?
L’AI è una tecnologia che per molti versi risulta davvero sbalorditiva (si presti attenzione alla radice semantica più pura di tale attributo, la quale riporta al “rendere balordo”, cioè sciocco, inetto) e che è sostanzialmente applicabile a quel che si voglia, come del resto lo fa l’intelligenza umana nella sua versatilità, pur nella modalità contenuta che la distingue. I benefici, ieri solo immaginabili in termini di plausibile attuabilità, sono qui a portata di pochi click e godibili da chiunque non superi i 60 anni di età, simbolica deadline passata la quale sembrerebbe di riscontrare nella popolazione un appetito maggiormente misurato, un entusiasmo più sobrio se non addirittura una certa velata insofferenza nel fruire delle potenzialità sconfinate dell’AI, con la conseguente propensione ad optare poi a favore di qualcosa di più antiquato come ad esempio la propria zucca. L’uomo da sempre ha cercato di realizzare qualcosa che potesse sostituirlo nell’esecuzione di un compito o nello svolgimento di un lavoro e lo ha fatto quasi sempre con appagante successo: oggi si prodiga invece per dotarsi di un mezzo che vada oltre il compensare un’azione materiale facendo rotta verso la spasmodica ricerca di ciò che possa surrogare la propria intelligenza, nella inverosimile speranza e ingenua presunzione di poter controllare questo prodotto che, ontologicamente, nasce esattamente per superare la sua capacità di controllo. Tralasciando gli sciagurati esempi agevolmente ricavabili dai teatrini della politica o individuabili all’interno di qualche organigramma aziendale, proviamo a chiederci come sia possibile immaginare che un’intelligenza maggiore venga controllata da un’intelligenza minore. Per tal motivo l’AI non può esser considerata alla stessa stregua di come si farebbe con un attrezzo in grado di ottimizzare e perfezionare l’esercizio di una mansione pratica: l’intelligenza artificiale (e su questo macroscopico equivoco di fondo risiede tutta la sua pericolosità non percepita) non è un martello o un aratro ma è un agente autonomo.
L’aspetto paradossale di quel che potrebbe definirsi “dilemma AI” è che l’intelligenza artificiale nasce promettendo di migliorare la vita dell’essere umano ma, andando progressivamente e inevitabilmente a superare ogni suo compito cognitivo, ne compromette alla fine l’esistenza. Una fregatura colossale cui andiamo incontro con fiero entusiasmo. Non è questa una osservazione suffragata dall’appetito per il catastrofismo o dall’inclinazione a visioni pessimistiche bensì da una algida analisi delle sole premesse in cui il fenomeno si sta manifestando adesso in plurime forme, avvertendo con nitore quelli che saranno i suoi più debordanti ed ingloriosi esiti. La strada è spianata ed evidente il corso intrapreso dall’AI nel suo vorace insinuarsi in qualsiasi attività quotidiana – dalla più banale a quella più sofisticata – per prenderne possesso e controllo. Un compito che non trova particolari elementi ostativi perché innanzitutto l’intelligenza artificiale della macchina ha come primo alleato la stupidità naturale dell’uomo. Il processo è inarrestabile e non vi è modo di contrastarlo al pari di ciò che è avvenuto con internet o la globalizzazione e che accadrà pure con la digitalizzazione, la blockchain e le criptovalute: cose meravigliosamente valide e disastrose al tempo medesimo, ciascuna in grado di rappresentare in un unicum la comunione di beneficio e maleficio per l’umanità ma da cui l’uomo non riesce ad astenersi nella sua storica e genetica abilità a far andar tutto per il verso storto. È inutile allora cercare di opporsi strenuamente alla propagazione dilagante della AI ed alla sua prossima egemonia in qualsivoglia campo di applicazione: questo però non vuol dire affatto che un po’ di sana resistenza guidata da un atteggiamento controcorrente possa nuocere alla salute, all’anima e all’intelligenza dell’individuo. Oppure è più accomodante mettere due belle fette di salame sugli occhi e lasciar perdere?
Il senso del limite è lo spartiacque tra intelligenza umana e intelligenza artificiale: la prima ce l’ha, la seconda no. Una AI limitata (anche quella che viene cautamente definita con l’acronimo ANI, Artificial Narrow Intelligence) diviene una forma di ossimoro intollerabile, qualcosa di essenzialmente non concepibile: l’inghippo celato dagli entusiasmi per lei nutriti e che animano questi tempi risiede nel fatto che abbiamo deciso di delegare ad un sistema di algoritmi la nostra coscienza del limite, ciò che ci consente di effettuare delle scelte contenute nel numero ma comunque di saper valutarne l’entità, di gestirne la misura, di accettarne le conseguenze, di apprezzarne il valore, di assaporarne il gusto. Nel nostro esser naturalmente limitati vediamo una mancanza da colmare con qualcosa di artificialmente illimitato che pertanto – per sua natura artefatta! – non può acconsentire a ridursi né a supplente né, tantomeno, a mero strumento. L’illimitato al servizio del limitato? Non suona affatto. Compaiono qui due ingredienti che per principio non possono far parte della stessa ricetta, due fattori che tra loro non possono mecciare (vocabolo di raccapricciante attualità usato da programmatori o adolescenti come sinonimo di combaciare, abbinarsi, avere qualcosa in comune, dall’inglese to match). Non che l’intelligenza umana abbia acquisito una valenza negativa – ci mancherebbe altro – ma su di essa si proietta una certa inadeguatezza, insufficienza e insoddisfazione, ragion per cui ci siamo inventati qualcosa di artificiale con lo scopo di trovare un rimedio a questa presunta manchevolezza, senza interrogarci però se esso sarà peggiore del male. Oggi la NI (Natural Intelligence) è divenuta una questione non più sopportabile dall’uomo stesso, un’insostenibile imperfezione, uno pseudo-difetto da far correggere a un potentissimo sistema digitale che peraltro perfetto non è. È innegabile il beneficio che la AI apporti in molti settori ma l’allarme da lanciare è che essa non vada a costituirsi come elemento onnipresente, costitutivo ed imprescindibile per qualsiasi attività umana, manuale o cerebrale che sia. Tale processo – già in corso – conduce inevitabilmente una persona a porsi in una condizione di subordinazione rispetto all’AI perché ha concesso a quest’ultima di sostituirsi alla propria intelligenza, facendosi placidamente accompagnare in un moto di regressione mentale. Qui è necessario ponderare non tanto sui rischi che l’AI ci vuol far correre quanto sulle rinunce cui saremo costretti: in pole position c’è appunto l’intelligenza naturale-individuale in tutta la sua meravigliosa modestia, di cui l’intelligenza artificiale-collettiva vuol fare un sol boccone. Il senso del limite è ciò che ci distingue da un sistema d’intelligenza artificiale ed è questo senso che per l’appunto rende virtuosa un’opera umana: la macchina non si stanca, non suda, non soffre, non combatte, non compete, non si arrende, non accetta la resa o il fallimento: in una battuta, non ha autostima. L’AI può avere meriti ma non ha virtù (non si dimentichi che questo sostantivo giunge dal latino vir, cioè uomo) e pertanto i suoi prodotti non possono essere considerati per definizione come “virtuosi” ma solamente apparire tali, perpetrando quella sottile finzione che trova forma, appunto, nell’artificio.
La rivoluzione di cui l’AI è protagonista avanza modificando e trasformando radicalmente il modo di pensare e di fare una cosa, e ciò vale tanto per l’individuo che ne è consapevole quanto per quello che non lo sia: ma c’è una vaga idea della contropartita che implica un cambiamento di un peso specifico mai sperimentato prima? quale sarà lo scotto da pagare per un salto evolutivo – o involutivo? – di stazza così epocale? Se una delle possibili risposte ammette la perdita parziale o l’intera rinuncia all’autonomia, all’indipendenza, alla capacità di scelta e infine alla libertà, allora conviene mollare il colpo ora, anche se la congenita presunzione e orgoglio dell’uomo vorranno prevalere. Ma si è già detto prima che, una volta accesa la miccia all’AI, il processo di combustione è inarrestabile e l’incendio originato già divampa propagandosi sotto i nostri occhi: che fare allora? L’unico rimedio per sottrarsi ad uno stato di completa soggiogazione nei confronti dell’AI è quello di trovare fonte di ispirazione e guida negli Antichi, custodi di quella tradizione che sta agli antipodi dell’habitat in cui dimora l’intelligenza artificiale. L’obiettivo sarà allora quello di trovare una via di mezzo che conceda di vivere l’era dell’AI senza il bisogno di sentirsi subordinati ad essa in ogni situazione – quasi fosse un perentorio obbligo di condotta – e di domandarsi se una cosa possa essere pensata ed elaborata con il proprio cervello (cum grano salis) anziché optare meccanicamente per l’algoritmo, accettandone in automatico il risultato propinato. Tanti insorgerebbero qui obiettando che quanto generato dall’AI non debba costituire il prodotto finito ma solo una base da revisionare e da riplasmare con personalità propria: ciò non evita comunque la questione dello stravizio sistematico sotteso. E a coloro che invece ne facessero tutta una questione di risparmio di tempo (ne conosco una fiumana), mi verrebbe da chiedere quante e quali insostenibili ricorrenti premure la vita li costringa a dover gestire tanto da non poter sporadicamente astenersi dal consumare il loro rapporto quotidiano con l’AI: non guasterebbe in tal caso ricordare ciò che scrive Seneca all’inizio del suo trattato De brevitate vitae, sicché funga da monito: “Non abbiamo poco tempo, ma molto ne perdiamo”. L’auspicio allora è che venga coltivata e si diffonda quell’aurea mediocritas cara a Orazio: un concetto che nulla ha da spartire con la ‘mediocrità’ bensì che riporta ad uno spirito animato dalla ‘moderazione’ nel fare uso e nel godere di qualcosa. Se la rinuncia all’agente artificiale è cosa assurda ed anacronistica, il fronte su cui impegnarsi sarebbe quello di accordarsi alla celebre sentenza latina “in medio stat virtus” del buon Aristotele, sapendo e volendo scegliere con coscienza quando è il caso di consegnarsi all’AI e quando no. Un’azione – questa sì metodica – volta a liberarsi dalla tentazione di mettersi sempre nelle sue mani perché ci si accorge che – talvolta o spesso – può non servire allo scopo, perché si percepisce che è più bello, godibile, esaudiente e perfino motivo di genuino orgoglio fare una cosa con la testa che si ha sul collo, perché si intuisce che il tempo non è un nemico da sconfiggere ma un potente alleato, perché si comprende che non è per forza necessario superare un limite ma ci si può accontentare di quanto concesso alla finitezza umana.
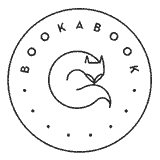


Commenti
Ancora non ci sono recensioni.