Il fatto che i serial killer vengano puntualmente descritti dai vicini di casa come uno che salutava sempre, non sta a significare che chiunque può trasformarsi in un assassino, ma che certe persone sono così rare da sfuggire completamente alla comprensione degli altri. Fu così per Igor Vitalyevich Savitsky, che fu scambiato per l’evaso di un manicomio, per un asceta travolto da un’allucinazione e per un fanatico divorato dalla sua ossessione.
Nacque nell’Impero Russo nel 1915, quando i valzer manierosi degli Zar furono travolti dagli inni rivoluzionari di Lenin. Si fece uomo in clandestinità, minacciato dal concerto per fucile e orchestra di Stalin e a quarant’anni si illuse che la bacchetta di Khrushchev avrebbe mutato la melodia sovietica in un radioso poema sinfonico. Da ragazzo studiò disegno di nascosto, senza capire la provenienza del denaro che i suoi genitori gli davano per le lezioni private più costose di Mosca. Grazie a una sospetta raccomandazione entrò all’università e diventò un pittore. Negli atelier dell’Arbat scoprì che il suo Paese era la superpotenza del cubismo, dell’astrattismo, del suprematismo e di tutti gli -ismi che compongono l’immaginifico mondo delle avanguardie. La Nazione del genio era però anche quella che impose il Realismo Socialista, una pittura-réclame tutta leader radiosi, inaugurazioni di fabbriche e working class heroes in tuta da ginnastica. I pittori si divisero in tre. Ci fu chi si sottomise all’ottimismo istupidente comandato dal regime. Ci fu chi emigrò, come Chagall e Kandinsky. E poi ci fu chi rimase e non si piegò, dipingendo le più stupefacenti meraviglie del Novecento. Se il mondo avesse visto i loro capolavori, non avrebbe dato importanza a Picasso, Klimt o Dalí. Nessuno però li ammirò, perché quegli intrepidi pagarono la loro libertà con la deportazione e con la perdita del permesso di soggiorno nella memoria degli uomini. I loro capolavori marcirono nelle cantine delle loro vedove e nei magazzini di Zagorsk, l’Auschwitz sovietico dell’arte libera.
Il solco che lasciarono nel mondo scomparve per tutti ma non per Igor Savitsky, che contrabbandò i loro quadri e li nascose alla fine del mondo. Lo fece come l’Oskar Schindler delle avanguardie sovietiche, lo fece con i soldi dello stesso regime che aveva tolto di mezzo i pittori, lo fece in modo così singolare che nessuno capì come ci riuscì né cosa lo muovesse. Non si può biasimare chi lo fraintese: lui soggiornò nel mondo come un violino che si suona tossendo, un notturno in chiave di sabbia, un fascio di note troppo acute per essere udite dall’orecchio umano. Se avesse scritto la canzone della sua anima su un pentagramma e l’avesse proposta a un discografico, questi gli avrebbe restituito lo spartito con un punto di domanda su ogni riga.
I pochissimi che ancora oggi si trovano dinanzi all’incredibile impresa che portò a compimento spalancano le braccia in quei gesti larghi e solenni che il direttore compie quando vuole che l’orchestra suoni la meraviglia. Il cosmopolita e l’introverso, il portuale e lo scacchista, il santo e il ruffiano, chi è nato stamattina e chi nascerà fra cent’anni. Tutti trasaliscono dinanzi all’impresa di Igor Vitalyevich Savitsky perché è la più stupefacente che sia mai stata compiuta da un uomo, a giudizio di tutti gli uomini.
IGOR
1
Il 9 maggio 1967 cominciò sciaguratamente per Venya, capotreno del rapido Mosca-Dushanbe. Quando lo sferragliare di una curva lo destò nella cabina di servizio, la sua mano si mise a setacciare il pavimento. Tastò una scarpa con i lacci annodati, la cintura agganciata ai pantaloni e la giacca da ferroviere: delle bottiglie di Stolichnaya Limonnaya non c’era traccia. Dopo essersi stiracchiato, alzò il busto con fatica e, reggendosi sui gomiti, tirò il cordino della luce da lettura. Merda, merda, merda, mi hanno rubato la vodka, pensò mentre la porta della cabina ondulava con lo sciabordio del vagone. Niente panico, alla prossima fermata mi fiondo alla bottiglieria della stazione, stabilì alzandosi in piedi. Quando sollevò la tenda del finestrino vide riflesso il suo volto sciupato, gli occhi grigi, la carnagione olivastra e i denti di metallo. Non appena mise a fuoco il paesaggio, la disperazione lo aggredì come un rugbista che salta su un avversario. Il cielo era una lastra di argento appannato e una distesa interminabile di sabbia copriva il pavimento del mondo fino all’orizzonte. Oh cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo, siamo già nel deserto… Altro che il chiosco della stazione… Maledetto Uzbekistan, maledetto Kazakistan, maledetto questo Karak, Karakà, Klaralkal, Karalkpà o come si chiama questo cazzo di -stan col suo deserto di merda, si disse mentre sentiva l’anima compressa dal legno di una matrioska sempre più piccola.
Venya trascorse la mattina tra le cabine a elemosinare cicchetti. Si scolò un bianchino, venti grammi di xeres e un po’ di porto. Mischiò il più possibile, ma all’ora di pranzo si sentì come un malato terminale che si è disfatto di un mal di gola. Dopo aver servito l’ennesima tazza di tè ai passeggeri, ripensò alle parole che un balordo gli aveva rivolto nell’androne di un palazzo di Leningrado. Prova il lucido, fa miracoli! Tornato nella cabina di servizio, prese un tubetto di lucido da scarpe, lo spalmò con l’indice su una fetta di pane e quando la mollica fu zuppa rimosse lo strato più brillante con un coltello. Che sia una sconfitta essersi ridotti a questo? si domandò fissando il pavimento, come se la risposta fosse nascosta nelle sfumature beige del laminato. In fondo no, non c’è mai sconfitta nel cuore di chi se ne fotte, concluse deglutendo il panino corvino. Quindici minuti dopo, Venya era acciambellato sul pavimento, rasserenato dalla pace che si trova in inverno nelle case vuote di villeggiatura.
Il treno aveva galoppato nel deserto per tutto il giorno e si stava avvicinando allo scalo di Khodzhely: un avamposto ferroviario tanto sperduto che pareva costruito per volere di un sindacato di dromedari. Ogni volta che i freni del Mosca-Dushanbe stridevano in mezzo al vuoto, i passeggeri si interrogavano sul perché esistesse una fermata in mezzo a un deserto. In molti immaginavano un burocrate ottuagenario carico di medaglie disegnare una X su una cartina e scrivere scalo: un gesto da ministero del tutto indifferente alle sorti di chi viaggia. Con la stessa logica si sarebbe potuto costruire un aeroporto in fondo all’Atlantico, una tramvia in cima a un grattacielo o una pompa di benzina in metropolitana. Per altro, quella fermata era in Karakalpakstan, una Zona Riservata in cui era vietato recarsi a meno di permessi speciali. Su una cosa sola erano tutti d’accordo: i due minuti di sosta erano una buona occasione per sgranchirsi le gambe e fumare una sigaretta.
La minuscola banchina di Khodzhely emerse dall’orizzonte circondata dal rossore del tramonto. Il marciapiede era coperto da una lingua di sabbia ma si distinguevano gli spigoli del casello ferroviario: un cubo di cemento fagocitato per metà da una duna. Sul tetto, Venya notò un ometto che marciava avanti e indietro come un lupo che si è appena risvegliato in una gabbia. La locomotiva si fermò col suo rumore di sfasciume, il ferroviere aprì lo sportello e lo vide precipitarsi verso di lui.
«Laisse-moi monter, camarade, je ne peux pas manquer le train pour Moscou» disse con voce uguale a quella di una donna magra.
«Chi? Cosa? Eh?» chiese il capotreno che percepì quelle parole come avvolte dalla nebbia.
«Ah, mon Dieu, scusi compagno, le parole sono uscite in francese. Volevo dire che devo salire al più presto sul treno» ripeté sulle spine.
Venya squadrò il suo interlocutore dalla testa ai piedi per capire quale tipo di allucinazione fosse prodotta dal lucido da scarpe. Il corpo di quell’uomo era così magro da sembrare la reliquia dell’umano che era stato. La fronte alta era solcata da rughe che parevano scavate a picconate da un minatore del Donbass e la carnagione gialla gli ricordò la mummia di Lenin. Le sue mani erano levigate come quelle di un pianista del Bolshoi e le sue pupille sprigionavano il bagliore che i ritrattisti di corte dipingono negli occhi del loro principe. Portava un’elegante giacca grigio scuro con una medaglia al valore appuntata al petto, una camicia ben stirata e una cravatta a righe. I pantaloni gli scendevano fino alle caviglie sottili come gambi di sedano e invece delle scarpe portava due pantofole di feltro grigio.
«Ma insomma, compagno, cosa aspetta lì impalato? Le ho detto che devo salire subito, s-a-l-i-r-e!» ribadì mettendo un piede sul predellino e afferrando il corrimano.
«Ma lei come si chiama?» domandò Venya intrigato dalle generalità di un’allucinazione.
«Igor Vitalyevich Savitsky» rispose intervallando nome e patronimico da una scarica di colpi di tosse simili a un martello pneumatico che frantuma l’asfalto.
«Bagaglio?»
«Solo questo» rispose indicando un giradischi Yunost a valigetta e muovendo la testa a destra e a sinistra per scrutare oltre la sagoma del capotreno.
«Ah, be’… mah… viaggia solo con un giradischi?» chiese mentre immaginò se stesso parlare col vuoto.
«J’ai des bagages sur le chemin du retour. Ehm, volevo dire che i bagagli li ho al ritorno. Ma che le importa dei miei bagagli!» lo incalzò mitragliando le parole.
«Senta, giusto per sapere. Non è che ha della vodka?» domandò Venya.
«Io non bevo: si levi!» gridò Igor tradendo l’impazienza di chi aveva aspettato tutta la vita per salire su quel treno. Approfittando dell’ottundimento di Venya gli sgusciò sotto al gomito e salì i gradini.
Un francese in pantofole nel deserto… Speriamo sia avanzato un po’ di lucido da scarpe, meditò il capotreno, certo che una persona così non potesse esistere né essere mai esistita.
Un’improvvisa raffica di vento inghiottì del tutto il piccolo casello ferroviario di Khodzhely. I passeggeri rimontarono in carrozza, mossi dall’angoscia di essere dimenticati laggiù ad annegare di spazio. Venya sbadigliò e il suo fischietto fece il trillo d’acciaio che avvertì lucertole, cammelli e scorpioni che il rapido Mosca-Dushanbe stava partendo.
2
Igor, che a modo suo esisteva, si immerse in un brodo sensoriale fatto dell’odore di stoffa, della condensa che appanna i vetri e delle luci a basso voltaggio. Non appena salito, in lui era montata l’angoscia di un esploratore polare con le provviste agli sgoccioli. Di fronte allo scompartimento numero nove, vide tre cuccette per lato con tre signore sulla sessantina che odoravano di sciroppo alla menta. Una nonnina velata guardava lo scorrere del deserto fuori dal finestrino e teneva sulle ginocchia una piccola borsa di tela. Accanto a lei sedeva una signora dai lineamenti uzbechi con la pelle paonazza e la terza babushka era una ucraina con i capelli sottili nascosti da un fazzoletto a fiori e un chotki in mano. Le tre donne esibivano la confidenza di tre amiche e parlavano a bassa voce. Igor entrò, le guardò negli occhi e si accomodò nella cuccetta di mezzo.
«Compagno, non si presenta?» domandò l’ucraina per seguire l’etichetta del treno, che prevede che ogni passeggero dica chi è, dov’è diretto e cominci un discorso che lascerà a metà.
«Mi chiamo Igor Vitalyevich Savitsky» rispose mangiando le parole per il senso opprimente di ansia che gli cresceva nel petto.
«E cosa ci fa in mezzo al deserto?»
«Lavoro in un museo a quattro ore di cammino da qui» spiegò puntando il dito affusolato verso due mulinelli di sabbia.
«Compagno, non si prenda gioco di tre anziane signore… Nei deserti non ci sono musei.»
«In questo sì.»
«Ma non è vietato venire qui?»
«Sì, il Karakalpakstan è una Zona Riservata. È perché non ci sono le strade e spesso nemmeno la corrente.»
«Chi ci viene in un museo in una Zona Riservata? E come fa a esserci un museo se non c’è la corrente?»
«Noi teniamo delle torce all’ingresso» rispose col tono del delirio lucido.
«Ah. E dove è diretto?»
«A Mosca. Sto andando a prendere dei quadri di inestimabile valore per il museo.»
«Quindi lei è una sorta di spedizioniere, o facchino?»
«No, Madame, io sono il direttore» disse col tono dell’usciere di un Grand Hotel.
«E perché è in pantofole?»
«Tre settimane fa mi sono ustionato un piede con dell’acqua bollente. Mi hanno comprato una crema, ma io l’ho scambiata con un tubetto di colla per il restauro dei vasi. Così invece di impomatarmi mi sono incollato il piede alla pantofola» disse alzando la caviglia sottile e indicando la calzatura di feltro. Le tre vecchine squadrarono il nuovo inquilino della cabina e, pur senza parlarsi, si convinsero che doveva essere come quegli squilibrati convinti di essere Kosygin, John Lennon o Popovich.
«Ha fame? O forse sete?» domandò la signora col chotki scuotendo una bottiglia bruna di porto.
«Aspetti che controllo» rispose Igor strizzando gli occhi e concentrandosi al massimo. Con grande sforzo fece comunicare il cervello con la lingua, la lingua con la gola e la gola con lo stomaco. Terminata l’assemblea dei suoi organi, emise il suo verdetto. «Sete no, fame sì.»
Le tre signore si guardarono impietosite e una tirò fuori dalla borsetta un grappolo d’uva zuccherina che gli allungò.
«Grazie, compagna. E le posate?»
«Le posate?»
«Per l’uva.»
«Ehm, sì, va bene» rispose lei aprendo una vaschetta con del pilav e porgendogli forchetta e coltello. Con la precisione di un chirurgo, Igor affondò la forchetta nell’acino per tenerlo fermo e ne incise la pelle con la punta del coltello, seguendo la sua rotondità verde. Poi infilò la lama sotto il lembo sollevato e, con un gesto esperto, fece scivolare la buccia traslucida in un nastro umido. Ripeté l’operazione con gli altri acini, disponendoli uno accanto all’altro come perle sbucciate. Sotto lo sguardo allibito delle babushke mangiò metà degli acini: il massimo per un uomo che non riusciva a conservare l’interesse per il cibo per più di qualche minuto. Subito dopo Igor si distese nella cuccetta girandosi sul fianco destro, poi sul sinistro, allungandosi, raggomitoladosi, coprendo gli occhi con l’avambraccio e spostando il giradischi sotto i piedi. Pareva che nessuna posizione potesse curarlo da un’angoscia che lo consumava come il verme che divora la polpa di una mela. Le vecchine non lo disturbarono, ma quando calò la notte lo videro alzare e abbassare le dita in un conto corredato da un farfugliamento senza fine: «Vingt-deux peintures et quarante-six dessins. Oui, oui, trois plus cinq plus trois plus onze font vraiment vingt-deux». Le compagne di viaggio non capirono quelle parole, ma percepirono la logica insolente di quegli incubi in cui si rincorrono i decimali di un numero periodico. Non appena Igor si voltò verso l’interno del vagone, una di loro guardò le altre e fece roteare l’indice vicino alle tempie, descrivendo con le labbra le parole “Scemo di un villaggio del deserto”. Le altre due annuirono e, in un tacito accordo, si ripromisero di dividere con lui i pirozhki con uova e cipolle, i cetrioli in salamoia e lo kvass che avevano portato per il viaggio.
3
Quella notte Igor non chiuse occhio, ossessionato com’era dalla misura di ventidue dipinti e quarantasei disegni e sconvolto da una tosse che gli feriva i bronchi come un arpione dalla punta spessa. Quando guardava l’orologio che segnava sempre la stessa ora, gli pareva che se lo avesse aperto avrebbe visto gli ingranaggi immobili.
All’alba, la steppa kazaka si mostrò in tutta la sua ampiezza, con le cunette ventose, i cespugli crespi e le ombre delle aquile che si proiettano sulla terra. Le cuccette si riempirono e si svuotarono in un tempo scandito dal crepitìo dei fiammiferi, dal tintinnio dei brindisi e dalle presentazioni di chi sale. Poi la notte tornò e al risveglio il finestrino si tinse dei riverberi biancoverdi dei boschi di betulle. Ogni passeggero che vedeva il corpo di Igor si improvvisava medico e diagnosticava mali che iniziavano per bronco, polmo o pneumo. In molti cercarono di parlargli ma i loro tentativi furono vani perché il campo di forze che definiva gli interessi di Igor era del tutto alieno a quello degli altri. Non gli importava dell’ottavo piano quinquennale, del razionamento del burro e del coraggio dei vietcong. Lui si interessava solo della tabella di marcia del viaggio e subissava il capotreno di domande: «Perché ci siamo fermati?», «Quanto ritardo abbiamo accumulato?», «Perché stiamo tornando indietro?». Venya rispose sempre in modo generico senza guardarlo negli occhi, intimorito dalla possibilità che le allucinazioni del lucido da scarpe sopravvivessero alla sbornia e perseguitassero eternamente i suoi sventurati consumatori.
In Unione Sovietica, il primo passeggero che vede la meta sorgere dall’orizzonte sobbalza in un grido, come se giungere a destinazione fosse un inimmaginabile colpo di scena. Accadde così anche la sera del 12 maggio 1967, quando una voce femminile urlò «Mosca!» tra la nebbia bluastra della campagna. Tutti gli scompartimenti allora echeggiarono «Mosca!», «Mosca!», «Mosca!». A quell’annuncio Igor si infervorò come un cane che sente il padrone sulle scale e andò in corridoio con la vecchina uzbeca per guardare la capitale in avvicinamento. L’umidità aveva steso una patina di condensa sui vetri e qualcuno aveva scritto col dito Alla fine del tunnel c’è un altro tunnel. La donna tirò la manica del maglione nel palmo e asciugò l’umidità svelando strisce orizzontali di città. Igor vide una nuvola simile a un polmone grigio appoggiata sulle guglie dei grattacieli, poi le ciminiere di mattoni e le cupole variopinte delle chiese. Quando il convoglio attraversò la Moscova, l’odore vischioso del carbone mise i vagoni in fermento. In corridoio, dietro alla porta del bagno, si formò una coda di viaggiatori con spazzolino e portasapone, intenzionati a sostituire i pigiami con abiti civili. I muri di cinta cominciarono ad alternarsi ai depositi e ai treni merce, mentre i binari si sdoppiarono continuamente come il delta di un fiume. Per le vecchine che l’avevano nutrito, Mosca era la città con gli ospedali migliori, con gli spacci più forniti e con biblioteche gigantesche. Per Igor a Mosca c’erano solo le sue vedove, fatte di carne e ricordi spezzati. Da quelle donne voleva una cosa molto precisa: che gli consegnassero i tesori proibiti del suo Paese.

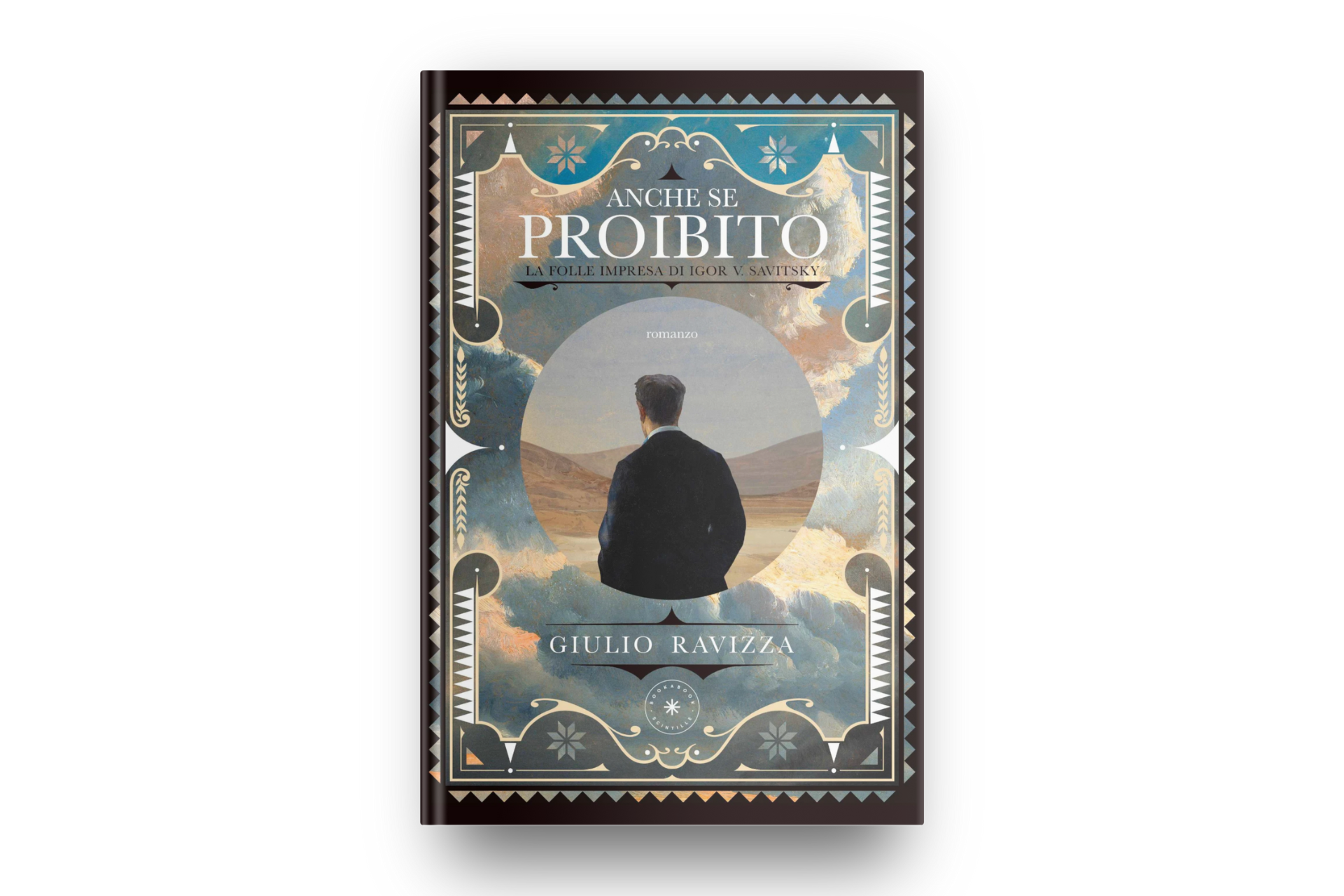



Commenti
Ancora non ci sono recensioni.