Lo “scoglio”, la base del presepe, era la stessa realizzata l’anno precedente da mio padre per partecipare alla gara scolastica di presepi nella scuola dove insegnava. La sua forma, fatta di gobbe, cavità, falsi altopiani, in cui immaginavamo una lontana Palestina, fin da allora martoriata, cambiava quindi annualmente, rendendo il paesaggio sempre diverso. Su una struttura di rete metallica, vi aveva appoggiato carta di giornale (conservata per giorni dopo le letture quotidiane) imbevuta di colla, composta da acqua e farina, e vi faceva sorgere montagne, grotte e pianure. Con trepidazione attendevo che giorno e notte trascorressero per vederlo nuovamente all’opera, una volta che la colla si fosse essiccata, per dipingere tutto a tempera, aggiungere sughero e legno, preparare il cielo stellato fatto di carta azzurra bucherellata da tante piccole lucine. Nel frattempo, con il cartone di scatole di chissà quali alimenti, venivano poi realizzate piccole casettine di varie dimensioni, le più piccole da collocare più lontano, insegnando, divertendo, a me ed ai suoi alunni, i principi della prospettiva con l’esempio concreto. Su questa struttura andava poi posto il muschio e realizzati, con attenzione e maestria, i simulacri dei sentieri, dei corsi d’acqua e dei boschi. Solo alla fine giungeva il momento di recuperare le statuine addormentate che avevano riposato per quasi un intero anno. Ogni statuina era una memoria scolpita nel tempo, un frammento d’eternità vestito di terracotta Allora iniziavano a snodarsi, insieme alla parvenza d’acqua ed a file di viandanti immobili, le storie di mia madre.
Quel tempo, composto da un inestricabile groviglio di realtà e fantasia, è fuggito inesorabilmente portando via quei presepi insieme a mio padre e poi a mia madre. Ma nel silenzio delle storie che non si raccontano più, sopravvive la voce di chi ha amato con parole semplici. Il tempo si curva quando la memoria si fa racconto, e il racconto si fa dono e quindi giunse il mio turno di sussurrare ai miei figli quelle storie d’amore che avevo scoperto, pian piano, essere emerse da testi sacri, da credenze popolari, da favole dimenticate, da testi ripudiati, da documenti storici, da paure recondite e profonde, ma soprattutto dal desiderio di insegnare e trasmettere l’amore. Ma il mio lavoro mi ha impedito di mantener vivo quel sogno. Così il desiderio di rinnovare la mia infanzia attraverso quella dei miei figli e di far loro rivivere quelle sensazioni di magica realtà di tanti anni fa non fu esaudito. Così anche quel tempo si è dissolto senza pietà ed è spietatamente andato via. Credo che sia stato proprio quel desiderio a spingermi verso una scelta nuova: quella di cercare di far rivivere quelle storie d’amore nei nuovi figli che le famiglie affidavano alle scuole che dirigevo: la realizzazione di presepi viventi scolastici, miracoli di sguardi incantati. Sapevo bene che alcuni avrebbero potuto storcere il naso, appellandosi alla laicità della Scuola pubblica, e criticare questa scelta, sottolineando che la Scuola dello Stato è laica. Tuttavia “laicità” è libertà, non negazione: non significa rifiuto delle religioni, ma piuttosto indipendenza, assenza di appartenenza a qualsiasi altra comunità che non sia quella scolastica, il cui scopo è esclusivamente insegnare a studiare. Se un presepe, con la sua forza simbolica, può aiutare i ragazzi ad imparare, ad accendere la meraviglia, lo lascio decidere al lettore di questi miei ricordi.
Se solo avessi potuto restare un anno ancora in quella scuola che ho amato come una casa, avremmo dato vita a un altro presepe. Avevo già scritto la descrizione dei personaggi, che lo rendono vivo, nonostante la loro fissità, studiandoli uno ad uno, ricordando un passato che indica il futuro. Personaggi narrati con una buona quantità di curiosità e notizie, spesso dimenticate o mai conosciute, soprattutto riguardo al presepe napoletano, per accendere nei ragazzi quella scintilla che si chiama fantasia. Perché la fantasia è l’unica via per mantenere viva la conoscenza. Un metodo che avrebbe permesso di risvegliare, in me, in loro e nelle rispettive famiglie, ricordi lontani di quella bellissima storia d’amore rappresentata nel presepe, che non. Presepe che non è mai solo rappresentazione, ma è un invito, una soglia aperta tra il cielo e la terra, una luce che filtra da una finestra socchiusa, risvegliando la meraviglia e l’amore.
Perché il presepe è prima di tutto questo: una storia d’amore. che narra di una rivoluzione silenziosa, quella di un Dio che non impone né punisce, ma scende tra noi, si fa uomo, si fa figlio per giungere ad una fratellanza universale che non ha eccezioni e non conosce discriminazioni. Un Dio che non ha una sua parte, un suo popolo, una sua comunità, ma è di tutti e per tutti. Un Dio che ama senza condizioni, che abbraccia tutti, nessuno escluso. Un Dio che è solo amore… oppure non è.
Il presepe è quindi la rappresentazione dell’amore. Di una storia d’amore. La storia affascinante di una donna, una madre, e la meraviglia della nascita, di ogni nascita. È la storia eterna di una madre e di un figlio, della fragilità che diventa forza. È anche la storia di un uomo che ama e rispetta la donna che avrà un figlio da un altro, proteggendola e tenendola con sé, sempre e comunque, salvando in tal modo la sua vita e quella del bambino. È la storia di un’umanità che si salva ancora, ogni volta che un bambino viene al mondo. È una storia di magia, perché l’amore è magia. E l’amore, alla fine, è ciò che tutti cercano, anche quando non sanno dirlo. Anche quando, per paura, si rinuncia a darlo e a riceverlo. Ma il presepe, silenziosamente, continua a raccontarlo.
Questo piccolo lavoretto, nato con l’intento di parlare ai ragazzi della mia ex scuola, è in realtà una carezza dedicata a mia madre. È pensato per i figli dei miei figli, e per chiunque senta il bisogno di scaldarsi ancora una volta al tepore di un amore puro: quello di una madre che dona tutto, senza aspettarsi nulla in cambio.
Questo testo presenta una parte iniziale di contestualizzazione dell’avvenimento base rappresentato nel presepe, illustrando curiosità e precisando fatti che a molti sfuggono. Cerco di spiegare, per esempio, perché Gesù non possa essere nato nell’anno zero o perché il Natale non è il 25 dicembre. Propongo un excursus tecnico su come si sia arrivati all’attuale calendario. La contestualizzazione vede anche la descrizione di quanto è inserito nell’ambiente presepiale, con particolare attenzione alla rappresentazione napoletana. Con l’aiuto dei vangeli apocrifi e delle tradizioni locali entro più nel dettaglio della magia del presepe e delle leggende che vi “prendono vita”. I personaggi citati dai vangeli canonici e apocrifi vengono analizzati con una certa profondità, sollevando il velo della consuetudine per tornare a sfiorare la magia svelandone la storia, rivelando leggende, riscoprendo meraviglie, immaginando scenari dove ogni statuina è un frammento di poesia per esaltarne la ricchezza simbolica. Infine è la volta di quei personaggi, anche anacronistici, che aggiungono incanto all’incanto, figure silenziose, con caratteri sconosciuti ai più, ma che sanno raccontare più di mille parole.
Non ho la pretesa di presentare uno studio accademico. Non sono storico, né teologo. Questo mio lavoro è, piuttosto, una narrazione affettuosa, una passeggiata tra i significati del presepe, popolato di esseri umani, creature fantastiche e simboli naturali, proprio come faceva mia madre accanto al camino: raccontando. Solo che, in questo racconto, ho voluto intrecciare memorie con spunti storici, artistici e letterari, riportando aneddoti, riflessioni e suggestioni… con la promessa di divagare il meno possibile.
La storia d’amore che ci accompagna comincia con un prodigio: la nascita di un bambino da una vergine. Se volessi lasciarmi trasportare dalla suggestione, potrei subito ricordare che lo stesso archetipo si ritrova anche in tante altre tradizioni. Da Zoroastro a Mitra, da Iside e Horus a Krishna e Devaki, da Buddha a Demetra e Persefone… la nascita miracolosa è un canto che l’umanità ha sempre amato intonare, in mille lingue diverse.
Ma non ci dilungheremo oltre. Per iniziare il nostro viaggio fantastico e immaginifico, preferisco affidare l’incipit a un poeta dell’antichità, che con profetica delicatezza annunciava una nuova età dell’oro, segnata dalla venuta di un bambino nato da una vergine: così scriveva Publio Virgilio Marone nella sua quarta egloga tratta dall’opera “Bucolĭca”, lasciando scivolare i versi nel mistero e nella speranza.
“Ùltima Cùmaeì
venìt iam càrminis aètas;
màgnus ab ìntegrò
saeculòrum nàscitur òrdo.
Iàm redit èt Virgò,
redeùnt Satùrnia règna,
iàm nova prògeniès
caelò demìttitur àlto.
Tù modo nàscentì
puerò, quo fèrrea prìmum
dèsinet àc totò
surgèt gens àurea mùndo,
càsta favè Lucìna:
tuùs iam règnat Apòllo.”
Che, trasposta con un respiro poetico, potrebbe suonare così: “È giunta a compimento l’ultima delle profezie della Sibilla Cumana. Dalle radici più remote del tempo, rifiorisce l’ordine originario dei secoli. Ritorna la Vergine, e con lei si ridestano i regni dorati di Saturno, mentre dai cieli profondi discende una stirpe nuova. Tu, Lucina, casta e benevola, veglia sul bimbo che nasce alla luce: per lui, per la prima volta, si placheranno le guerre tra fratelli, e tornerà a fiorire l’età dell’oro. Già il tuo Apollo risplende sul mondo che rinasce.”.
Lucina, antica divinità romana dal fascino etrusco, era la protettrice delle madri nel loro atto più sacro: il dare la vita. Il suo nome, colmo di dolcezza e presagio, significa “colei che porta alla luce”. Figura affine a Giunone e a Diana, incarna la soglia luminosa tra il mistero e la nascita.
Eppure, è poco probabile che Virgilio conoscesse le Scritture ebraiche o il messianismo biblico. Il suo richiamo alla “Vergine”, infatti, potrebbe non alludere a una donna, ma piuttosto alla costellazione celeste, simbolo di un tempo cosmico, di un ciclo eterno che si rinnova. Quanto al bambino, egli potrebbe rappresentare il figlio atteso da una dinastia potente: simbolo di speranza, promessa di un’era luminosa e rigeneratrice.
Ogni religione custodisce una culla: non sempre visibile, ma sempre colma di ciò che l’umanità ha di più sacro: la vita che rinasce. Ma non è necessario essere credenti per leggere queste pagine, anche quando non si crede, si può ascoltare il suono dell’amore che si rinnova nel racconto di una nascita.
LE BUONE NOTIZIE – fonti
Le fonti delle informazioni su Gesù che abbiamo a disposizione sono solamente gli “Evangelia”, dal greco εὐαγγέλιον , “buona novella” o “lieto annunzio”. Con il termine “Vangelo” si intende qualsiasi testo che parla della vita e delle opere di Gesù di Nazareth.
Fra tutti i testi evangelici, solo quattro, risalenti alla fine del I e all’inizio del II secolo dopo Cristo, furono considerati, fin dalle prime comunità cristiane, come “canonici”. Il loro status ufficiale di “scritture sacre” fu sancito nel “Primo decreto” degli “Acta” del Concilium Tridentinum (1545-1563). Tra questi, il Vangelo secondo Giovanni si distingue per stile e contenuti dagli altri tre di Matteo, Marco e Luca, che sono detti “sinottici” in quanto così simili fra loro da poter essere pubblicati in sinossi a colonne affiancate. Tuttavia, fra i testi canonici, solo quelli di Luca e Matteo offrono cenni della Natività, e lo fanno in appena 180 versetti. Matteo, ebreo, scrisse per un pubblico ebraico; Luca, pagano, si rivolse ai gentili dell’Oriente. Questo spiega la differenza fra i personaggi che, secondo i due autori, visitano il neonato Gesù: Luca parla di pastori, mentre Matteo cita i magi.
I brani originali e le traduzioni utilizzate nel testo provengono dal sito www.maranatha.it.
Accanto ai Vangeli canonici, esiste un universo affascinante di testi “apocrifi”, termine che, dal greco ἀπόκρυϕος significa “nascosto”, “segreto”, esclusi dal canone perché dalla Chiesa non ritenuti ispirati. In sé il termine “apocrifo” non significa “falso” e solo a partire dal V secolo d.C. ha assunto l’accezione negativa che ha ancora oggi. Gli apocrifi sono spesso una miscela di elementi miracolosi e simbolici e, pur espunti fin da prima del X secolo d.C. dai testi canonici, fecero in tempo ad arricchire il racconto evangelico, lasciando una profonda impronta nella tradizione, nella letteratura e nell’iconografia cristiana, tanto che moltissime informazioni, in essi contenute, sono ormai integrate pienamente nelle tradizioni cristiana e islamica, contribuendo, fra l’altro, a delineare l’immaginario poetico e mistico della notte di Natale.
Come fonte del nostro racconto, oltre ai testi di Luca e Matteo, è certamente da citare il più antico fra gli apocrifi, il “Protovangelo di Giacomo”, un testo risalente alla seconda metà del II secolo d.C. e diffuso nella Chiesa d’Oriente nelle versioni greca, siriaca, copta, saidica, araba, armena, etiopica e in qualche dialetto slavo, ma poco conosciuto o assente dalle liturgie della Chiesa d’Occidente. Sebbene attribuito a Giacomo il Giusto, fratello di Gesù, l’autore non può essere lui, essendo morto nel 62. Da questo testo, però, apprendiamo i nomi dei genitori di Maria: Anna e Gioacchino, figure che, nel racconto, si stagliano tra dolore e speranza, in una narrazione che sfiora la poesia.
Ricco di altri dettagli è il “Vangelo dello Pseudo-Matteo”, giuntoci in un testo datato tra il VII e l’VIII secolo, ma probabilmente già noto fin dalla fine del IV secolo, dal quale hanno attinto ampiamente altri successivi vangeli apocrifi.
Dettagli che sono ampliati, anche con modifiche, dai successivi “Vangelo dell’infanzia” e dai “Vangeli dell’infanzia di tradizione armena e araba”, scritti tra il VI e l’VIII secolo. In esso troviamo episodi suggestivi, come la palma che si piega per offrire datteri a Maria nel deserto: un’immagine che riecheggia anche nel “Corano”, nella Sura XIX, a testimonianza di un dialogo culturale e spirituale ancora da esplorare.
I brani tratti da questi testi apocrifi provengono dalla raccolta “Vangeli apocrifi” di padre Giuseppe Bonaccorsi.
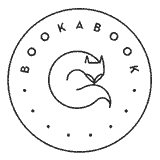



Commenti
Ancora non ci sono recensioni.