Senza le approfondite letture dei libri di Terzani, pazzo a suo modo per la vita straordinaria vissuta, non avrei saputo interpretare al meglio neanche il gioco del calcio che, ad un’analisi scrupolosa, non è soltanto un gioco in virtù delle sue implicazioni sociali e per la propria, controversa ma indiscussa, valenza culturale e le sue relazioni con i fatti della mia vita. Durante tutta la mia esistenza vissuta fino a questo momento, me ne rendo conto solo ora che ho compiuto e superato il classico giro di boa dei cinquant’anni, ho pensato, parlato e scritto tanto riguardo ai miei pensieri occasionali, soprattutto da quando, ormai un bel po’ di anni orsono, con l’avvento e la diffusione di massa delle cosiddette reti sociali, tutti abbiamo avuto la possibilità di poter esprimere le nostre opinioni nel vasto mare cibernetico di Internet. Non ho, però, mai scritto un libro. In fondo – mi sono spesso detto – sono sempre di più coloro che scrivono libri, aiutati anche da una certa facilità di pubblicazione che era impossibile in passato, ma pochi invece che li leggono. Ho sempre sentito forte il mio senso di appartenenza alla categoria dei lettori piuttosto che a quella degli scrittori.
Il calcio, poi, lo abbandonai tanti anni fa con sdegno e repulsione: non riuscivo più a leggervi nessuna poesia, nessuna vera passione. Mi sembrava – e mi sembra anche adesso, è inutile nasconderlo – solo un prodotto di mercato, una macchina da soldi, un noioso e ripetitivo varietà da salotto televisivo piuttosto che lo sport proletario per eccellenza quale me lo ero sempre immaginato.
Dunque, se una buona occasione si presenta sempre nella vita, la mia è stata la nascita di mia figlia a un’età, quarant’anni, in cui pensavo che nel mio destino fosse scaduto il tempo per vivere quella bella condizione del diventare genitore, così ordinaria nella visione generale delle cose ma straordinaria e unica quando accade la grazia di viverla.
Un po’ per caso, un po’ per forza e un po’ per amore, con mia figlia siamo finiti a vedere alcune partite di calcio negli stadi, tra le bandiere sventolanti, i cori eccitati, il rumore rimbombante dei tamburi e l’odore aspro e acre dei pochi fumogeni che ancora riescono a passare i controlli sempre più serrati delle forze dell’ordine, in impianti tecnologici sempre più disumanizzanti, tra tornelli, controlli identitari e codici a barre da scannerizzare.
Il fatto che per mia figlia la passione calcistica non sia mai effettivamente esplosa ma, al contrario, si sia affievolita quasi subito, non ha avuto per me nessuna rilevanza: la scintilla in grado di riaccendere e ravvivare un fuoco sopito da troppi anni era nuovamente scoccata.
Come l’incontro inaspettato con un’amante perduta da tempo, tutte le emozioni e le sensazioni relegate e dimenticate nei complicati e tortuosi labirinti dei ricordi sono tornate alla luce con il loro carico di energia e vigore.
Questa, quindi, non è stata solo la mia buona occasione per scrivere finalmente un libro ma è stata anche l’opportunità per tornare ad interessarmi e parlare di calcio, lo sport più popolare al mondo, di come esso si sia trasformato nell’epoca del materialismo dilagante e di quali emozioni può ancora, nonostante tutto, suscitare nelle persone. 1
Il poster del Milan faceva bella mostra di sé attaccato alla parete della mia cameretta. Era come un raggio di luce che catturava la mia attenzione in una stanza sobria e spoglia di colori. Era il Milan della stagione calcistica 1979-1980.
Le facce di quei calciatori avevano occhi penetranti e ipnotici che sembravano fissarmi intensamente mentre, sdraiato nel mio letto di bambino, passavo le ore affascinato a guardare e riguardare quel manifesto in carta lucida, ad ammirare incantato quei volti baffuti da fine anni Settanta, quegli sguardi baldanzosi e fieri, quei visi guerrieri da gladiatori moderni così diversi dai calciatori di oggi, tutti conformi al culto dell’immagine che li vuole inevitabilmente belli, doverosamente tatuati, coi muscoli scolpiti e le pose da stelle del cinema eseguite per essere poi imbalsamate nelle foto da postare sulle reti sociali. La maglia poi era meravigliosa: semplici e sottili righe rosse e nere verticali, senza fronzoli, senza orpelli, con l’unico scopo di rispettare i colori sociali e l’identità di una squadra e della propria tifoseria anziché quello di genuflettersi alle esigenze di mercato e del cosiddetto merchandising che impone di avere molteplici maglie diverse a stagione, spesso con colori diversi da quelli sociali tradizionali al fine di alimentare la molteplicità dei prodotti dei punti vendita, degli store, come si usa dire oggi utilizzando inutili e sterili inglesismi, che ogni società calcistica di alto livello ormai possiede.
Il portiere di quella squadra era Ricky Albertosi e si distingueva da tutti gli altri per la maglia di un giallo acceso, pieno di vita e di energia. Lui, tra tutti i protagonisti di quella foto, mi affascinava in maniera particolare: aveva una posizione marziale e l’atteggiamento da ceffo; avrebbe potuto interpretare il personaggio di Giulio Sacchi, violento, crudele e sadico protagonista nel film Milano odia, la polizia non può sparare del 1974 appartenente al genere poliziesco che le produzioni italiane negli anni Settanta sapevano fare con grande maestria e successo. All’epoca ancora non lo sapevo, ma da lì a poco Albertosi finirà davvero in prigione, anche se solo per un paio di settimane, per quella drammatica vicenda del calcioscommesse che scosse dalle fondamenta tutto il sistema calcio coinvolgendo pure Paolo Rossi, il ragazzo di Prato che solo pochi anni dopo, tornato a nuova vita sportiva dopo la squalifica, ci fece vincere quell’avvincente e indimenticabile mondiale in terra di Spagna. Anche allora il mondo dell’Italia pallonara evidentemente non era immune dagli intrighi economici e dalle truffe.
Il mio rapporto col calcio, dunque, iniziò proprio così, con quella grande foto affissa alla parete.
Ma cosa ci faceva il poster del Milan sul muro della mia cameretta se tutti coloro che mi conoscono da sempre, famigliari, amici, ex compagni di scuola, sarebbero pronti a giurare solennemente che da piccolo ero stato tifoso della Juventus?
Come ci era finito quel poster appeso sulla parete della casa dove abitavo da bambino?
Il piccolo negozio di alimentari era posto sotto il piano stradale; vi si accedeva scendendo due scalini di marmo. Era uno dei quattro negozi di generi alimentari di quel piccolo paese situato sulle colline di Maremma dove vivevo. Sul finire degli anni Settanta del secolo scorso quel modesto borgo di poche case incastonato e nascosto in una sorta di valle circondata dai colli verdi di prosperosa vegetazione mediterranea poteva ancora permettersi il lusso di ospitare ben quattro negozi di generi alimentari, due macellerie, una tabaccheria e due empori dove chiunque poteva trovare qualsiasi cosa di cui potesse aver bisogno. Tutto questo accadeva prima della diffusione dei supermercati, della grande distribuzione e dei centri commerciali che con la loro potenza di fuoco hanno portato alla quasi totale scomparsa quei piccoli luoghi di socialità e di incontro di un’umanità che non andava a fare la spesa col carrello.
In quella strana mattina dell’anno qualunque 1979 scesi quei due scalini in marmo del negozio di generi alimentari del mio paese mano nella mano alla mia mamma.
Il mio babbo non c’era più!
Pochi mesi prima accadde infatti che non tornò a casa.
Prima c’era e poi non c’era più!
Questa è l’estrema, cruda e schietta sintesi di come un bambino di sei anni da poco compiuti quale ero riuscì a elaborare la morte del proprio genitore. Non soffrii, non piansi e non feci domande; l’evento fu troppo grande per essere affrontato in solitudine. Semplicemente chiusi con decisione e fermezza la saracinesca delle emozioni e feci finta di niente.
Rimanere indifferente a quel vuoto inaspettato e a quella sensazione di abbandono fu come mettersi una sorta di corazza difensiva. Così come il corpo, come estrema difesa di sé stesso quando è sottoposto a un lacerante e insopportabile dolore fisico, perde i sensi o muore, così io decisi inconsciamente di sopprimere la consapevolezza delle emozioni per non dovere fare i conti con quella inedita esperienza. Crescendo, quando il dolore che per anni era stato solo messo in castigo e reso silenzioso ruppe gli argini e tracimò all’esterno con l’energia e la violenza di un’onda che tutto travolge, sono stato ingeneroso e poco riconoscente, questo lo riconosco, nei confronti della mia mamma, degli zii, dei parenti vari, criticandoli eccessivamente per non avermi coinvolto in quella sofferenza, per non aver trovato le parole, semplici ma sincere per spiegarmi cosa stesse accadendo. Tutti agirono con le migliori e nobili intenzioni in una situazione difficilissima, con l’unico scopo di proteggermi, in cui ognuno non sapeva bene cosa fare.
Eppure, proprio in quel far finta di niente, in quel non dirmi niente, in quel fingere di essere normali in un evento tragico e devastante che normale non era, ci fu un grande errore di gestione delle emozioni. Avvertivo infatti che qualcosa di grave era accaduto, vedevo che il mio babbo non c’era più ma ancora non sapevo cosa fosse la morte, non riuscivo a elaborare spiegazioni dentro di me, non potevo usare parole che ancora non possedevo per chiedere conto a qualcuno. Chiudersi a riccio e far finta di niente diventò quindi l’unico rifugio possibile fino a quando, crescendo, non fui costretto, con grande ritardo, a mettere mano, volente o nolente, a ciò che in passato avevo necessariamente dovuto relegare all’angolo.
Il mio babbo era un uomo di un’epoca diversa. Quando nacqui, si limitò ad accompagnare la mamma in ospedale alle prime doglie, tornando solo dopo che io ero già venuto al mondo. Non si occupò mai di me come fanno molti padri di oggi: non mi cambiò i pannolini, non mi portò a spasso nel passeggino, non mi accompagnò al parco né assistette alle mie prime recite alla scuola dell’infanzia. Non era disinteresse o mancanza d’amore; semplicemente, negli anni Settanta, in quel piccolo paese di Maremma, le cose andavano così: la cura dei neonati e dei bambini piccoli era un compito che spettava alla mamma.
A sei anni, poche settimane prima che lui morisse, avevo appena iniziato le elementari.
In paese era in programma una grande festa, la sagra del cinghiale, preceduta da una battuta di caccia. Quel giorno, babbo mi portò con sé, insieme agli altri cacciatori. Era l’inizio di una stagione della vita in cui avremmo potuto condividere tante esperienze. Per me fu una giornata indimenticabile, che ancora oggi ricordo con immenso affetto. La descrissi, con la mia scrittura incerta e un vocabolario semplice, sul quaderno di scuola. La maestra Gina ci scrisse sopra un bel ‘bravissimo’, e la mamma lo ha sempre custodito con cura e una punta di emozione.
Non ci furono più altre occasioni per condividere esperienze insieme. Mi sono spesso chiesto chi sarei diventato se avessi avuto accanto una guida salda, ma il destino segue sentieri misteriosi e imperscrutabili. Di una cosa, però, sono certo: tutte le emozioni represse legate a quel lutto esplosero con l’arrivo dell’adolescenza. E non fu solo un modo di dire. In quel periodo iniziarono a comparirmi le prime forme di acne, che la mamma liquidò come un normale effetto degli ormoni, senza darci troppo peso. Ma la situazione peggiorò rapidamente: quello che sembrava un semplice problema di pelle si trasformò in una serie di noduli, anche grossi, che mi deturparono il viso.
Mentre i miei coetanei scoprivano i primi amori, i primi baci, i momenti magici di un’età che dovrebbe essere sinonimo di bellezza, libertà e spensieratezza, io mi sentivo un mostro. Mi vedevo sbagliato, fuori posto, indegno di essere amato. La mamma mi portò da vari specialisti, che mi prescrissero creme, antibiotici e trattamenti di ogni tipo, fino a un ricovero di una settimana nel reparto di dermatologia dell’Ospedale Santa Maria Nuova a Firenze. Rimasi lì da solo, perché lei, dovendo lavorare, non poté restare con me.
Fu durante quel soggiorno che accadde qualcosa che rafforzò ancora di più la mia sensazione di essere un errore, un’anomalia. Appena arrivato, dopo che i medici ebbero esaminato la mia cartella clinica e osservato il mio viso, mi fecero percorrere un lungo corridoio fino a una piccola stanza. Mi fecero sedere su una sedia di metallo con la seduta di formica blu scuro. Poi arrivarono degli specializzandi: i dottori spiegarono loro, davanti a me, quello che consideravano il mio problema dermatologico. Poco dopo giunse un fotografo, che immortalò ogni dettaglio di quelle protuberanze sul mio viso. Ho sempre immaginato che quelle foto fossero destinate a libri universitari o a presentazioni durante convegni medici.
Seduto su quella sedia, circondato da persone che scrutavano le parti di me che ritenevano interessanti, mi sentivo come un insetto intrappolato su un vetrino sotto un microscopio. Loro vedevano solo ciò che serviva al loro studio, ma io, come persona, dov’ero? Che ruolo avevo in tutto questo?
Quei medici, a modo loro, furono bravi. Con le loro cure, i miei problemi sembravano svanire, ma era solo un’illusione temporanea: dopo poco, tutto tornava, in un ciclo doloroso che mi accompagnò per tutta l’adolescenza. Loro, però, si concentravano solo sui sintomi, sulle protuberanze, e lavoravano su quelle. Nessuno – né i medici, né la mamma, né gli zii, né le persone intorno a me – si fermavano mai a chiedermi: ‘Massimo, come stai davvero? Mettiamo da parte la scuola che non va, gli antibiotici, le creme all’acido azelaico (che un bravo farmacista di Piazza del Porcellino a Firenze preparava apposta per me.) Proviamo a capire cos’è questo fuoco che brucia dentro di te e che, in qualche modo, sta cercando una strada per emergere.’
Fu solo con i primi passi nella giovinezza, quando l’adolescenza cominciava a dissolversi, che iniziai, con molta fatica e inciampando ancora tante volte, a riflettere sul mio ruolo in tutto quello che mi stava accadendo. Lentamente, tra altri errori e cadute, cominciai a sentirmi parte attiva della mia vita, non più come una mosca nera intrappolata sul vetrino dell’entomologo, sotto lo sguardo freddo di un microscopio.
Massimo, di che squadra sei? – mi chiese Laura, la sorridente titolare del negozio di alimentari. “Di che squadra sei?” è il modo tutto maremmano per chiedere per quale squadra di calcio una persona faccia il tifo, a quale squadra “tenga” come si dice da altre parti d’Italia. La domanda mi colse alla sprovvista e mi lasciò per un attimo interdetto perché fino a quel momento non ci avevo mai pensato. Di calcio non ne sapevo ancora niente e nessuno me ne aveva mai parlato. La mia mamma era completamente disinteressata a questo sport; il mio babbo invece, mi dissero in seguito coloro che lo avevano conosciuto meglio di quanto fosse stato possibile a me, era tifoso delle Fiorentina ma dai racconti che mi furono fatti riguardo alla sua vita capii che esprimeva un tifo blando, superficiale, privo di reale passione e interesse. Probabilmente, essere della Fiorentina era più una sorta di atto dovuto, convenzionale, un suo modo per dire di avere come tutti una squadra da tifare anche se vincere o perdere non gli produceva nessuna vera emozione. Il suo reale interesse, ciò che accendeva in lui una passione autentica, era la caccia e la caccia al cinghiale in particolare. I ricordi che possiedo di quelle poche esperienze vissute insieme a lui prima che lasciasse qua il suo corpo, sono tutti legati all’attività venatoria: andare a portare da mangiare ai cani, accudirli in casa quando accadeva che venissero colpiti dai cinghiali feriti e sanguinanti, e quindi diventati per necessità violenti, guardare mamma togliere le penne, una ad una, agli uccellini morti messi in fila sul tavolo da cucina, saltare un sabato di scuola nei primi giorni della prima elementare per seguirlo alla grande battuta di caccia per la sagra del cinghiale che si sarebbe svolta in paese il fine settimana successivo. E poi il profumo di bosco che usciva dalla “ladra”, la tasca orizzontale posta sul dorso del giaccone verde oliva che indossava in inverno e nella quale riponeva le piccole prede catturate con le tagliole, le trappole che in Maremma si usano per catturare gli uccellini. Sono questi i ricordi più vividi e autentici del mio rapporto con il mio babbo in quei soli sei anni di vita vissuti insieme. Proprio quella passione per l’attività venatoria fu la causa della sua prematura morte avvenuta per mezzo di un colpo di fucile sparato per errore da un suo compagno di caccia. Il calcio per quel me bambino non esisteva in quell’orizzonte e alla domanda di Laura, di quale squadra fossi, non riuscii a dare una pronta risposta. Ci pensai un po’ e poi, forse perché vagamente avevo sentito qualcuno nominare le più famose squadre di calcio italiane, ne dissi una a caso, la prima che mi venne in mente: il Milan! Laura, scegliendo con attenzione da un grosso rotolo di poster, tirò fuori proprio quello del Milan e me lo consegnò sorridendo.
Non ricordo perché in quel negozio di alimentari si distribuissero i poster delle squadre di calcio. L’idea che mi sono fatto dopo, ripensandoci, è che fosse stata una sorta di strategia di vendita di qualche marchio che agganciava un regalo all’acquisto di qualche prodotto. L’unica certezza che ho è che, quando mamma ebbe finito di fare la spesa, risalimmo i due scalini, accedemmo nuovamente alla strada soleggiata e tornammo a casa. Mamma probabilmente immersa nei suoi tristi e solitari pensieri mentre io tutto sommato contento di tenere in mano il poster arrotolato di una squadra di calcio come se fosse una reliquia preziosa ricevuta in dono. Nonostante tutto ciò, la mia vita da tifoso non presa mai la via di Milano e non si tinse mai di rossonero. Diventai invece tifoso della Juventus e in molti, leggendo la frase che ho appena scritto, saranno indotti a pensare che questo accadde perché, come spesso succede per quelle inevitabili dinamiche umane, era la squadra più forte e prestigiosa a cui da bambini è più facile legarsi. In realtà non andò proprio così. Come divenni tifoso della Juventus è una storia curiosa, una piccola storia ma che in sé contiene una storia molto più grande e che merita di essere raccontata.
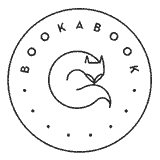
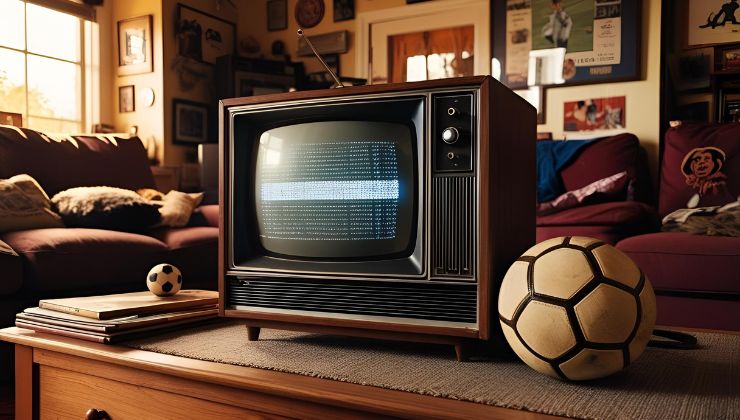


Commenti
Ancora non ci sono recensioni.