Nella visione comune e collettiva, il termine punk indica quindi un’estetica fatta di creste colorate, piercing, spille, jeans strappati e giacche in pelle ricoperte di borchie. Un aspetto che si trova ad accompagnare una musica aggressiva, fatta di suoni elettrici e taglienti, al quale spesso si attribuisce erroneamente un’ideologia politica vicina all’estrema destra.
A livello musicale, il punk rock sembra voler “distruggere il rock’n’roll, depurandolo dai ritmi della black music, fino a lasciare solo rumore e struttura”.
Rappresenta un ritorno alla semplicità del rock delle origini, in controtendenza rispetto alla crescente complessità delle melodie: un rumore ricercato più o meno consapevolmente, in contrasto con i suoni ricercati del post rock, in cui volume e distorsione massime sono ostentati come armi.
La sua nascita viene convenzionalmente fissata nel 1976, ma si trovano diversi precursori sin dagli anni Sessanta, in particolare nel genere denominato garage rock e in gruppi statunitensi come i Kingsmen, i Kinks e gli Who, in cui già si sente la ferocia musicale e la ribellione che caratterizzerà il primo punk britannico, di cui Sex Pistols e Clash saranno poi i massimi esponenti. A queste band si deve riconoscere l’introduzione di sonorità molto vicine al rock sperimentale e una tecnica musicale di alto livello, ma un’influenza altrettanto forte si trova nei Velvet Underground (attivi fino al 1973), le cui sonorità sporcate dal rumore bianco e gli effetti di feedback avranno un forte riverbero sulla prima generazione di punk. D’altro canto, è certamente agli Strooges (sciolti nel 1974) e al loro leader Iggy Pop che va attribuito l’eclettismo, la trasgressione e i comportamenti autodistruttivi delle esibizioni che caratterizzeranno i live punk rock: la musica degli Strooges è più veloce e aggressiva, basata su chitarre distorte, riff e linee di basso semplici, batteria pesante. I loro concerti sono i primi a rivedere i confini fra pubblico e musicisti. Saranno dei loro fan a fondare, a New York, i Ramones, uno dei gruppi che più si distinguerà anche oltreoceano. La scena underground mondiale (soprattutto quella di New York, Los Angeles e Londra) assisterà da qui a un uragano pronto a stravolgere il mondo della cultura giovanile e l’industria musicale. I gruppi newyorkesi fanno una musica grezza e sporca, ma sono fondamentali nella creazione dell’estetica punk; essenziale per il suo diffondersi sono i live del CBGB, un locale sito a Manhattan attorno a cui, in breve tempo, si trova a orbitare tutta la scena underground. Al CBGB suonano, fra gli altri, Patti Smith, Blondie, Ramones, Talking Heads e Television, al cui bassista (Richard Hell) è attribuito il lancio di quella che diventerà la moda punk: giubbotti di pelle, magliette e jeans strappati, capelli corti con la cresta da mohicano. Se qualcosa accomuna questi primi musicisti punk, è la differenza che avevano gli uni con gli altri: basti pensare al rock poetico e recitativo di Patti Smith in relazione all’estetica e al sound da motociclisti dei Ramones.
Le caratteristiche del genere, nato sulla East Coast, vengono amplificate alcuni anni dopo, quando giungeranno a Los Angeles: suono più duro, immaginario più aggressivo, testi più politicizzati. La città degli angeli vede nascere band come i Germs, i Circle Jerks, gli Weirdos e i Dickies, che portano all’evoluzione dell’hardcore punk e, a partire dagli anni Novanta, permettono la riemersione del genere, dando vita a un vero e proprio revival, tramite il quale si diffondono sottogeneri come il pop punk, lo skate punk e il melodic hardcore punk.
Ma la trasgressione dell’onda punk non si ferma nel nuovo continente: già dagli anni Settanta approda nel Regno Unito, stravolgendo la compostezza e il buoncostume di un paese che a stento aveva digerito il rock degli anni Sessanta e tutte le mode che ne erano derivate.
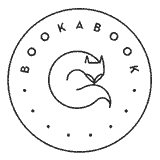






Commenti
Ancora non ci sono recensioni.