Eppure, oggi, chi cammina in montagna rischia spesso di perdersi proprio questo: la vita della montagna, il suo respiro lento e profondo. Ci lasciamo trascinare dal ritmo frenetico della quotidianità, anche quando siamo in natura: guardiamo l’orologio, pensiamo alla meta, seguiamo una traccia GPS senza fermarci a osservare davvero ciò che ci circonda. Ma la montagna non si scopre di fretta.
Rallentare è un atto di rispetto. Per il paesaggio, per chi in quei luoghi ha vissuto e lavorato, per la natura stessa. È fermarsi a sentire il vento tra le cime degli abeti, osservare il volo di un gheppio sopra una cresta rocciosa, riconoscere l’odore di terra umida dopo un temporale. È accorgersi che su un vecchio tabià è ancora incisa una data, il segno di una storia passata. È sedersi su un prato senza fretta, lasciando che il tempo della montagna diventi anche il nostro.
Questo capitolo è un invito a vivere la montagna con occhi nuovi. A non essere solo escursionisti, ma viaggiatori del tempo e dello spazio alpino. Perché la montagna è viva e ci parla, basta solo imparare ad ascoltarla.
La lingua ladina: un’eredità da ascoltare
La lingua ladina è molto più di un semplice idioma: è una testimonianza vivente della storia delle Dolomiti, un legame invisibile tra le generazioni che hanno abitato queste montagne. Affonda le sue radici nel latino volgare parlato dai Romani e si è evoluta nei secoli, resistendo alla frammentazione politica e all’influenza delle lingue dominanti – italiano, tedesco, veneto. Oggi il ladino è parlato in alcune vallate dolomitiche, come la Val Badia, la Val Gardena, la Val di Fassa, Livinallongo con Colle Santa Lucia (in ladino, Fodóm) e Ampezzo, e sopravvive grazie alla determinazione di chi continua a trasmetterlo.
Questa lingua è lo specchio del territorio in cui è nata. Le sue parole raccontano di neve, boschi, pascoli e rocce, e si adattano al paesaggio, lo descrivono con precisione e rispetto. Nelle parole ladine c’è la memoria di un modo di vivere la montagna che oggi rischia di scomparire, ma che possiamo ancora riscoprire se impariamo ad ascoltarle.
Ci sono parole che esistono solo in ladino perché rispondono a un bisogno specifico della vita in montagna, a una realtà che altrove non ha lo stesso peso. Conoscerle significa entrare in sintonia con il territorio e con chi lo abita da secoli.
Ecco alcuni esempi:
Jì a crëpe: andare a rocce. Non significa solo scalare, ma anche muoversi in un ambiente dove la montagna si fa più aspra e il bosco lascia spazio alla pietra e alla vastità. È un’espressione che distingue chi vive la montagna non solo come meta escursionistica, ma anche come parte della propria quotidianità.
Canton: un angolo nascosto, spesso tra le case di un paese. Ogni borgo ladino ha i suoi cantons, luoghi silenziosi dove il tempo sembra essersi fermato. Saperli riconoscere significa entrare nel cuore autentico di un villaggio alpino.
Sfarinoza/zisena: neve farinosa, asciutta, perfetta per camminare o sciare. Per chi vive in montagna, la neve non è solo “neve”: ha consistenze, suoni e significati diversi a seconda delle condizioni climatiche. Riconoscere la sfarinoza/zisena significa capire come la montagna cambia con le stagioni. C’è anche la neve compatta sulla quale si cammina senza sprofondare. In ladino tale azione si definisce jì a tolech e automaticamente con tale locuzione si comprende il tipo di neve che si intende.
Ogni lingua ci offre una prospettiva unica sul mondo, e il ladino è la chiave per vedere le Dolomiti con occhi diversi. In un’epoca in cui tutto sembra omologarsi, conoscere e usare queste parole significa preservare un’identità culturale e mantenere vivo un legame con la montagna che va oltre l’escursionismo.
La prossima volta che camminate tra le Dolomiti, provate a fermarvi e a chiedervi: cosa mi racconta questo paesaggio?
Forse in una vecchia baita annerita dal sole ritroverete un canton nascosto che porterete con voi come un bellissimo ricordo personale. Forse vedrete il confine tra il bosco e la roccia e da lì salendo verso la cima capirete cosa significa jì a crëpe. Forse, un giorno d’inverno, sentirete sotto i vostri passi la neve che scricchiola e saprete che quella è sfarinoza/zisena.
Ascoltare la lingua di un luogo significa ascoltare la sua anima. La montagna parla, e il ladino è ancora la sua voce più autentica.
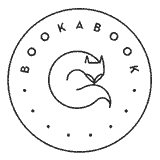
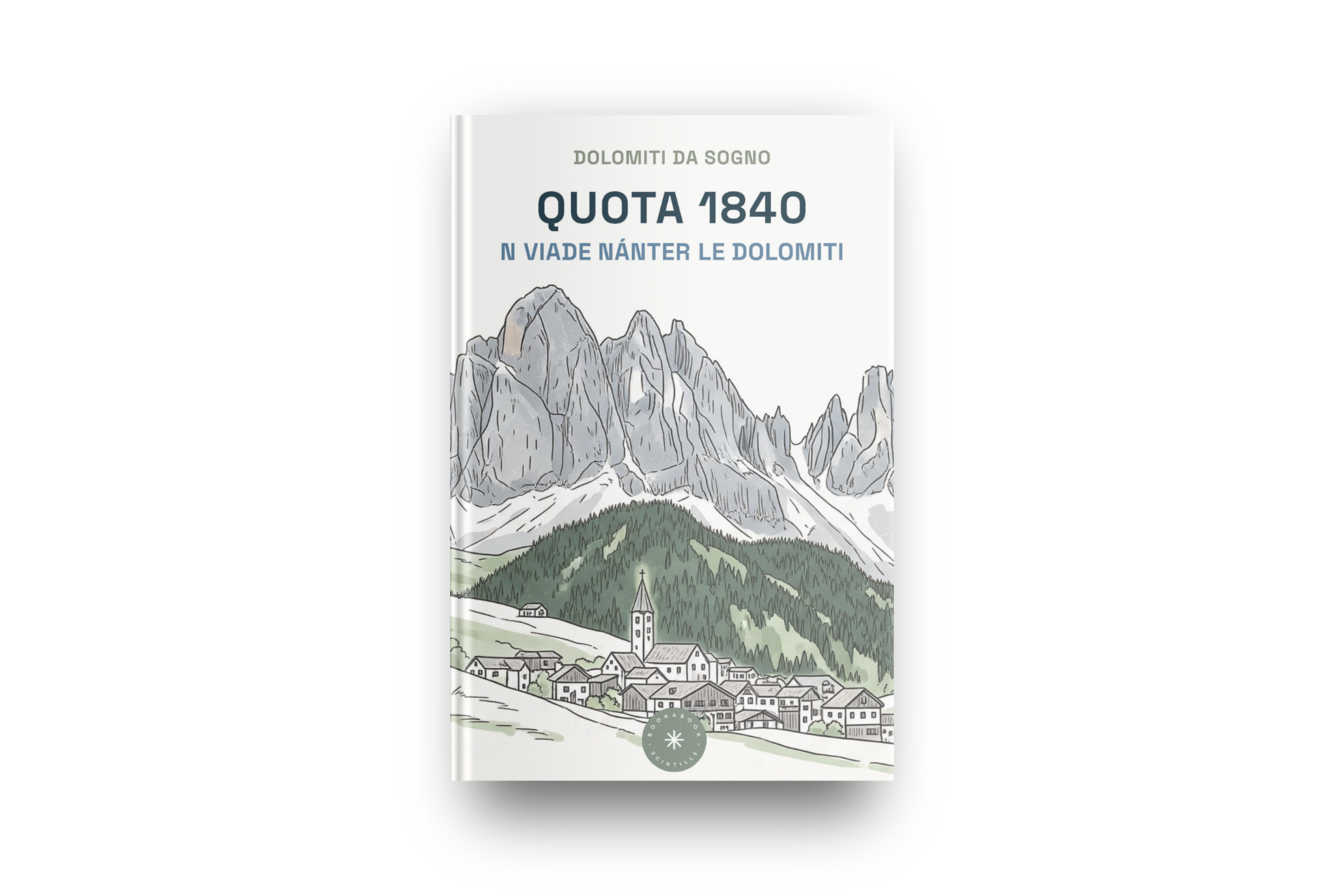



Commenti
Ancora non ci sono recensioni.