Elena con la sua storia ha attraversato i secoli diventando una delle donne più complesse e affascinanti della tradizione letteraria, ispirando diversi autori e spingendoli a scrivere altre storie. Storie che vanno oltre l’Iliade, che vanno oltre quel canto. Elena è bellezza, è amore, è desiderio. Elena è fedeltà, infedeltà, è passione, è tradimento, è colpa, è redenzione. Elena è la donna che gli uomini amano amare e amano odiare. Elena è la mano di chi riscrive la sua storia, di chi decide se deve essere venerata o biasimata. Ogni riscrittura però, in fondo, non è altro che il riflesso dell’animo del suo autore. La colpa però, se davvero esiste, non è solo in Elena. Ogni singola scelta di ciascun personaggio, si riflette sulla vita degli altri e la verità è che nessuno è completamente colpevole o innocente. Solo entrando nell’animo di chi ha vissuto quei giorni e perdendosi tra le sue contraddizioni, tra il suo pericoloso sogno di gloria e tra il suo passato prima di Troia, si può davvero capire quel conflitto che ha segnato il destino di tanti. Dall’Iliade alla letteratura contemporanea Elena intrisa di bellezza, colpa e inevitabilità resta la donna capace di spingere ogni lettore a una profonda riflessione sulla complessità dell’esperienza umana.
Queste cose non avvennero mai, ma sono sempre
Salustio, Degli dèi e del mondo
1
ELENA E MENELAO
Nel corso della letteratura l’amore di Elena per Paride è diventato il simbolo di una passione travolgente sciolta da obblighi e da doveri. Ci sono stati però, scrittori che si sono soffermati sull’amore tra Elena e Menelao, un amore che sa di attesa, di perdono. Un amore, quello di Menelao e Elena, che va oltre ogni logica, ogni razionalità, che va contro la volontà stessa. A te è imposto di non abbandonarmi, e a me è ingiunto di tornare tra le tue braccia. Per secoli, di Elena, si è detto che è stata la donna più bella del mondo e che tradendo Menelao sia diventata la causa della guerra di Troia ma bisognerebbe andare oltre per capire la realtà del suo animo. Elena è una donna vittima di un destino o una colpevole?Omero stesso nel Terzo Libro dell’Iliade, sembra perdonarla attraverso le parole di Priamo «Vieni qui, figlia mia, siedi vicino a me, a vedere il tuo primo marito, e gli alleati e gli amici: non certo tu sei colpevole davanti a me, gli dèi sono colpevoli, essi mi han mosso contro la triste guerra dei Danai». Elena, bellissima e ammirata, è allo stesso tempo una donna nelle mani degli dei nell’ottica di Priamo, in quanto vittima di un volere superiore Priamo, in fondo, è un uomo sapiente, la sua esperienza è grande, e sa giudicare le persone. Ha compreso che Elena porta con sé il peso di un destino a cui la sua bellezza l’ha consegnata – e Priamo sa che i doni degli dèi non sono mai senza pericolo. Per alcuni scrittori però, non fu la bellezza di Elena a scatenare la guerra, ma un inganno, un eidolon. Tra loro c’è Stesicoro di cui Platone parla nel Fedro, e facendo riferimento proprio a dei frammenti di Stesicoro, Platone scrive
Esiste infatti, per coloro che commettono colpe nei confronti del mito, un antico rituale espiatorio, che Omero non conobbe, ma Stesicoro sì. Quando infatti venne privato della vista per aver ingiuriato Elena, non rimase all’oscuro della causa come accadde ad Omero, ma, essendo seguace delle Muse, la comprese e compose subito questi versi:
Non è vero questo discorso
Non salisti sulle navi ben costruite
Non fosti mai sulla rocca di Troia.
Quando ebbe compiuto quell’opera detta Palinodia, recuperò all’istante la vista.
Ma è all’interno della sua opera La Repubblica che Platone pone una domanda che sembra riscrivere la storia, secondo Stesicoro, ci si batté a Troia per il simulacro di Elena, nell’ignoranza del vero? Ed è dall’idea di Stesicoro che Euripide darà vita alla sua Elena, un fantasma dotato di respiro, fatto con un pezzo di cielo e simile in tutto a me. Nell’Elena di Euripide, la guerra di Troia viene combattuta per un doppio, quella che Paride ha rubato non è Elena, è solo un riflesso, un fantasma creato con l’inganno e in questo modo l’autore usa la figura di Elena per mettere in discussione la verità stessa. Nella tragedia di Euripide, è la stessa Elena a sollevare il velo sulla sua storia. Per volere di Zeus, il dio Ermes l’aveva avvolta in una nube e condotta sulle rive del Nilo, lontano da chi amava. A Troia, invece, era giunto solo un eidolon, un fantasma, un riflesso di lei. Quell’eidolon era una perfetta copia di lei, che si aggirava come un’ombra tangibile, così reale da ingannare ogni sguardo, da ingannare Paride e Menelao fino a convincerli del suo respiro. E per quel simulacro, per quella fragile visione di bellezza, i Greci e i Troiani erano in guerra. L’oggetto della difesa dei Troiani, il trofeo per cui combattevano i Greci, non ero io, era solo il mio nome. Ma Euripide conduce i suoi lettori fino all’istante in cui Menelao, in Egitto, incontra lo sguardo della vera Elena. Ed è allora che il destino, sottile e inesorabile, svela il suo volto, mostrando il fragile confine tra ciò che è reale e ciò che è solo un inganno. Quando si parlerà di Elena, non si saprà mai se si tratta del suo corpo o del suo simulacro. Elena è il potere del simulacro – e il simulacro è il luogo dove l’assenza soggioga. La guerra combattuta per un fantasma però riprende un precedente omerico. Nel Quinto Libro dell’Iliade, infatti, i Greci combattono per un doppio di Enea creato da Apollo con l’inganno «ma intanto fece un fantasma Apollo arco d’argento, che somigliava a Enea, simile anche nelle armi». Elena diventa così, l’oggetto di storie che vanno oltre il mito. Nell’Elena egizia di Hofmannsthal, scritta nel 1928, l’Elena colpevole dell’Iliade convive con l’Elena innocente della tradizione stesicorea.
La novità, in Hofmannsthal, sta nel fatto che l’Elena che ci viene presentata è vista attraverso gli occhi di Menelao: essa lo ha effettivamente tradito, lo ha lasciato per Paride e per altri uomini… Ma, nonostante tutto, egli la ama disperatamente, ama il suo amore, così grande, così tellurico e oscuro, non può fare a meno di lei […] Il dramma ci racconta la storia di una “redenzione” possibile, che non può passare per i meccanismi della “rimozione” […] del passato di Elena, ma attraverso la non facile accettazione dei suoi trascorsi.
Se nel primo atto, l’opera di Hofmannsthal resta legata alla tradizione stesicorea attraverso l’eidolon e un’Elena che vorrebbe che la verità della sua storia si dissolvesse con la sua richiesta Etra, «dove di Troia nessuno mai ha udito, là, al mondo, nascondici per breve tempo – Puoi questo?» è solo alla fine del secondo atto, con un’Elena che accetta il peso delle sue scelte, le sue colpe e il suo essere Elena, che Hofmannsthal rivela ai suoi spettatori un concetto di perdono che non avviene attraverso la negazione del passato ma solo attraverso la sua accettazione. Per quella notte, unica e casta, che una volta giunse per unirci in eterno; per quelle notti colme di terrore quando nella tenda per me ti struggevi sono allora le parole di Elena, che non inganna o illude, che non rinnega il suo passato a Troia. Per quella notte di fiamme, quando a te mi traesti e però, duro, negasti a te stesso di baciarmi e così, quello che Hofmannsthal crea, è un Menelao capace di perdonare con la consapevolezza di chi sa ciò che è stato. La vera Elena, pur costantemente presente sulla scena, è riconosciuta da Menelao solo all’inizio e alla conclusione della storia, e di fatto gli viene sottratta per buona parte del dramma, fino al momento nel quale egli saprà realizzare, nell’interiorità della propria coscienza, una piena conciliazione con essa. Menelao è in fondo chiamato ad accettare la realtà di un’Elena adultera.
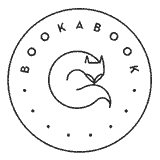



Commenti
Ancora non ci sono recensioni.