Martedì, 3 settembre 2019.
«Ciao».
Le labbra dell’uomo sfiorarono la sua guancia lasciando una sensazione impersonale, con una rapidità quasi meccanica; il saluto tra loro fu sbrigato come un adempimento svogliato, fatto con la stessa efficienza con cui si compila un modulo che ti sembra inutile. Gli occhi di Maila saettarono subito verso il tabellone delle partenze, alzò una mano e la aprì senza nemmeno voltarsi completamente, ignorando lo sguardo dell’accompagnatore, interrompendo sul nascere qualsiasi, eventuale, tentativo di conversazione da parte di lui. Poi si immerse nel flusso anonimo e frettoloso dei passeggeri, dove la sua figura si allontanava senza esitazione. Nessuna ultima occhiata, neanche un indugio. Poiché sarebbe stato un intoppo nella sua tabella di marcia.
Proseguì spedita verso l’imbarco, con la mente già oltre i controlli di sicurezza, concentrata sui varchi, col passo svelto e quel trolley che la seguiva come un’ombra frettolosa.
Controllò l’orologio per l’ennesima volta, la mascella era leggermente serrata come a voler incanalare ogni energia verso l’obiettivo: il gate. Lei sapeva di non avere tempo per le smancerie, nemmeno per un sorriso vero, nonostante quel viso luminoso, che era disegnato per ispirare buonumore, sembrava quasi un controsenso in una maschera di efficienza.
Quella relazione era giunta al capolinea. Le parole della sera prima, furono sussurrate con un tono stanco ma definitivo, le risuonavano ancora nella mente: non funziona, non possiamo far finta. Nessun urlo, nessuna accusa, solo un’amara constatazione che entrambi avevano accolto con un silenzioso assenso.
Un velo di malinconia la sfiorò, ma non era tristezza per la fine di quella storia. Era un senso di vuoto più ampio, esistenziale. Fu attraversata da un dubbio, era davvero così semplice archiviare una relazione? O c’era qualcosa di più che non intravedeva, una ricerca di conferme che la spingeva da un letto all’altro, lasciandola sempre con un senso di vuoto?
Trentacinque anni, e la gioia spensierata della giovinezza le sembrava un ricordo sbiadito, quasi una vita precedente. Sistemò distrattamente la sciarpa leggera color pervinca, in modo da incorniciarle il viso luminoso, mettendo in risalto gli occhi chiari e intelligenti. In questo piccolo gesto automatico, risiedeva la consapevolezza sottile che aveva della sua immagine. Si percepiva come una donna desiderabile, lo leggeva negli sguardi, lo ascoltava nei complimenti sussurrati. Eppure, preferiva mimetizzarsi nell’ombra del suo mondo interiore; un labirinto intricato di pensieri e fantasmi, dove si sentiva paradossalmente più al sicuro che in mezzo agli occhi degli altri. Poteva apparire come la donna ideale: indipendente, colta, affascinante. Eppure, c’era un velo sottile sulla sua illusoria sicurezza. Osservando attentamente, si notava un’ombra di malinconia che increspava il suo sguardo.
Nella routine quotidiana, l’unico raggio di sole era Terry. Un West Highland Terrier bianco, un batuffolo di pelo e allegria che riempiva la casa di piccoli rumori festosi. Quando tornava la sera, trovava ad accoglierla una danza scodinzolante e un tripudio di guaiti entusiasti. Lui non chiedeva spiegazioni, non faceva domande scomode. Voleva solo carezze, coccole, e la certezza di essere amato.
In fila agli imbarchi dell’aeroporto, il pensiero di Terry le illuminò il volto. Immaginò la sua folle corsa verso la porta, un’esplosione di gioia incontenibile in quel corpo piccolo e bianco. Si abbandonava a quel contatto morbido, a quegli occhioni neri e vispi che la guardavano con adorazione incondizionata. Bello e docile, si lasciava manipolare, spazzolare, abbracciare, felice di essere semplicemente suo. Certo, era anche curioso come una scimmietta, invadente quando fiutava uno spuntino, rumoroso con i suoi ansiti e i suoi piccoli grugniti. Ma era anche obbediente, affettuoso in modo quasi commovente, e perennemente stupito, con quell’espressione buffa e interrogativa, quando Maila si sottraeva alle sue leccate appiccicose.
«Ma perché non vuoi la mia lingua sulla faccia? È un gesto d’amore, padroncina!». Sembrava chiederle con quegli occhioni imploranti. Maila provava un affetto quasi morboso per Terry. L’idea di separarsi da lui per un fine settimana la turbava. Anche se i suoi genitori erano affezionati al cagnolino, le rodeva un senso di colpa. A trentacinque anni, si sentiva più padrona affettuosa che amante appassionata. Con lui, aveva creato un linguaggio tutto loro, fatto di gesti impercettibili, intese silenziose. Lei lo osservava, ne studiava le espressioni del muso, del corpo, soprattutto il modo in cui muoveva il naso per captare gli odori. Lui, a sua volta, sembrava leggere nei suoi occhi le sue emozioni. Un legame viscerale, che andava ben oltre il semplice rapporto padrona-cane.
Prima che lo prendesse in casa, una domenica a pranzo, Maila aveva annunciato: «Mamma, papà, vorrei un cane».
«Un cane? Ma sei sicura? È un grande impegno» aveva risposto sua madre, con una punta di preoccupazione.
«E poi, con il tuo lavoro… chi se ne occuperebbe?» aveva aggiunto il padre, corrugando la fronte.
«Lo so, lo so che è una responsabilità» replicò Maila, cercando di convincerli «ma ne ho tanto bisogno. I cani sono senza ipocrisia, sono creature sincere… è che…» Maila esitò un attimo, cercando le parole giuste «più frequento gli animali, e meno comprendo gli umani, ecco».
«Meno comprendi gli umani?» domandò il padre, perplesso.
«Sincere?» chiese a ruota la madre, inarcando un sopracciglio, tornando al punto precedente.
«Sì, mamma! Rispondo prima a te. Voglio dire che sono creature autentiche, senza secondi fini. Papà, pensa, dicono che il loro fiuto è come una bussola infallibile, una lente d’ingrandimento sull’anima delle cose».
«L’anima delle cose?» ripeté il padre, un po’ scettico. «Non esagerare, Maila. Sono pur sempre animali».
«No, papà, non esagero! Mamma, annusano le vibrazioni, percepiscono le intenzioni nascoste dietro le apparenze. Ringhiano se un odore non li convince, se sentono negatività si mettono in allarme. Poi loro non sanno mentire, non sono capaci di ingannare». Maila voleva questo cane. «Idealizzano i padroni, papà! Proiettano su di noi una perfezione… Grazie al loro fiuto, nessun luogo è davvero estraneo, ogni angolo è un universo di odori da esplorare e decifrare. Mamma, e poi sono così socievoli! Ogni incontro con un altro cane è una festa olfattiva. Tra cani non c’è indifferenza, solo amicizia immediata o inimicizia dichiarata. È un mondo binario, semplice e diretto, lontano dalle sfumature ambigue e complesse delle relazioni umane. Gli umani invece…» Maila sospirò, «gli umani sono così complicati e indecifrabili… a volte persino ostili».
I genitori si erano scambiati un’occhiata, sorpresi da tanta passione e dalla vena di malinconia delle sue parole. Avevano pensato, un cane avrebbe davvero fatto bene a Maila, così sola e presa dal lavoro, in questo suo silenzio ovattato tra lo studio e la musica.
«Va bene, Maila» aveva detto infine il padre, con un sorriso indulgente «prendi questo cane. Ma promettici che te ne occuperai tu, eh?».
«Promesso!» giurò Maila, con gli occhi gioiosi. Una frase le risuonava dentro come un mantra: “Più si frequentano gli animali, meno si comprendono gli umani”.
Maila era in pace solo nella sua solitudine. Voleva tornare nel silenzio del suo studio. Lì, con Terry accoccolato sul tappeto, poteva finalmente abbassare la guardia, lasciare che i pensieri fluissero senza filtri, senza il bisogno di sorrisi di circostanza o conversazioni superficiali. Nessun rumore, nessuna richiesta, solo la rassicurante presenza del suo cane e la libertà di perdersi tra sé.
Una volta giunta a destinazione, sarebbero tornati anche i pranzi con i genitori e le domande insistenti sul suo lavoro, sugli amori, e ogni parola era uno spillo che pungeva la sua quiete. La solitudine, per lei, era un rifugio necessario. Era diventata la cifra della sua esistenza da quando le arie d’opera e le sonate al pianoforte avevano lasciato il posto al silenzio ovattato del suo studio che, con lui in casa, le sembrava pieno delle sue note interiori.
Conosceva davvero la solitudine? No, non quella vera e aspra. Aveva trascorso troppo tempo in famiglia, protetta e coccolata, le voci dei genitori erano un brusio costante intorno a lei. Eppure, tra i loro racconti animati, Maila si sentiva come se parlasse un’altra lingua, le sue risate forzate non erano divertimento. Li percepiva come un velo protettivo e soffocante, un rifugio dorato che la isolava dal mondo esterno e dai suoi desideri inconfessati, e le impediva di vivere pienamente la sua vita. Per questo, si accontentava di amori brevi e superficiali, senza radici e senza futuro. Relazioni liquide, come le definiva lei stessa, perfette per affogare e non sentirsi mai veramente a casa.
Troppe conoscenze approssimative e innumerevoli inviti mondani: un circolo vizioso di sorrisi forzati e chiacchiere insulse. Una fitta rete di rapporti inconsistenti, dove non mancavano le ferite per piccole cattiverie, le invidie sussurrate, le parole taciute. Desiderava ardentemente l’anonimato, la distanza dagli altri. Sognava di vivere tra estranei, era meglio persino stare tra nemici dichiarati, pur di fuggire a quella soffocante ipocrisia affettiva. Ogni viaggio rappresentava un’illusione di cambiamento. Ben sapeva che, prima o poi, sarebbe tornata al punto di partenza, dietro quel velo familiare, nella rassicurante penombra del suo studio. Eppure, non poteva fare a meno di illudersi, sorridendo amaramente della propria ingenuità e di quella perenne tendenza a credere nelle favole. Si paragonava ai bambini, fragili e indifesi, ma capaci di una purezza e un’umanità disarmanti. In fondo era rimasta anche lei bambina, intrappolata in un eterno presente fatto di delusioni.
Le dita le tremavano leggermente al ricordo dei tasti d’avorio, un tempo sua unica vera voce, ora muti testimoni di un passato che sentiva ancora gravare sulle sue spalle come un fardello invisibile.
Guardò il telefono, era arrivato un messaggio dell’ultimo uomo, le apparve un sorriso amaro sulle labbra. Già mi manchi, diceva lui. Maila esitò un istante, poi cancellò il messaggio senza rispondere, bloccò il mittente. Era più semplice così, un taglio netto prima che le cose si facessero troppo complicate.
In aereo, diede un rapido colpo d’occhio agli altri passeggeri.
Alla sua destra, una donna dal viso dolce e stanco che cullava un neonato addormentato. Emanavano un profumo delicato di latte e borotalco. Accanto a lei, una bambina, non più di sei anni, con i capelli biondi e arruffati, cercava di dormire appoggiandosi alla spalla della madre. Un quadretto familiare rassicurante. Maila distolse lo sguardo con un’increspatura di malumore, una punta di gelosia le pizzicò il cuore. La maternità era un universo lontano anni luce dalla sua esistenza.
Di fronte, una coppia di giovani, elegante, fremente per la partenza. Lui, i capelli impomatati, la camicia bianca immacolata, le stringeva la mano con possessività, attirandola a sé con piccoli strattoni. Lei, un tailleur grigio perla, i capelli raccolti in uno chignon severo, si ritraeva con una grazia studiata, quasi infastidita da quell’effusione pubblica. Un bacio fugace sulla guancia, un sorriso forzato, poi lo sguardo circospetto di lui, a controllare di non essere osservato. E un altro bacio, stavolta alla mano, un gesto antiquato, che corrugò le labbra di lei in un’espressione indefinibile, un misto di noia e rassegnazione. Maila osservò la scena con curiosità e distacco. Quelle dinamiche di coppia, erano rituali stanchi e prevedibili, le sembravano estranei al suo modo di vivere le relazioni.
Si accomodò al suo fianco un ragazzo atletico e abbronzato, sui venticinque anni. La invase un profumo fresco, leggermente agrumato. In un istante che parve prolungarsi, i loro sguardi si incrociarono, un guizzo di sorpresa e curiosità accese un sorriso spontaneo su entrambi i volti. Il ragazzo le rivolse alcune parole in un idioma fluente e melodioso. Maila lo ascoltò con attenzione, sforzandosi di decifrare quel suono estraneo. “Pardon?”, chiese, incerta. Lui ripeté la frase, scandendo le parole con cura, ma il risultato non cambiò. Forse una lingua slava. Non capiva. Un sorriso di scusa, un gesto di resa. Entrambi si coprirono la bocca con la mano, quasi a chiedere perdono per l’incomunicabilità linguistica. Ci fu poi una lotta, silenziosa e cortese, per la sopravvivenza nello spazio angusto delle poltrone. Lei accavallò le gambe con un movimento fluido, quasi felino. Lui si lisciò i capelli con un gesto nervoso, e appoggiò le mani sulle ginocchia divaricate, occupando più superficie possibile.
Maila vide un tatuaggio che incorniciava l’avambraccio destro del ragazzo. Un’occhiata fugace, poi un’altra più attenta. Due versi, in inglese, tracciati con un inchiostro nero e sottile. Riconobbe le parole, le sillabe familiari di una poesia amata. L’Ode al vento occidentale di Percy Bysshe Shelley. Un sussulto al cuore. Lesse mentalmente i versi tatuati sulla pelle del ragazzo:
“Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud!
I fall upon the thorns of life! I bleed!”
“Oh, sollevami come un’onda, una foglia, una nuvola!
Io cado sulle spine della vita! Io sanguino!”.
Un brivido le percorse la schiena. Quei versi, così intensi e dolorosi, rispecchiavano la sua indole, risuonavano con la sua stessa inquietudine.
“Allacciare le cinture!”. La voce metallica dell’altoparlante la riportò alla realtà. Si partiva. Destinazione Genova.
Un volo breve, un’ora scarsa. Il tempo di un respiro sospeso.
In quota, col viso girato verso l’oblò. Finalmente, il cielo. Immenso, infinito, un oceano di azzurro e bianco che le scorreva accanto, in fuga verso il suo Terry. Le montagne si stagliavano all’orizzonte, il mare brillava lontano. La sua Liguria, il suo rifugio. E allora? Che importava se anche quest’ultima storia era naufragata? Che importava se il cuore era ancora un po’ ammaccato? Doveva augurare amore e felicità agli altri, per fare un esercizio di generosità. E poi, pensare a sé stessa. Non rinunciare alla speranza, per non arrendersi alla malinconia. Aprire i polmoni, respirare l’aria frizzante del cambiamento. Sentirsi leggera, quasi liberata. Come quando si lascia il casinò dopo una lunga notte di gioco, a mani vuote, ma con la sensazione di aver giocato la propria partita fino in fondo. E si augura buona fortuna a chi resta, e continua a scommettere sulla vita.
Osservò di nuovo il ragazzo al suo fianco. Bello, indubbiamente. Un profilo greco, occhi chiari, un’aria vagamente familiare. Le ricordava un attore famoso, un divo del cinema francese. Un nome sulla punta della lingua, che non voleva saperne di uscire. Forse la somiglianza era labile, una suggestione passeggera. Ma era piacevole averlo vicino. La sua presenza discreta la metteva di buon umore.
Un pensiero fulmineo la illuminò come un’epifania: “Dio ci ha creati per guardarci con curiosità, non con rabbia. Perché la curiosità è apertura, è desiderio di conoscenza, è la scintilla che accende il cammino. Per vedere a cosa siamo destinati.” Non dare un giudizio, non condannare, non essere ostile. Solo curiosità, stupore e meraviglia di fronte alla varietà infinita dell’esistenza.
Sapeva fin troppo bene che certe fantasie si pagano. Che l’attrazione, la passione e l’ebbrezza del momento hanno sempre un prezzo da saldare. Ma non le importava. Osservò di nuovo lo straniero, udì altre parole incomprensibili che gli uscivano dalle labbra, e sentì nascere una strana affinità, una connessione inspiegabile. Un’eco di intimità che risuonava nel profondo. Aveva visto un’anima gemella? Ritrovata per caso in un aereo, a migliaia di metri d’altezza. Come se avesse ascoltato questi pensieri, lo sguardo di lui si fece più diretto, quasi a dire: “Sì, ti riconosco. Ti stavo aspettando.” E Maila rispose con un’occhiata eloquente, un linguaggio universale fatto di fiducia: “Mi piaci, straniero. E io piaccio a te? Ti desidero, più di chi ha avuto tutto da me e non ha saputo cosa farsene”. Si scovarono, in quell’istante sospeso, in una patria ideale, un luogo immaginario dove le nostre essenze si comprendono senza discorsi, si vogliono bene senza riserve e paure.
Nessuna parola fu pronunciata, solo un contatto fugace con le mani, una sfiorata appena accennata. Poi, le labbra si incontrarono con una voracità inaspettata, improvvisa e potente che spazzò via ogni esitazione. Il sapore della sua bocca era nuovo, eccitante, e per un attimo Maila si abbandonò a quella vertigine, sentendo un bagliore accendersi in petto.
Gli altri passeggeri erano sentinelle distratte, assopite. Ignari del piccolo terremoto emotivo che si stava consumando a pochi centimetri da loro. E Maila e lo straniero, nel loro volo silenzioso, a non capire più cosa stesse accadendo. A lasciarsi trasportare dalla corrente, a farsi cullare dall’ebbrezza di passioni in alta quota, verso un orizzonte sconosciuto.
A Genova, l’atterraggio fu brusco per il ritorno alla realtà. Uno scambio rapido dei numeri di telefono, dei contatti social. “Ci sentiamo, promesso”. Un sorriso, un cenno della mano. Lui salì in un taxi per il porto, direzione Corsica. E poi, all’uscita dall’aeroporto, l’aria frizzante di settembre, il cielo terso della Liguria. E suo padre ad attenderla, con quel sorriso bonario negli occhi azzurri e luminosi. Un abbraccio stretto, un bacio sulla guancia. “Bentornata, Maila”.
Tra le coccole affettuose, il padre le disse con un tono di voce un po’ emozionato:
«Ti hanno riconsegnato il secrétaire restaurato».
Un lampo di gioia illuminò il viso di Maila. «Ah, finalmente! Meraviglioso…» Un pensiero improvviso la assalì. «È già nel mio studio?».
«Certo. L’abbiamo sistemato proprio stamattina. E c’è anche una sorpresa». Sorrise enigmatico. «L’ebanista ha trovato un vecchio quaderno ingiallito al suo interno».
«Un quaderno?» Maila inarcò un sopracciglio, incuriosita. «Cosa c’è scritto?».
«Sembra un diario, sai? Pagine fitte di scrittura, date, capitoli… Un manoscritto, chissà di chi fosse».
«Che strano…» Maila si morse il labbro inferiore, pensierosa. «Contatterò l’antiquario di Bologna che mi ha venduto il secrétaire. Magari si riesce a rintracciare il proprietario».
Il padre sorrise, compiaciuto da quella sensibilità. Mentre raggiungevano l’auto, chiacchierando amabilmente del volo, del tempo, delle piccole cose di ogni giorno, poi Maila chiese: «Come sta il mio piccolo terremoto?». Udì la risposta del padre, ma la mente volò via, attratta dal mistero del ritrovamento del quaderno ingiallito, fantasticava sulle storie sussurrate tra quelle pagine, già immaginava le infinite possibilità racchiuse in quel piccolo oggetto, un potenziale inaspettato di umanità nascosto nel cuore del vecchio secrétaire.
-
IL SECRÉTAIRE E IL MANOSCRITTO
Appena varcata la soglia di casa, Maila sentì un urto peloso alle gambe. «Terry!» Lì sotto, con la coda che vibrava così velocemente da sembrare un’unica sfocatura. Guaiti acuti riempirono l’aria, mentre le girava intorno un vortice di gioia canina. Lei si chinò per affondare le mani nel suo pelo morbido e profumato di pulito e il piccolo Westie le saltò addosso in una frenetica danza di benvenuto, lo strinse forte al petto. «Mon amour! Mi sei mancato tanto!» sussurrò, con il viso nascosto nel suo manto. In risposta, quella lingua piccola e ruvida le solleticava la pelle con una serie di leccate umide e affettuose sulla guancia.
Finita la calorosa accoglienza di Terry, lo posò a terra e, con lui che la seguiva, prese le scale quasi di corsa, con un sorriso impaziente che le incurvava le labbra. Ad ogni gradino, sentiva un’ondata di battiti crescerle nel petto. Finalmente. Era lì. Restaurato.
Vide il secrétaire. Troneggiava contro la parete, mentre la luce del tardo pomeriggio ne accendeva la calda tonalità ambrata.
Si fermò sulla soglia del suo studio, il suo sorriso illuminava la scena. La lucidatura a gommalacca aveva esaltato le intricate venature della radica di noce, trasformando il legno in una superficie cangiante, quasi pulsante di vita. Allungò una mano, le dita sfiorarono la facciata liscia, seguendo le sinuose venature come se volesse decifrarne la storia. Un mobile così imponente eppure così discreto, pensò, era un testimone silenzioso di un’altra epoca, custode di segreti sussurrati nel silenzio.
La primavera dell’anno precedente, a Bologna, quel negozietto dell’antiquariato era stato una scoperta inattesa, proprio come Riccardo, l’uomo che le camminava accanto, con la mano calda nella sua. Ricordava il sole tiepido sulla pelle, il profumo inebriante dei glicini in fiore che si mescolava all’odore acre dei mobili antichi dentro quel locale. Si erano fermati davanti a un banco colmo di oggetti disparati, quando il suo sguardo era stato catturato da un angolo polveroso. Lì, quasi dimenticato, troneggiava il secrétaire. Le venature scure della noce sembravano guizzare sotto uno strato di polvere, promettendo una bellezza nascosta che le aveva parlato subito al cuore.
Si era convinta di aver fatto un affare, e in fondo lo era stato davvero. Un mobile autentico dell’Ottocento, un pezzo pregiato che meritava di essere riportato al suo antico splendore. La radica era magnifica, certo, ma bisognosa di cure, di attenzioni. Così aveva deciso di affidarlo alle mani esperte di quel restauratore genovese, un artigiano vecchio stampo di cui le avevano detto meraviglie.
Ora, il risultato sotto i suoi occhi, superava di gran lunga le sue aspettative. Ammirava la lucentezza profonda della gommalacca, che rifletteva la luce morbida dello studio come uno ritratto dorato. Passò ancora le dita sulla superficie calda del mobile, seguendo le curve delicate delle cornici, i profili netti dei cassetti. Ogni dettaglio era perfetto, curato con la maestria della passione e dedizione dell’ebanista.
Il secrétaire si presentava con una struttura imponente e lineare, tipica dell’arredo lussuoso ottocentesco. Fronte e fianchi dritti, scanditi dalla ribalta superiore e dai tre ampi cassettoni sottostanti. Maila abbassò delicatamente la calatoia, rivelando uno scarabattolo interno di squisita fattura. Un piccolo teatro finemente decorato, con quattro colonne tornite e laccate a incorniciare sei tiretti disposti simmetricamente. Al centro, un vano aperto, illuminato sullo sfondo da una superficie riflettente al mercurio, velato dal tempo e dall’ossidazione, ma ancora capace di restituire un’immagine sfumata e suggestiva.
Nella parte superiore del castelletto, Maila notò un cassettino basso e largo, quasi nascosto alla vista, sormontato da uno spazio vuoto impreziosito da un loggiato di colonnine intarsiate. Un dettaglio raffinato e un tocco di eleganza inaspettata.
Lo sguardo si soffermò su una piccola maniglia metallica, quasi invisibile al centro dello specchio. Un’esitazione, poi la sua curiosità prese il sopravvento. Un dito si allungò, sfiorando il metallo freddo prima di spingere delicatamente. Un leggero scatto, quasi impercettibile, e una piccola fessura si aprì. Dietro, non più celato alla vista, un vano nascosto. Ed era lì, in quel recesso segreto, che il restauratore aveva ritrovato il manoscritto.
Maila scorse subito il vecchio quaderno ingiallito, appoggiato con cura in quel piccolo spazio ricavato. Lo strinse al petto per un istante, quasi fosse un tesoro. La copertina era lisa, consunta dal tempo, le pagine erano fragili. La carta sottile scricchiolò leggermente tra le sue dita, emanando un odore antico che le pizzicò le narici.
Aprì con delicatezza alla prima pagina del quaderno. La scrittura era minuta ed elegante. Una bella grafia dal tratto deciso e raffinato. Le parole danzavano sul foglio, formando frasi di grande suggestione. Esattamente come aveva detto suo padre, sembrava un diario, scandito da date e suddiviso in capitoli. Ma sul frontespizio, in bella evidenza, campeggiava un titolo enigmatico e suggestivo: MENTRE VIVEVO. E sotto, il nome dell’autore: Giovanni Battista Draghi.
Un nome sconosciuto e un titolo misterioso. La curiosità di Maila crebbe incontenibile.
Fu catturata, si creò un velo tra lei e il mondo circostante. Non sentiva il rumore del traffico fuori dalla stanza. Le pratiche da sbrigare, gli impegni della giornata, persero di importanza, dissolvendosi come fumo nel vento. Potevano tranquillamente aspettare, accumularsi e moltiplicarsi nella lista delle cose da fare. In quel momento, esisteva il manoscritto, e la voce lontana di Giovanni Battista Draghi, e il richiamo irresistibile di una storia che attendeva solo di essere riscoperta.
Sabato, 7 gennaio 1978
Per mano di un gruppo armato dell’estrema sinistra, due militanti missini, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, vengono assassinati durante un assalto a una sezione del M.S.I. in via Acca Larentia, a Roma nel quartiere Appio. Poco dopo, nella rivolta che segue il duplice omicidio, i carabinieri uccidono un altro esponente del partito: Stefano Recchioni. I tre avevano un’età compresa tra i 18 e i 22 anni.
MULATTO
Giusto il monito di quel padre al figlio: «Ti auguro di conoscere Vittoria e Sconfitta, e di trattare queste due ingannatrici con la stessa indifferenza». Aveva indicato la via della saggezza, quella che insegna a discernere il bene dal male, i cui conflitti potevano leggersi negli occhi di chiunque avesse vissuto abbastanza.
Quanto a me, non serbo ricordi di una figura paterna.
Mi chiamo Giovanni Battista Draghi, detto Gianni. La prima volta che la sconfitta mi si presentò, non la riconobbi come una ciarlatana, ma come un’ombra costante. Nacqui a Napoli nel 1945, ero un bambino con la pelle più scura in un’Italia che si stava ancora scrollando di dosso gli orrori della guerra, ero uno scugnizzo che faceva le prime corse e i primi giochi nelle strade del Sud.
Mia madre parlava poco di mio padre. Del soldato americano, sentivo sussurrare un’unica parola, carica di un’ombra di sdegno e vergogna: “negro”. Si diceva avesse incrociato il destino della giovane donna tra i vicoli brulicanti dei Quartieri Spagnoli. Il resto era sotto un velo di silenzio.
Io fui il risultato tangibile di quell’incontro fugace.
Mio nonno, la cui vita era legata al mare, aveva trasferito la famiglia a Castellammare di Stabia, il porto da cui salpavano le navi dei suoi armatori. Io, invece, rimasi a Napoli, tra le mura austere della Real Casa dell’Annunziata, nel cuore vibrante e caotico di Forcella. Nessuno della famiglia di mia madre mi aprì la propria porta.
Ricordo il volto gentile di una suora, le sue mani premurose che mi accarezzavano il capo. La sua presenza fu un raggio di luce in un’infanzia altrimenti opaca. Fu lei a tessere i fili spezzati con i miei parenti, a intercedere affinché mia madre trovasse impiego nell’orfanotrofio. Lì, tra le culle e i vagiti, il suo sguardo iniziò a posarsi su di me con una nuova dolcezza, fino a quando, compiuti sei anni, mi strinse la mano e mi riportò in quella che avrebbe dovuto essere la mia casa.
Cos’è un rifiuto? Un oggetto abbandonato, privo di utilità, di valore. Io ero nato da quel gesto metaforico, germogliato dalla violenza di un uomo strappato alla sua terra per combattere un conflitto lontano e insensato. Ero il frutto inatteso di un desiderio proibito, un’appendice superflua. Eppure, dentro quel corpo di bambino, ardeva un universo interiore, un complesso intreccio di pensieri, emozioni, legami e principi.
Mio padre, avrà mai immaginato le conseguenze di quell’incontro fugace? Sarà mai riuscito a riabbracciare la sua terra natia?
Dove vanno a perdersi le mie angosce? Le sento ancora qui, dure come pietre, venate di una malinconica poesia, altre volte cupe e tragiche, vagando senza meta nell’oceano delle mie incertezze.
Fin dalla tenera età, ho dovuto imparare ad ascoltare la voce interiore, a cercare un senso in un’esistenza che sembrava iniziare con un punto interrogativo. Una battaglia silenziosa si consumava dentro di me, un dialogo incessante con la mia stessa mente.
La mente, spesso cieca, si crogiola nella sua miopia, intrappolata dalle percezioni immediate, attratta dalla concretezza delle cose, dalle dinamiche relazionali, dal perseguimento di obiettivi personali, senza rendersi conto della bellezza intrinseca che pulsa in ogni forma di vita.
Mi ritrovavo spesso incapace di riconoscere il mio valore. La lucidità del pensiero era offuscata, e nessuno, se non io stesso, sembrava disposto a difendere i miei diritti. Nessuno condivideva il colore della mia pelle, né tra le mura domestiche, né fuori.
L’unico uomo in famiglia, mio nonno, mantenne sempre un certo distacco. Anche quando ero nella stessa stanza, si riferiva a me con un pronome impersonale, “quello”, delegando a mia madre o ad altre gli ordini che mi riguardavano.
Sento l’impellente necessità di dare un ordine a questa mia vita, devo raccontarmi, fissare queste memorie sulla carta, perché, per quanto mi riguarda, la trama del mio destino è ormai definita.
Padre… oggi mi hanno mostrato la mia fine. Sono stato condannato, e la tua immagine è un’ombra costante nei miei pensieri. Solo ora comprendo la vastità dei momenti trascorso senza cercarti, senza capire.
Il tempo esiste; ce ne accorgiamo quando viene a mancare. Oggi mi presento a te con l’umiltà di chi non ha più nulla da perdere. Ho baciato il legno della croce e l’immagine di tuo figlio, nostro Salvatore. La mia pena è stata pronunciata. Ho stretto la mano del primario che mi ha rivelato la verità, mi ha accompagnato con parole di conforto, ma nei cui occhi ho letto un addio silenzioso e definitivo. Sono stato condannato. Nessuna voce si leverà per chiedere la mia salvezza. Dovrò morire. Questa è una verità che sapevo già; mi ha accompagnato fin dal primo vagito. Mi è stato detto che un male oscuro si è insinuato nel mio corpo, probabilmente sarà lui, implacabile, a decretare la fine del mio cammino.
Perciò ti raggiungerò, e il desiderio di rivederti brucia dentro di me. Per ora, l’impossibilità è un muro invalicabile. Se questo è stato deciso: affrettati a portarmi a casa, Padre.
Avevo coltivato l’illusione di un’esistenza senza fine, per non dissolvermi come un’ombra inconsistente. Troppo occupato a galleggiare in superficie, dimenticandomi di immergermi nelle acque profonde e turbolente in cerca di attimi significativi. Ora, mi assale il timore di non meritare il Tuo Regno, ma ho la speranza di poter intraprendere un cammino spirituale come ultimo fragile appiglio.
L’idea di restare confinato tra queste mura mi opprime, sento già il sussurro della follia insinuarsi nella mia mente. Ora i giorni si fanno tangibili, possono essere un peso schiacciante o una dolce carezza. Quanto mi rimane? Anni? Mesi?
Gli attacchi di panico e le crisi di pianto si faranno più frequenti, come onde impetuose che si infrangono sulla riva. Mi mancheranno volti familiari, la routine del lavoro, la sensazione di essere parte di un mondo che continua a girare. Ho bisogno di aria, di sentire il vento sul viso. Devo riempire i momenti, imparare a vivere in modo autentico, trovare il coraggio di affrontare l’ignoto.
Devo trasformare le mie debolezze, purificarle fino a quando non sarò in grado di percepire nel profondo del mio essere l’Amore Divino. Ricevere la Tua Grazia e irradiarla ovunque, come un faro nella notte.
So che mi aspettano lunghi periodi di isolamento, dopo i ricoveri in ospedale, giorni e notti segnati da un dolore fisico e psicologico inesorabile. Ma il bene più prezioso è ancora qui, dentro di me: la mia vita. Tutto il resto attende la fine di questo incubo.
Sabato, 11 febbraio 1978
In Cina è stata proibita la lettura delle opere di Shakespeare, Aristotele e Charles Dickens.
RIFLESSIONI
Esco di casa quando il cielo inizia a tingersi di rosa, giusto il tempo di osservare il mondo che si risveglia lentamente. Qualche luce si accende alle finestre, ma le strade sono ancora silenziose. Lì, avvolto nella quiete del mattino, cammino, osservando ogni dettaglio, cercando di ritrovare un equilibrio interiore che sento vacillare. Ne ho un bisogno vitale, come l’aria che respiro.
Questo mio modo di affrontare l’esistenza non è stato il più saggio. Ora cerco altri modi per accogliere la fine, che abbiano una dignità maggiore.
Dicono che il male che mi affligge sia implacabile, generoso nella sua crudeltà, senza possibilità di remissione. Un avversario tenace, che non concede tregua, indipendentemente da quando lo si scopre. Ho giusto il tempo per riflettere su ciò che sono stato. Le lacrime sono compagne fedeli, capaci di liberarmi; esprimono ciò che la mia bocca tace. Questo senso di fine porta con sé un’urgenza: voglio lasciare un segno nel mondo, desidero raccontare la mia storia affinché qualcuno possa capirmi e tramite la magia della scrittura, leggere di me tra decenni e trovare un legame affettivo con il mio spirito.
Non posso perdermi in convenzioni e nascondere ciò che provo. Questa malattia ha tagliato via le illusioni come una lama affilata, facendomi vedere quello che conta davvero. Siamo belli nelle nostre imperfezioni. Fino all’ultimo respiro questa sarà la mia inesorabile ricerca.
Si dovrebbe vivere con la passione di un innamorato, con il cuore palpitante di desiderio. L’amore è un balsamo per le ferite dell’anima, un antidoto contro i pensieri più oscuri. Se non mi sentissi così solo, riuscirei a percepire la forza del mio Spirito, il coraggio che nasce dalla consapevolezza delle mie scelte, il conforto della Bellezza interiore che scaturisce dall’accettazione serena della realtà. Ogni istante non sarebbe una lotta, ma un incontro tra forze che si sono allontanate, dimentiche del tempo in cui danzavano all’unisono nel mio Essere.
Come uomo, consapevole dei miei limiti, sento il bisogno di immaginare, di aggrapparmi a qualcosa, perfino al ricordo fugace di un bacio, anche se so che è un’illusione, che non porterà a nessuna redenzione, e che, ancora una volta, sto ingannando me stesso.
Cerco di non frantumare l’unità del mio essere. Il Male e la Delusione non li considero entità separate dallo Spirito, dalla Forza, dalla Gioia, dal Piacere. Intuisco in loro un potere trasformativo, una sorta di alchimia interiore che attende di essere compresa.
Mi sono ammalato, ne sono convinto, perché avevo smarrito quella primordiale sensazione di integrità. La mia psiche vagava in un’eco disarmonica rispetto al corpo, la mente e lo spirito avevano cessato la loro danza sincronizzata. Così, mi sono ritrovato indifeso, esposto a forze difficili da contrastare, come un fragile vaso di cristallo in balia della tempesta.
La paura, l’ansia, la depressione, la rabbia… un quartetto di avversari implacabili che hanno ingaggiato un duello spietato con la mia carne, con il mio stesso respiro affannoso.
Percepivo distintamente, come quell’unità che mi aveva sempre sostenuto avesse perduto la sua armonia, la sua melodia originaria.
Il valore del tempo si è trasformato dopo quella diagnosi, come una moneta antica ritrovata in un forziere dimenticato. Non c’è più spazio per l’indugio, ogni pensiero deve tradursi in azione, ogni desiderio in un progetto imminente.
Mi hanno fatto un dono, paradossale quanto crudele: la certezza che il mio futuro è un orizzonte vicino, una linea sottile che presto si dissolverà. La mia ombra si prepara a congedarsi dalla terra. La parola “tempo”, un vocabolo così comune, ha assunto sfumature diverse e significati cangianti nelle varie stagioni della mia esistenza.
Nella mia infanzia, era l’attesa febbrile di crescere, l’intervallo percepito come un’eternità che separava il bambino dall’agognato mondo degli adulti.
Poi, la giovinezza, e l’età adulta… Si è fatto tiranno, sempre insufficiente, un vaso in cui riversare troppe cose da compiere, ventiquattro ore che non bastavano mai a contenere la frenesia della vita.
Ora, è soprattutto un album di ricordi: spiccioli sparsi sul tavolo di una cucina assolata, accanto a una natura morta di frutta dai colori vividi. Lei dormiva, il viso abbandonato a un riposo sereno, le labbra appena dischiuse. Quello, ora lo so, era un frammento di un mondo felice, un’isola di pace in un mare in tempesta.
Ero convinto, con la cieca fiducia della gioventù, che il corpo fosse l’espressione tangibile della nostra forza interiore. Non ero ossessionato dalla salute, lo lasciavo libero di esprimersi, di godere dei piaceri della vita, sicuro della sua resilienza. Ingenuamente, pensavo che il mio fisico possedesse un’innata saggezza, una capacità autonoma di respingere virus, batteri, ogni sorta di male.
Provavo, certo, a nutrirlo con cura, offrendogli il meglio che potevo. Avevo rispetto e attenzione per la forma e per la sostanza, e mi dilettavo nella lettura, nutrendo anche la mente, il motore di ogni azione. Credevo che la lotta con la natura fosse un affare suo, una battaglia silenziosa che si sarebbe risolta senza il mio intervento.
Gli eventi della vita e l’inarrestabile fluire di un fiume… paragoni quanto mai pertinenti. Entrambi scorrono, cambiano forma, incontrano ostacoli, ma la loro essenza profonda rimane immutabile, un movimento continuo verso una meta sconosciuta.
Tutto si trasforma, si evolve, si rinnova, come le foglie che cadono e rinascono a primavera. Ma, in fondo, nulla muta veramente. Il ciclo continua, eterno, indifferente alle nostre piccole storie.
Martedì, 28 febbraio 1978
Ieri la Francia ha effettuato altri esperimenti nucleari a Mururoa, nella Polinesia francese, in quel lontano Oceano Pacifico.
Al telegiornale hanno appena annunciato la morte di un ragazzo, Roberto Scialabba, assassinato da colpi di pistola. L’efferato omicidio è stato rivendicato dalle frange neofasciste romane.
VITA OVUNQUE – COMUNQUE
La vita è ancora un fremito nel mio petto, un’eco lontana che si propaga dalle viscere. E fuori, il sole inonda di luce le cose, disegnando ombre lunghe sull’asfalto. Altri corpi si muovono intorno, voci si mescolano nell’aria, e io, con la mia ombra che si allunga sempre più, rimango un uomo in mezzo ad altri uomini. Tornando a casa, si sono susseguiti i volti che ho incrociato, una folla anonima che mi ha sfiorato senza notarmi. Gli sguardi si sono evaporati, con la consueta indifferenza che avvolge il passaggio degli sconosciuti nelle strade affollate. Ma ora, seduto nella penombra del mio salotto, un’onda di quiete inattesa mi avvolge. Qualunque sia l’ultima carta che il destino ha in serbo, sento che nulla potrà superare la nitida consapevolezza di ciò che mi attende. Affronterò l’ignoto senza un lamento, cercando di conservare quel poco di dignità che ancora mi veste. È in questo fragile proposito che risiede la vita che ancora mi scorre nelle vene; il mio doloroso orizzonte non mi curverà le spalle sotto il peso dello sconforto, il respiro non si farà corto per la disperazione.
Ho sentito, come se fosse la prima volta, la fragilità della mia mano, il battito incerto del polso. Carne e sangue, un’eco lontana del Verbo che si fece uomo, un’esistenza breve come un respiro nel vento. Questa è la verità che mi abita, la mia verità, e questa è la vita che mi resta, anche se le sue luci si stanno affievolendo. La mia croce, invisibile agli occhi degli altri ma così pesante sulle spalle, attende il suo Calvario personale. Ho seminato pensieri, mi sono abbeverato alla bellezza di un verso, di una tela, ho cercato e trovato un’eco nel dignitoso anelito dell’anima a sollevarsi, a drizzare la schiena, metaforicamente, prima che si pieghi definitivamente.
Le rughe sul mio viso non raccontano più la freschezza della giovinezza, ma portano con sé le storie di un’esistenza vissuta, le mappe indelebili tracciate dal tempo. Sotto la pelle segnata, la fiamma di un amore passato arde ancora, la memoria di un dolore provato, la tenacia di un desiderio e la ricchezza di un album sfogliato mille volte. Nessuno suona la tromba per annunciare l’inizio della corsa. Se non si ode lo sparo, se non si sente la scarica di adrenalina, ogni sforzo, ogni anelito rischia di disperdersi come polvere nel vento.
Eppure, anche questo silenzio, questa attesa, è un frammento di vita. Le dita continuano a muoversi sulla tastiera, finché avranno la forza e la volontà di farlo, finché le parole vorranno ancora danzare sulla pagina bianca.
Dio… ora siamo solo io e Te. La Bibbia è lì, sul comodino, la sua copertina consunta testimone di tante notti insonni. La leggerò stasera, cercando tra le sue antiche storie un conforto. Mi aspetta una lunga traversata verso l’ignoto, e devo prepararmi con la serenità che le mie forze mi concedono. Le ricchezze terrene non hanno più alcun peso, i beni materiali sono diventati ombre inconsistenti. Ho solo un’impellente necessità: sentire l’aria fresca sulla pelle, il respiro della vita che si fa sempre più flebile. Non lasciarmi ora, non dimenticarmi proprio su questo ultimo tratto di sentiero. Questo è tutto ciò che conta veramente.
Ci incontreremo, infine? Vivi davvero, al di là del sottile velo della mia esistenza terrena? Sei reale, o sei solo il riflesso del mio desiderio di trascendere questo confine? Sento ancora un sussulto, le ultime vibrazioni di una spiritualità tenace che ha resistito a tante tempeste. Ho attraversato mari in burrasca nella mia vita, credo di aver poco altro da temere. Sia quel che sarà, accolgo il Tuo silenzio.
Volgerò gli occhi indietro per un’ultima volta, sussurrando addii sinceri a coloro che hanno incrociato il mio cammino, che hanno condiviso con me frammenti di esistenza. Il cuore mi suggerirà parole dolci, intessute di affetto, per coloro che ho amato. Auguro con ogni fibra del mio essere tanta felicità a chi avrà ancora il dono di osservare il sole sorgere per molti anni, e a chi conserverà un piccolo ricordo della mia breve stagione sulla terra.
Ho avuto scontri, incomprensioni, ho lasciato dietro di me qualche ombra, un’impressione negativa nel cuore di qualcuno. Prego, con l’umiltà di chi si congeda, che mi perdonino e che possano dimenticare le mie mancanze, le ferite involontarie che potrei aver causato.
Non sento il peso del rancore, nessuna amarezza mi stringe la gola in questo momento. Anzi, desidero ardentemente trovare una pace con tutti, dissolvere ogni traccia di risentimento come nebbia al mattino.
Abbiate pietà di me, vi supplico, e perdonatemi. Io, dal profondo del mio animo, vi perdono. Questa è la beatitudine? Una serenità inattesa che mi avvolge in questo preciso istante.
Voglio chiudere gli occhi e rivedere gli anni passati, la vivacità dei giorni di gioventù, le speranze che ora, con un gesto lento e doloroso, strappo via dal mio cuore sanguinante perché il loro eco risuona come una beffa.
Dio mio! Quante immagini affollano la mente, fotogrammi nitidi di un tempo che non tornerà. Si dissolveranno anch’esse, svanendo come fumo dalla mia testa, o si disperderanno nell’immenso vuoto che presto mi accoglierà?
Se mi volto a scrutare il sentiero percorso fino ad oggi, un’amara constatazione si fa strada: quanto tempo sprecato in futilità, quanta energia dispersa in litigi, incomprensioni, pigrizia, nell’incapacità di afferrare il vero significato dell’esistenza. Quanto poco ho amato, quante volte ho agito in contrasto con quel sussurro interiore che chiamiamo coscienza. Se i giovani potessero solo comprendere che la vita è un dono prezioso, un’opportunità di gioia… ora che sto per perderla, ne comprendo appieno la forma, la sua fragilità.
Dio, ti prego, fa’ in modo che altri non consumino invano questo meraviglioso presente.
Fammi rinascere, se possibile, con la saggezza dei miei errori, per essere migliore, per assaporare ogni singolo istante come un sorso d’acqua fresca. Sarebbe un sollievo immenso.
Presto sempre meno attenzione all’immagine che rifletto nello specchio. Ah, se solo avessi la forza di un tempo!
Valutate con cura il tesoro della vostra vita, non disperdetelo in cose effimere. Costruite il vostro destino con consapevolezza, pensando soprattutto a coloro che verranno dopo di voi, i vostri figli. Ora che devo separarmi da tutto ciò che mi è stato caro, il pensiero mi strazia come una lama affilata.
Affido queste memorie al foglio, le sensazioni che mi attraversano in questo crepuscolo, perché desidero che resti qualcosa del mio passaggio su questa terra, oltre a un’ombra fugace, anche un debole bagliore della mia luce interiore.
Mercoledì, 1° marzo 1978
Oggi, con un gesto ignobile e avido, hanno trafugato le spoglie mortali di Charlie Chaplin dal cimitero di Corsier sur Vevey, in quella pacifica Svizzera.
LA CASAMATTA
Le estati del 1956 si scioglievano lente, pomeriggi pigri che rubavano ore preziose. Io, seduto sul gradino sbrecciato, ascoltavo le note spensierate di “Guaglione” cantate dagli altri ragazzi del quartiere. Le loro risate mi raggiungevano cariche di un’eco beffarda. Quel tempo, allora vuoto, ora riaffiora con una dolorosa precisione. Mi vedo ancora lì, il sole che scalda l’asfalto, intento a spingere con la punta del piede una lattina arrugginita che rotolava pigramente. Giornate qualunque che si trasformavano in una lenta agonia di noia. Lo sguardo basso, le spalle strette: non c’era eco di orgoglio per quel sangue che sentivo mescolarsi nelle mie vene, né per le parole che faticavo a trovare.
L’esistenza si stendeva davanti a me, un campo immenso da attraversare, un tempo infinito da riempire, da “ammazzare”, come sentivo dire. E io giocavo da solo, cercando invano un varco in quel muro invisibile che mi separava dai miei coetanei, dagli sguardi che mi sfioravano senza fermarsi. Un’ombra diversa in quelle strade strette, l’unico con quel colore di pelle. E nemmeno tra le mura di casa trovavo un riflesso, un volto simile al mio.
Fuori, per ottenere un cenno di rispetto, per far ammutolire quelle voci che mi ferivano, dovetti alzare le mani, far provare il mio pugno contro un naso, vedere il sangue sgorgare.
«Sei fràcito, caffellatte, carbonaro, spazzacamino, sporco, merdoso…». Le parole si conficcavano come schegge, il crudele battesimo che i miei coetanei mi riservavano, lanciate con la precisione di pietre.
Finché le mie mani, ancora piccole, non furono pronte a restituire il dolore di quelle parole. Un corpo a terra, un volto tumefatto: la lezione, brutale, fu chiara per tutti. Avevo scelto il più grande, il più ostinato, per farmi sentire.
Due ciottoli lisci e freddi mi stringevano il palmo sudato. Appena lo vidi avvicinarsi, pronto a recitare la solita litania che strappava risate agli altri, la mia rabbia esplose. Pugni ciechi, un turbine di furia che non guardava in faccia nessuno. Tutta la frustrazione, il risentimento accumulato in silenzio, deflagrarono in quell’istante, alimentandosi alla vista del sangue che rigava il suo viso gonfio.
Un pianto disperato, suppliche spezzate che mi raggiunsero come un’eco lontano. Alzai lo sguardo: gli altri erano spariti, lasciandolo solo, un mucchio di dolore e paura che singhiozzava parole di perdono.
«Vattene!», urlai, la voce roca di una rabbia che mi consumava. E lui, con uno sforzo inaspettato, si risollevò e fuggì via, trascinando una gamba.
Dopo quel gesto, finalmente, gli sguardi cambiarono. Un timido cenno, un silenzio meno ostile: il rispetto, conquistato con la violenza, era arrivato.
Abitavo in un palazzo popolare che la gente chiamava “Casamatta”. Un viavai continuo di volti segnati, di storie ai margini che si incrociavano su quelle scale scrostate. “La casa dei falliti”, udivo chiamarla. Un epiteto che, in fondo, non mi dispiaceva. Non avevo simpatia per i trionfi ostentati, li trovavo intrinsecamente volgari. Anzi, era la fragilità di tanta gente, i loro silenzi carichi di sconfitte, a rendere sopportabile la mia stessa esistenza. Un modo per sentirmi parte di quella stessa umanità dolente.
Al quarto piano, un uomo alto e magro, il Cantastorie. Un naso singolare, lungo e affilato, con una strana curva che lo schiacciava verso il basso, come una freccia puntata al mento. La prima domenica del mese, lo vedevo uscire con i suoi abiti migliori, la giacca un po’ lisa ma pulita. Lo seguivo con lo sguardo mentre si dirigeva verso la piazza, di fronte alla chiesa. Lì stendeva una vecchia tela consunta, figure sbiadite che raccontavano, in sequenza verticale, una storia popolare. Un cappello di paglia ornato di campanellini tintinnava leggermente ad ogni suo passo. Poi, la sua voce si alzava, parole semplici accompagnate da gesti ampi e teatrali, narrando storie antiche o appena raccolte tra la gente. I bambini con gli occhi spalancati, gli anziani con un sorriso nostalgico sulle labbra: il suo pubblico si lasciava trasportare dalle emozioni, mentre il suo dito indicava le scene dipinte. Tra una strofa cantata e l’altra, un breve sorso da una fiaschetta di vino rosso, poi riprendeva con rinnovato vigore, agitando una bacchetta di legno e intonando le rime della sua ballata. Al termine, il cappello passava tra la folla, raccogliendo qualche spicciolo in cambio di un foglietto ruvido con la storia disegnata in miniatura, e un arrivederci al mese successivo.
L’inquilino che più mi era indigesto stava al quinto piano, aveva un modo tutto suo per liberarsi dei rifiuti. La finestra si apriva, urlava di andar via dalla strada, e senza busta né riguardo, fette rosse e succose di anguria volavano nel vuoto come goffi elicotteri, schiantandosi fragorosamente sull’asfalto cinque piani più sotto, lasciando una scia appiccicosa. Perché lui, spesso, mangiava solo una parte; così i resti, gli avanzi che piovevano dal cielo, rimanevano a marcire sulla strada polverosa finché qualcuno non li spazzava via o finché i gabbiani, attratti dal tanfo acre, non venivano a banchettare. D’estate, con il caldo torrido, l’odore diventava così intenso da rendere impossibile affacciarsi al balcone.
Un giorno, quell’uomo singolare sparì. Nessuno lo vide più, e con lui svanirono anche i resti di cibo e gli stormi di gabbiani che stazionavano nei paraggi. Forse, visto la sua indole, fece un ultimo lancio, come un disperato rifiuto umano si sarà gettato da una rupe.
Strana, a suo modo, anche la signora del secondo piano. Superata la sessantina, viveva sola, la porta sempre chiusa, nessun visitatore. Giorno e notte, un lamento straziante rompeva il silenzio del palazzo: «Aiuto! Me sent’ male». Ma non sembrava esserci nulla di rotto, nulla di veramente malato. Era solo un grido solitario, un disperato bisogno di essere ascoltata, di sapere che qualcuno si accorgeva della sua esistenza. Almeno una volta al mese, le sirene di un’ambulanza squarciavano l’aria, portandola al pronto soccorso da cui, dopo nemmeno un’ora, tornava a piedi, spesso aggrappata al braccio di qualche vicino malcapitato che, compresa la messinscena, cercava in ogni modo di liberarsi da quella presa avida di attenzione.
L’ultimo degli eccentrici abitanti della Casamatta era il mio dirimpettaio, al primo piano. Viveva come un eremita con le persiane sempre abbassate, estate o inverno. Ma un caldo giorno d’agosto del 1956, la sua figura apparve improvvisamente dalla finestra, la voce gli tremava dalla rabbia mentre urlava di fare silenzio a delle persone che, in strada, discutevano animatamente. Parlavano dell’Andrea Doria, il transatlantico italiano affondato nell’Oceano non lontano da New York. La controversia, tra loro, si incendiò in un crescendo di accuse e recriminazioni che risuonarono tra le pareti del palazzo e la strada sotto. Ricordo il vociare concitato, i gesti scomposti, le bocche spalancate che vomitavano parole furiose, gli occhi iniettati di collera, le mani che sbracciavano freneticamente. Un pandemonio tale che persino un sordo, osservando quei corpi tesi, avrebbe potuto percepire l’intensità della disputa. Uno degli uomini, esasperato, gridò in dialetto napoletano: «Scinne si sì n’omm’, mmece ‘e t’ affaccià».
L’inquilino rispose con altrettanta veemenza, con la voce strozzata, che era un uomo, eccome, ma che non sarebbe sceso. E se non lo faceva, era solo perché non voleva rovinarsi la vita più di quanto non lo fosse già. Aggiunse, con un tono di sfida malcelato, che, se non fosse stato per questo, sarebbe sceso in strada armato di bastone, come si usava fare nei quartieri popolari dove era cresciuto, ben diversi da quel luogo che, a confronto, gli sembrava quasi borghese. Le solite frasi che l’ira fa urlare, quando la ragione si annebbia. Ma l’inquilino continuava a gridare e la voce che si era alzata fino a spezzarsi in un singhiozzo disperato, un grido di pianto che rivelava un abisso di sofferenza interiore. Allora gli uomini in strada, toccati da quella fragilità improvvisa, gli chiesero con un tono più amichevole come si chiamasse. Ma lui, con un sussulto di orgoglio ferito, rispose con un rifiuto categorico in dialetto: «Nun t’ ‘o dico comme me chiamme, nun t’ ‘o dico!».
«Va buono, nun m’ o’ dicere, ma mo statte calmo», replicò uno degli uomini, cercando di stemperare la tensione. Ma l’inquilino non smise di gridare, la sua voce rotta dal pianto continuava a echeggiare tra le pareti del palazzo. Ormai tutti ascoltavamo con un misto di compassione e tristezza. Poi, improvvisamente, il cielo si aprì e iniziò a piovere. Gocce grosse e fitte spazzarono via la gente dalla strada, e un silenzio quasi irreale calò sul quartiere, ovattando ogni rumore. Il signore del primo piano, come in trance, aprì tutte le finestre del suo appartamento e si mise a fissare la pioggia battente, quasi volesse purificare con quella cascata d’acqua il suo dolore. Ero appena rientrato in casa quando udii un rumore, un colpo secco che ruppe la quiete. L’inquilino aveva smesso di lottare con i suoi demoni interiori. Ai primi di settembre, suo figlio fece ritorno. Scoprimmo, con un sussulto di tristezza, che era un membro dell’equipaggio dell’Andrea Doria. Il pover’uomo, consumato dall’angoscia per non aver avuto notizie del ragazzo per troppo tempo, era stato sopraffatto dalla disperazione, e aveva sfogato la sua ira urlando contro gli uomini in strada e, soprattutto, contro sé stesso.





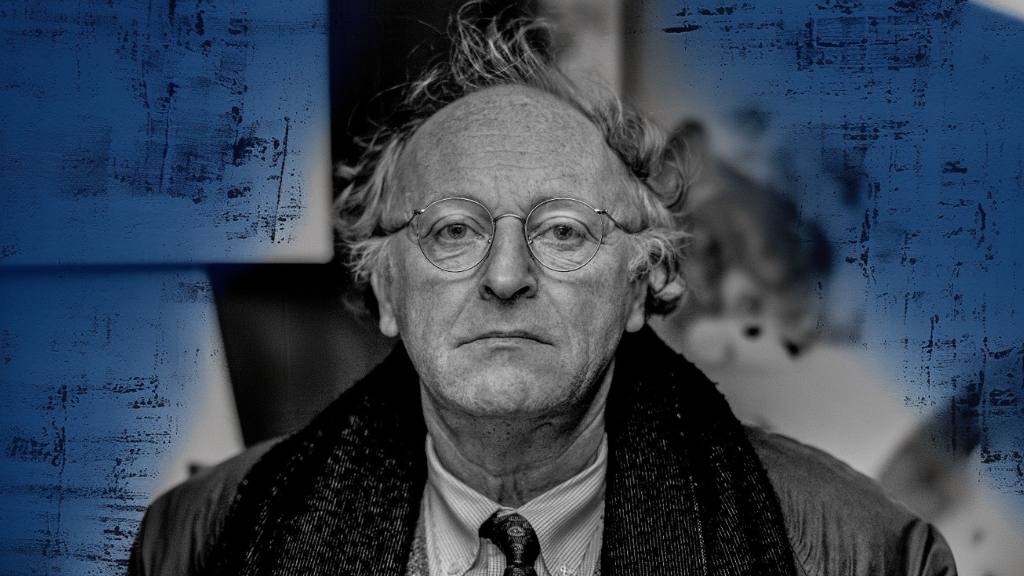







Enrico Maria Pierpaoli (proprietario verificato)
G R A Z I E !
Abbiamo raggiunto 250 copie.
Enrico Maria Pierpaoli (proprietario verificato)
Grazie Luca per le tue parole così gentili e sincere! Sono davvero felice che l’anteprima del mio libro ti abbia catturato e che tu abbia apprezzato la scrittura e le immagini. La tua stima e fiducia significano molto per me. Spero di poter continuare a regalarti emozioni con la lettura completa del libro! Spero che leggerai il resto senza dover stare a letto!
Luca Vita (proprietario verificato)
Grazie ad una lieve influenza che mi trattiene a letto ho potuto leggere l’anteprima del tuo libro, ti confermo stima e fiducia, mi ha preso senza riuscire a fermarmi nella lettura, scorrevole e denso allo stesso momento, mai scontato e ricco di immagini schizzate o definite ma sempre con modo sapiente e opportune a trasmettere il momento. Bravo, davvero bravo.