Gli introdotti, gli iniziati stavano in mezzo a soubrettes
e subrettine con ostentata disinvoltura, offrendo caffè
e Coca-Cola, col volto di chi sa come fare
e che a un certo punto dice: “Be’, fuori ho la macchina,
si può andare da qualche parte”.
Molti gruppi di giovani affollavano il bar negli intervalli
tra spettacolo e spettacolo, attirati dal mito
del varietà e delle sue vissute e facili abitatrici.
La ribalta era quella di un cinema-teatro rionale e
su di essa l’eterna barzelletta del marito cornuto e lo
scoscio delle ballerine strappavano da sempre qualche magra
risata e qualche rado battimani, nel buio
sordido della platea.
Più spesso, un sarcasmo urlante e sibilante irrompeva verso
palcoscenico e inseguiva fin tra le quinte
qualche danzatore dall’andazzo troppo apertamente
femmineo, oppure rincorreva implacabile il fluttuante deretano,
con triplo riporto, di certe ballerine, recante i
segni di una ormai lunga carriera.
È un pubblico severo quello dell’avanspettacolo,
con i suoi gusti e le sue preferenze: vuole essere
divertito, eccitato per quel che paga.
Sa di pagare poco e di non poter pagare di più e si
piglia quello che gli è destinato, ma non passivamente;
emette le sue condanne, decreta i successi, anche
se modesti, settimanali.
Si instaura tra platea e ribalta un rapporto con
una dimensione precisa.
Il balletto serve ad eccitare, a far vedere gambe,
deretani, poppe che devono sapersi presentare con
una loro sobrietà e consapevolezza.
Appena però sguscia da questo schema, con qualche pretesa
decorativa o “artistica”, il pubblico nereggia,
fischia, disapprova e si leva sublime il supremo
atto di critica popolare: la pernacchia.
Questo è il rapporto tra pubblico e scena: un rapporto
scannato che cessa bruscamente con l’ultimo
chiudersi del tendone, dopo la duplice galoppata finale in passerella.
Nel bar appresso invece fiorivano altri rapporti.
Una voce commentava: «Com’è taciturna la tua
amica, Spery. Peccato che una bocca così bella non
dica qualcosa. Forse la nostra compagnia non le è gradita?».
La bocca bella tirava di stretto da una sigaretta a
metà sporca di rosso e gli occhi scostanti guardavano
al di là della gente seduta intorno a quel tavolo.
La Spery nominata, che era socievole e cordiale,
disse qualcosa sfiorando l’amica con uno sguardo, ma
la bocca bella non si mosse; allora chi aveva parlato si
rituffò nell’allegra ondata di battute e controbattute
che fluiva e schiumava fra le altre ballerine e gli altri
giovani che animavano il bar quella sera.
Una lunga bionda snodata faceva il verso all’amica
del capocomico, dimenandosi nei pantaloni aderenti
con le mani appoggiate ad una seggiola e assalendo
tutti con una risataccia violenta e invadente.
Ogni tanto i giovani signori si sbirciavano furbescamente,
come a dirsi che avevan le mani in pasta e
che quando volevano sfornavano.
Uno di essi, Diego, fissava spesso intento la scontrosa,
non ridendo alle battute degli altri, quasi per
farle intendere che si accomunava a lei.
Lei gli abbandonava qualche sguardo, tra il tenero
e lo sfottente, che lui raccoglieva e vagliava attento.
Dovettero pregarla per farla venire via anche lei
insieme a tutti.
Le macchine si riempirono del chiasso colorato
del palcoscenico e degli impeccabili doppiopetti dei
giovani signori, sotto le insegne già spente del cinema-teatro.
Filaron via inseguendosi verso la villa di Viscardo
Ferrati, scapolo, ippico-automobilista, erede di una
gagliarda fortuna, che lo zio gli amministrava produttivo e tollerante.
Il parco sonoro di decine di fontane, abitate da
putti neri e grondanti, accolse la bella compagnia che
fluì dai lustri sportelli spalancati per ascendere la
breve scala illuminata.
Dentro, tra divani e poltrone, su morbidi tappeti,
in un tinnir di bicchieri, la luce discreta delle abatjours
illuminava i gesti e i volti delle ballerine e dei
giovani signori.
Su quelli le origini popolari, per lo più campagno-
le, vi apparivano scomposte e grosse di sotto ai ceroni
e al rimmel; su questi era impressa, non senza le sfumature
d’una superiore ironia, un’espressione giocosa e soddisfatta,
come di bambino che ha tra le mani
un balocco divertente dal funzionamento facile.
L’anfitrione aveva illuminato il suo bar ricco e selezionato
e tutti attingevano nel caldo di un’atmosfera
sempre più movimentata e chiassosa, in cui si diffondeva
invadente dal grammofono una musica americana dalla straziata sezione ritmica.
Vera, la scontrosa, guardava con sussiego le altre
agitarsi a parodiare i numeri che eseguivano in palcoscenico.
Diego si era avvicinato alla sua poltrona senza
guardarla e si era seduto sul tappeto accanto a lei,
mentre Ada, la bionda snodata, si contorceva in mezzo
alla sala in una spasmodica ritmata convulsione, e
gli altri, interrompendo gli inseguimenti, le battevano
intorno le mani, come si vede nei film.
Con la finzione di una tragica sofferenza s’era sfilata
la maglia e si accarezzava i seni, scuotendo il bacino ad un ritmo vertiginoso.
Tutt’intorno fiorivano gli idilli più palperecci.
Diego aveva avvicinato il capo al ginocchio di
Vera e stava per posarvelo, quando una botta violenta
a mano aperta lo colse tra l’orecchio e il collo. Rimase
indifferente, ma internamente trasecolò. Volse piano
la testa fissandola. Lei lo guardava dritto con un’espressione impenetrabile.
Si sentì eccitato da quello sguardo e mentre ci
riprovava, un altro colpo lo raggiunse in pieno volto
e poi un altro e un altro ancora; allora si ritrasse con
lentezza e sentì un sottile piacere, come se quel dolore
facesse meglio pregustare la desiderata pietanza al
suo difficile palato.
Si rimise seduto a covarsi quel futuro rapporto
che già idealizzava.
Appena a Diego interessava una donna, ne traeva
i tratti che più lo avevano colpito e con essi costruiva
un’immagine che perdurava finché i fatti nel loro
svolgersi non la smentivano e cancellavano.
Nel frattempo, però, se la donna in questione compiva
qualche gesto o diceva qualcosa che coincideva
con l’immagine creata, allora spirito e corpo di Diego
si sublimavano nell’estasi più protesa e galoppante.
Pur dotato di un occhio disincantato per le emozioni
degli altri, era sempre disposto alle più ampie
concessioni verso i propri rigurgiti emotivi per poi
precipitare e crogiolarsi nella nausea più feroce.
La sua eleganza nel vestire, il suo viso sottile sotto
una morbida capigliatura dorata gli costava mille accorgimenti
durante la toilette mattutina. Il suo tratto
gentilizio, che s’era pazientemente costruito, aborrendo
la figura del padre che si inseriva invece nella
più fiorente e ridondante tradizione mercantile, gli
aveva fruttato il soprannome di “vero signore”.
Il “vero signore”, duramente percosso ai piedi della
ballerina, gioiva chiuso nel suo impeccabile panciotto
mentre, intorno, tutti si esibivano nella celebre
ed esausta imitazione di Salomè.
Ada teneva sempre banco e nei suoi scotimenti
disperati aveva disseminato per tutta la stanza indu-
menti che s’era andata strappando di dosso come se
scottassero.
Era rimasta con le calze a rete, che incominciava
ora a sfilarsi in preda ai sobbalzi di un’ultima disperata
agonia, mentre la gente muta attorno attendeva
impaziente di buttarsi sulla preda.
Le voci gridavano: «Brava! Brava!», con un entusiasmo forzato
nel battere le mani. Il tutto precipitò
in un frenetico calar di brache, peraltro di morbido
pettinato, e in mille stridi consenzienti e ridanciani.
Si moltiplicavano allegramente i connubi tra i
giovani signori e le figlie della campagna veneto-emiliana,
che la ribalta aveva innalzato alla gloria di quei
divani e di quei soffici tappeti.
Dopo i primi spasmi di liberazione, però, colavano
gelide le barriere delle risate signorili, sui modi grossi e
sulle goffaggini popolari delle molto amabili, e, al
plauso di prima, si sostituiva inevitabile uno scherno
soffuso che accarezzava ormai soddisfatto le molto
amate.
Il “vero signore” assisteva a tutte le esibizioni
sempre seduto ai piedi della sua scontrosa ballerina
e ogni tanto sogguardava la mano colpitrice, che stava
appoggiata sul bracciolo della poltrona.
Era una mano solida e fortemente unghiuta con
un che di rozzo e disperato, che affascinava Diego.
Da quella mano era andato pian piano costruendo
il carattere della donna e già si vedeva vivificato dal
rapporto con lei, dal suo orgoglio leonino, da quella
tempra che secondo lui si rivelava così adamantina,
così crudelmente essenziale.
Stava pregustando l’attimo-chiave che finalmente
li avrebbe buttati l’uno nelle braccia dell’altra e
intanto diceva qualcosa pacatamente, accennava a qualcuno
senza guardarla, accusava sempre più la vicinanza
fisica di lei.
Sentì giungere dal profondo l’empito disperato
che invoca l’allacciamento travolgente e mentre si
protendeva commosso per lo spasimo dell’attesa, un
altro colpo più violento degli altri lo colse sull’occhio
morbido.
Quel contrattempo non previsto lo fece precipitare in una
crisi isterica; balzò in piedi di scatto e
scaraventò un bicchiere contro il muro, urlando
all’irrazionalità di quella donna: «Pazza! Nevrastenica!
Presuntuosa!».
L’unghiuta essenziale, che veniva dalle eroiche
ma ingenue rive del Piave, si spaventò a quello scroscio
di sdegno gentilizio, che prorompeva dal bel panciotto
impeccabile per irradiarsi su, su, fino al vibrare
delle mani sboccianti dai candidi polsini, chiusi da
due aurei gemelli di squisita fattura.
Il “vero signore” infuriava, impazzava, fulminava
l’aria della sua giusta ira fra lo stupore dei gaudenti.
Vera, attonita, cercò di avvicinarlo sotto lo scrosciare
della stizza, ma venne duramente scrollata e
respinta.
Il suo gioco degli schiaffi era stato protratto troppo
a lungo e il gentiluomo accecato dal dolore fisico,
che quella mano campagnola gli aveva procurato, era
irrimediabilmente esploso.
Vera, con larghe ammissioni della sua colpa, tanto
tentò e fece che riuscì a placarlo fino a commuoverlo
con la sua radicale flessione d’atteggiamento.
Il desiderio vinse lo sdegno, che per altro la forte
mano unghiuta era andata a poco a poco ammansendo. La cara
immagine di prima andava lentamente rifiorendo agli occhi del “vero signore”.
La danzatrice si donava nella sua semplicità, quasi rozza,
ma tanto aggressiva, tanto essenziale.
Dopo il primo sfogo d’amore, Diego s’affrettò a respingere
la spiacevole sensazione di selvatico che gli
dava ora la sua Salomè. Gli appariva adesso più nella
sua rozzezza che nella sua essenzialità.
Vera lo pregava di dirle il suo amore,
accarezzandolo affettuosa, un po’ invadente.
«Dimmi che mi vuoi un po’ di bene, tesoro. Perdonami
per prima…» gli andava soffiando nell’orecchio
tristemente, quasi cupa.
«Io ti credevo come gli altri. Questa gente mi fa
schifo, mi fa schifo il mio mestiere. Voglio uscirne, sì.
Adesso non so come, ma ci riuscirò.»
Gli prese la faccia tra le mani, cacciandogli gli occhi
negli occhi, e disse in un soffio: «Ho tanto patito.
Se tu sapessi!».
Il “vero signore” arricciò impercettibilmente il
naso a quello sfogo troppo impetuoso, a quella
aggressione verboso-sentimentale, ma non poteva più
tirarsi indietro al momento, se non voleva rischiare di
lasciare a lei la parte primaria della recita.
Le accarezzò i capelli con uno sguardo lontanante,
mentre mormorava in una tonalità fonda: «Io ti capisco,
amore, anche se ormai non sono che un fantasma».
Come se la parola lo avesse evocato, sfilò un breve
corteo di belle anime, avvolte in lenzuoli e coperte
rosse che mal ricoprivano stanche nudità scosse da
lunghe risate intonanti nenie sepolcrali, in un
linguaggio apertamente inguinale.
Era una frase, quella del “vero signore”, che, nel
frangente, voleva una spiegazione, ma Vera non la chiese,
riconducendo anzi il discorso sulle sue sofferenze.
Abituata ai rapporti scarni che le offriva il mondo
da cui veniva e a quelli scannati; di quello in cui era, le
piaceva poter intonare il suo canto di dolore con quel
giovane raffinato, che pareva stenderle una mano
gentile al di sopra dell’abisso che separava i mondi di
ciascuno dei due.
Intanto il giovane raffinato ascoltava, rincresciuto
non poco che il suo discorso fosse stato troncato,
finché una breve pausa della sconsolata interlocutrice gli diede il la della ripresa.
«Ti dicevo, cara» intonò a sua volta «in confronto a
te io mi sento un fantasma, una cosa senza vita. I miei
amici, i miei familiari sono tutti vuoti fantasmi.
Tu soffri, godi, piangi, ridi: sei in una realtà più vera, ma noi
non siamo niente, non sappiamo che cosa sia la vera
vita e ci muoviamo sempre in un buio senza speranza.
«Io sento che avrei potuto essere vivo, essere utile,
ma non sono stato capace di rinunziare, di tagliare
netto, di evadere per sempre.»
Vera s’era improvvisamente incupita, come prima
di dargli gli schiaffi, e fissava per terra con gli occhi
duri e appena un accenno di scherno sulla bocca forte.
«Tu però non sai cosa sia non avere i soldi per il
necessario» replicò senza recitare.
Era una frase banale che Diego poteva aver udito centinaia
di volte, ma in quel momento sentì veramente quanto
non potesse capirla, quanto non l’avesse mai capita.
Guardò Vera nelle sue grosse, fiorenti forme di
campagnola, che lei abbandonava dimessa alla sua vista.
Una delle sue impennate sentimentali lo portò a
pensare che ci doveva essere la possibilità di varcare
l’abisso. La strinse teneramente mormorandole frasi
insinuanti, parole mozzate dai baci.
Lei si lasciava prendere, sussurrando all’infinito
il nome di lui.
Si lasciarono all’alba sotto la pensione di Vera in
un ultimo stanco bacio, poi Diego filò via sulla sua veloce automobile.
La luce gelida della città al risveglio e la bocca
amara di troppe sigarette fugaron via dall’animo di
Diego certi propositi, stimolati dalla sua danzatrice,
e un morbido letto alfine accoglieva il “vero signore”,
stanco di una lunga notte d’amore.
Come l’alba fredda era amica della ragione, così il
tardo risveglio era, per Diego, l’alleato della fantasia e
dei suoi voli sublimi.
Quel giorno pensò spesso a Vera e la paragonò tacitamente
a certe conoscenti e amiche che ebbe modo
di incontrare.
Mancava della loro raffinatezza, del loro buon gusto,
ma aveva in sé un impeto vitale, una sincerità
disadorna che gli pareva la facessero grandeggiare.
Giunto alla vetrina della trattoria dell’appuntamento,
la vide seduta ad un tavolo con un giovane dal
viso rosso e bruno su una camicia scura senza cravatta.
La guardò a lungo muovere concitata le sue grosse
labbra accompagnate dai gesti della sua mano forte,
finché lo sguardo fondo di lei non incontrò il suo.
Diego fece un cenno di saluto con la mano e si voltò
rapidamente andandosene, ma Vera aveva già raggiunto la porta e lo inseguiva.
«Diego, ti spiace per quello dentro?» gli disse
fissandolo, quando l’ebbe raggiunto.
«Ma io non ti ho chiesto nulla» le rispose Diego con
un sorriso stupito, soffocando una già morente stizza.
«Perché te ne vuoi andare, allora?» replicò lei
sommessamente.
Diego non rispose subito; si accese una sigaretta e
incominciò lentamente a camminare con Vera che gli
stringeva il braccio quasi con disperazione.
«Vera,» fece senza guardarla «me ne voglio andare,
perché non si può sempre stare solo a letto.»
«Lo sapevo» fece lei con il nodo alla gola «che sei
venuto con me solo per stare a letto e adesso dici così
perché ci sei già stato.»
«Tu dici delle cose» riprese Diego spazientito,
come se non l’avesse udita «che io non so capire e io
dico cose che tu non sai capire. Attraverso di me
parlano mille fatti e persone che non conoscono nulla dei
mille fatti e persone che parlano attraverso di te. Io ho
pensato di poter saltare l’abisso.»
Diego parlava più a se stesso che a Vera. «Ma
purtroppo non è che ci sia io da una parte e tu dall’altra:
l’abisso siamo tu ed io, l’abisso è il nostro rapporto,
noi come ci guardiamo, noi come ci parliamo.»
«Ma io sento che ti posso voler bene e che te ne
voglio già» replicava Vera stringendolo di più.
Diego si fermò a guardarla e non seppe trattenere
un riso stupido e stridente.
Vera strinse di più il braccio di lui come per farlo
smettere.
«Tu non hai capito» le disse allora lui con durezza, smettendo di ridere.
Vera, sentendosi addosso quello sguardo gelido
e scostante, mollò la presa, mentre sentì che Diego,
in quel momento, la ricopriva di un disprezzo che le
sembrava ingiusto e una collera disperata le guidò la
mano forte e unghiuta a colpire per l’ultima volta il
viso impassibile del “vero signore”.
Egli la salutò con un piccolo inchino risentito e
goffo, sparendo dietro la portiera sbattuta.
L’altro mondo, quello al di là dell’abisso, era fuggito da lei rombando.
La mano gentile sull’abisso si era ritratta, ma
qualcosa era cambiato.
Vera lo sentì quella sera all’ultimo spettacolo,
mentre il pubblico applaudiva, fischiava e rideva nel
buio della platea; il suo mondo di tutti i giorni.
All’uscita del teatro, Ada l’aspettava con due
uomini distinti che offrirono da bere e le invitarono a
casa d’uno di loro.
Questa volta Vera fu molto cortese e socievole; si
ricordava persino di certe belle parole che aveva sentito da Diego e le usava con disinvoltura.
22
Quello dei due signori che le era destinato le moriva dietro e la riempiva di complimenti e frasi affettuose. Quando si giunse alla situazione conclusiva
Vera si irrigidì improvvisamente, mentre lui la guardava preoccupato e interrogativo.
Allora lo fissò dritto con un sorriso tirato.
«Quanto mi regali?» gli chiese teneramente, un
po’ rauca ma decisa.
Il signore chinò la testa, incupito. Vera si alzò di
scatto dal letto rassettandosi.
«No, vieni qui» si affrettò lui a chiamarla.
«Ti prego» aggiunse, perché lei lo guardava senza muoversi.
Vera allora gli tese la mano aperta, in attesa.
Il signore trasse un lungo sospiro e mise mano al portafoglio, che aveva estratto dalla giacca appesa alla sedia.
Posò una banconota sulla mano aperta, ma la
mano non si mosse, allora ne mise un’altra e un’altra.
Vera andò a cercare la borsetta, vi ripose il denaro
con cura e tornò verso il letto sfibbiandosi la gonna.
«Lo sai che hai delle belle ciglia?» disse affettuosa
al suo ospite, accarezzandogli il viso con la mano forte
e unghiuta.


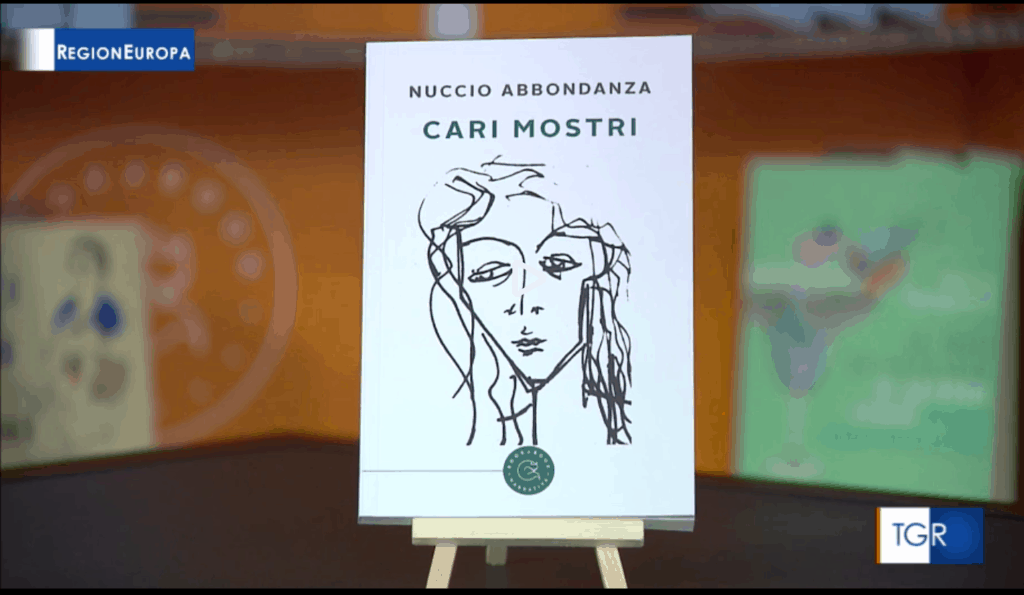
Commenti
Ancora non ci sono recensioni.