di Mozart, allora buona lettura.
Forse vi chiederete il motivo del titolo di questo libro:
lasciare andare a pensieri e riflessioni. Spero che queste righe
possano farne scaturire altrettante su quanto ci circonda e su
quello che c’è all’interno di ciascuno di noi, sul fuori e sul
A volte non servono grandi risposte ma solo giuste domande
(questa l’ho letta da qualche parte, lo ammetto, non è mia).
Infatti, una domanda frequente che ci si fa quando si arriva
alla soglia dei quarant’ anni e si sta ancora pensando se sia
giusto o meno avere una famiglia, e se valga la pena mettere
al mondo dei figli, è la seguente: quanto incide l’educazione
dei genitori sulla formazione del carattere dei propri figli, sui
loro valori e sul loro percorso esistenziale e quanto invece
è il semplice risultato di una combinazione genetica? Come
spesso accade, forse la risposta sta nel mezzo: in parte, quello
che tuo figlio sarà è il risultato dell’educazione dei genitori, in
parte è il semplice, ineluttabile e insondabile effetto del caso
o, se vogliamo metterla in termini scientifici, dell’effetto di
combinazioni genetiche, le quali possono sancire il fatto che
tuo figlio sarò uno stronzo in carriera o un insicuro sfigato o,
ancora, un farabutto poco di buono con il beneplacito dei genitori,
i quali, oggi, sono sempre più propensi a prendere le
difese di figli indifendibili.
Nel mio caso, posso ritenermi fortunato: la mia è stata
un’infanzia felice in cui non mi è mancato mai nulla,
ero circondato da amici e dall’affetto di genitori e nonni, e sempre
al centro di ogni attenzione. A pensarci bene, la vita era
davvero una “cake walk”: bastava non fare incazzare troppo mia
madre, portare a casa voti decenti ed evitare di farsi beccare
in flagrante dai “tutori dell’ordine” quando si commettevano
marachelle – fossero questi professori, preti o vigilantes di
quartiere. Alla fine, si poteva fare tutto (o quasi) godendosi
la libertà e la spensieratezza dell’essere fanciullo. Nessun
periodo è tanto gaio: nessun senso di colpa, scoperte continue,
amicizie solide come fortezze, i primi amori, scherzi e risate,
movimento, complicità, leggerezza.
Per molti bambini che nascono in certi Paesi, l’inizio del
viaggio non è altrettanto spensierato, e spesso è la violenza
dentro e fuori le mura domestiche a caratterizzarne lo sviluppo:
se è vero che i bambini apprendono per osmosi dal
comportamento (e dai valori) dei propri genitori, pensate
alle conseguenze che questo comporta nei figli di genitori
violenti o peggio.
Che sia stato un bene o un male non sono in grado di dirlo,
ma quello che so è che sono cresciuto in un ambiente protetto
e pieno di affetto, con due genitori che non mi hanno mai
fatto mancare niente ma che hanno saputo impartirmi valori
come il rispetto, la tolleranza, il rigore e il senso di responsabilità.
Tutto ciò ha avuto chiaramente il classico rovescio
della medaglia: quando l’incantesimo si spezza e la carrozza
di Cenerentola torna a essere una grande zucca, la disillusione
è forte e toglie il fiato come un pugno in pancia. Perché arriva
sempre il momento in cui si passa dalla spensieratezza
del fanciullo all’insicurezza dell’adolescente (e dell’adulto),
come se quel meccanismo, così ben oliato di affetti dovuti e di
regole precise, tutto a un tratto si inceppasse, e a quel piccolo
orticello si aprissero i confini, lasciando la parola al libero arbitrio,
al senso di colpa e alla responsabilità. Vengono così a
mancare i punti di riferimento: i genitori si separano, i nonni
muoiono, i buoni voti non bastano più, le scelte si fanno difficili
e certi treni che passano non tornano indietro; ma questo
lo scopri dopo, e quando lo scopri non sei mai pronto.
Una delle persone che ho più amato e stimato quando ero
piccolo è stato mio nonno materno: una persona dall’animo
semplice e gentile, una persona buona, generosa, sempre
disponibile. Tantissimi sono i ricordi che ho di lui e tutti belli:
le colonnine di duecento lire che teneva in mano e che faceva
tintinnare per avvisarmi che era arrivata l’ora della sala
giochi dopo la spiaggia, il momento di infiascare il vino con
quelle damigiane pesanti, il commento del giornale che leggeva
tutti i giorni, i pomeriggi durante i quali ci preparava (a
me e a mia sorella) il risotto giallo o le castagne, e,
soprattutto, la felicità che sprigionava quando sapeva che avevo
preso un buon voto a un esame, vinto una partita di basket
o che ero uscito con una bella ragazza. Insomma, mio nonno
era un uomo che dava per quello che era, senza giudicare ma
sapendo infondere sicurezza e il giusto senso del dovere. Un
uomo di altri tempi, forse.
Erano tanti i momenti felici di quegli anni Ottanta in cui
Milano sembrava non fermarsi mai, sull’onda del boom
economico e degli sfarzi: volente o nolente sono cresciuto in quel
mondo, estasiato dai giochi e dagli show in TV, sempre in
compagnia di amici, senza conoscere il dolore, la disperazione
e la solitudine. Con mia sorella litigavo spesso ma eravamo
anche grandi compagni di giochi e di intrighi; insomma, era
un divertimento continuo. La domenica dopo la messa c’era il
rito delle figurine, poi le partite alla radio e, alla sera, la
cena dalla nonna che preparava un sacco di leccornie, infine
si guardava Drive In. Oggi, il massimo dell’aspirazione
domenicale è la corsa al parco o la spesa al supermercato (sì, aperto
anche di domenica), sperando di incontrare la vicina carina,
che se ti saluta è già un successo.
Non si gioca più, non si fanno comizi al bar e non si comprano
più le figurine all’edicola; si fanno, però, scommesse online
(o in squallide ricevitorie), si chatta di continuo di banalità e
si postano foto felici di sé e dei propri figli su Facebook o su
altri social network (che sono, praticamente, una vetrina del
proprio egoismo). In quest’epoca, l’unico valore è l’identità
della massa in cui ci si annulla, dove ci si sente protetti e al
sicuro – nel nome di ideali che un nome non hanno più –, votati
solo al dio denaro e al dio potere. Adesso bisogna apparire,
essere presenti e costantemente aggiornati e reperibili; non c’è
più spazio per la riflessione, la lettura, il gioco o lo scambio.
Il tempo passa e dal posto finestrino si osservano gli anni
Novanta: le scuole medie segnano due momenti importanti,
fondamentali nella mia vita: la scoperta dell’altro sesso
(in senso più teorico che pratico) e la scoperta della musica
(mia madre mi convince a iscrivermi alla sezione musicale e
comincio a studiare la chitarra classica). Nel frattempo,
nel mondo, cadono il muro di Berlino e l’Unione Sovietica, e
scoppia la guerra nel Golfo: la prima che seguo in TV.
La mia classe – la mitica Terza B – va alle finali dei
Giochi della Gioventù con la squadra di pallacanestro e, poco dopo, a un
concorso nazionale per orchestre, piazzandosi al terzo posto.
Tanti interessi, poco tempo, giornate vissute al massimo
senza un attimo di tregua, sentimenti nuovi che non si sa
ancora come gestire, ma nessuna ansia perché tutto è nuovo,
impetuoso e, soprattutto, spontaneo.
Ma torniamo indietro di qualche anno: quelli delle elementari
con le partite a pallone al campetto, gli scherzi con
gli amici, i cartoni animati, i compiti, le feste con fantastici
panini al latte imbottiti e torte pannose, gli spaghetti della
mamma con il sugo fatto in casa, e soprattutto lei, la prima
fiamma, con quelle guance paffuttelle e quei capelli biondi e
gli occhi azzurri. È proprio vero che la prima fidanzatina non
si scorda mai, se poi ha un nome francese, tutto diventa ancora p
iù intrigante e romantico! Avrei dovuto capire fin da
quel momento che il percorso di avvicinamento all’universo
femminile non sarebbe stato semplice, per uno timido e non
particolarmente bello, è un vero calvario emozionale, fatto di
dubbi continui, mancanza di autostima e paure di essere respinto.
Ricordo ancora oggi la sua stanza con le bambole, il
mio impaccio alla sua festa di compleanno (dove arrivai con
la faccia gonfia dopo averla battuta contro il muro mentre
correvo in casa perché, appunto, in ritardo per la sua festa),
il terrore quando toccava a lei girare quella bottiglia di plastica
di Coca-Cola – il famoso gioco della bottiglia ha creato
sicuramente una stirpe di giovani traumatizzati – e la gelosia
che avvampava se dava un bacio a qualche altro ragazzo. Ero
consapevole di quanto fosse meschino essere invidiosi e gelosi,
ma, allora, ero orgoglioso di provare per la prima volta
queste emozioni per una bambina. Non sapevo ancora quanto
dolore, quanti pensieri, quante amarezze avrebbe causato la
stessa cosa negli anni a venire! Eppure, rimpiango tutt’oggi
la genuinità profonda di quel sentimento che ancora non si
chiama amore e che è troppo pudico per essere connotato da
vere pulsioni sessuali; un’emozione tipica esclusivamente di
quel periodo, di quella fanciullezza che non pensa ai “se” o ai
“ma”, tantomeno alle conseguenze di un bacio.
Sono i mitici anni Ottanta: quelli del Moncler e della Naj-Oleari,
dello zainetto Invicta, delle Big Babol e del Pongo, del
Corriere dei Piccoli, delle figurine Panini, del Billy e dei biscotti
Oro Saiwa (la mia merendina preferita, con le vignette di Snoopy
incise sopra), dei telefoni a gettoni, delle sale
giochi con le duecento lire, delle rosticcerie e del Burghy, del
Drive In e di Colpo Grosso (ma forse questo è venuto dopo),
degli autoscontri e del Grillo Parlante, del Monopoli e
dell’Allegro Chirurgo, di E.T. – L’extraterrestre e di Guerre Stellari,
di Lupin e l’Uomo Tigre… insomma, tutto aveva un fascino
particolare e veniva condiviso con amici, compagni di scuola e
con una sorellina che negli anni sarebbe divenuta la mia
unica confidente, sangue del mio sangue, con cui condividere
gioie, speranze e dispiaceri.
Il tempo vola e si aprono le porte del liceo (scientifico), si
scrive un nuovo capitolo di amicizie, amori (quasi mai ricambiati),
sport e musica; finché la pagella è buona, quasi tutto
è concesso. Si rientra un po’ più tardi il sabato sera, si va in
gita scolastica fuori dalla città, si sperimentano il sesso e la
musica di ogni genere. I primi anni Novanta sono gli anni dei
Queen (quante volte avrò ascoltato la cassetta di Innuendo!),
di Tina Turner, Phil Collins, Elton John e – su tutti – del grande
Joe Cocker (senza tralasciare gli italiani Litfiba, Luciano
Ligabue, Vasco Rossi, Jovanotti e Zucchero). Le loro canzoni
sono sempre presenti, nastri di musicassette che continuano
a girare, a fare da sottofondo a giornate interminabili sui libri
ma anche al rientro dal campetto da basket o da tennis.
Sì, perché come la musica, anche lo sport ha sempre avuto un
ruolo determinante nella mia adolescenza: tennis, nuoto, calcio,
pallavolo, football americano, atletica, ma soprattutto il
basket e, in modo particolare, quello d’oltreoceano, seguito di
notte e commentato dal grande Dan Peterson, quando in campo
c’era un giocatore destinato a cambiare la storia di questo
sport: Earvin “Magic” Johnson. La fantasia, la tecnica e il
sorriso del numero trentadue dei Los Angeles Lakers restano
indelebili nella memoria, così come quel tragico annuncio
in cui dichiarò al mondo intero di essere portatore del virus
dell’HIV (Human Immunodeficiency Virus, Virus dell’immunodeficienza
umana). Il bello di essere giovani è che si crede ancora nei miti
– sportivi e non –, sognando, un giorno, di
poterli eguagliare. A pensarci bene, era impossibile, tuttavia,
pensare di eguagliare Magic, ma portare la maglia con il suo
numero al campetto ti spronava a dare il massimo, come se, a
fine partita, a giudicare il tuo gioco, il tuo rendimento in campo
e i tuoi sforzi per la squadra ci fosse stato davvero lui.
Poi succede che un giorno ti alzi e scopri che Magic ha
contratto l’AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome, Sindrome
da immunodeficienza acquisita) da una prostituta, che
il tuo migliore amico ci prova con la ragazza che hai puntato
tu e non ha il coraggio di dirtelo, che il giorno prima della gara
di sci ti spezzi la tibia di netto, che i tuoi genitori si separano
e che Dio è morto (o non c’è mai stato)… Alla fine, ti accorgi
che la vita non è come la vorresti tu, non è come dovrebbe
essere per chi ha sempre fatto i compiti a casa e conseguito
buoni voti, per chi si è comportato sempre in modo educato
nei confronti del prossimo. Crollano i miti e i valori, la fede
vacilla, la vita non è giusta, nessuno è lì fuori a proteggerti e a
rincuorarti se le cose vanno male.
Insomma, la pacchia è finita, il Lato Oscuro (per dirla con il
linguaggio di Star Wars) incombe, possente.
Ci sono dei momenti nell’esistenza di ciascun individuo
che potrebbero definirsi “incroci del destino”, momenti che
rappresentano nodi cruciali, attimi in cui si percepisce che la
decisione che si sta per compiere avrà conseguenze per tutto
il resto della nostra vita. Ripercorrendo a ritroso la propria
strada, spesso ci viene da domandarci «chissà cosa sarebbe
successo se in quel momento avessi fatto B invece di A», quali
interconnessioni del destino, quali incastri si sarebbero dispiegati,
quali conseguenze quella scelta avrebbe comportato
oggi su noi stessi e sul prossimo?
Sono sicuro che ognuno abbia un sacco di questi momenti
chiave nel proprio passato; nel mio, uno è stato quello in cui,
assieme ai miei genitori, dovevo scegliere quale università frequentare.
Dopo il liceo scientifico (e con un buon voto
all’esame finale), si prospettavano diverse opzioni, ciascuna
di queste con dei pro e contro per eventuali risvolti professionali.
La difficoltà era quella di conciliare i propri interessi con
le esigenze del mercato del lavoro per poter garantire un certo
ritorno sull’investimento (i costi della retta). È probabilmente
una delle decisioni più difficili e dense di conseguenze della vita
di ogni adolescente, considerando il fatto che nessuno
può indovinare come lo stesso mercato del lavoro si modificherà
nell’immediato futuro e che il metodo per superare gli
esami universitari (almeno all’epoca) è sostanzialmente
differente da quello che utilizzavi per passare le interrogazioni
– programmate o meno.
Avendo vissuto una infanzia da figlio di medici, era chiaro
che la prima scelta ricadesse proprio su Medicina: negli anni
Ottanta e Novanta, infatti, la professione medica garantiva
non solo un buon reddito di base ma anche prestigio sociale e
riconoscimento all’interno della propria comunità, o almeno
era quello che io vedevo negli occhi e nelle espressioni dei
pazienti dei miei genitori (medico generico mio padre, pediatra
mia madre). Malgrado ciò, i miei genitori sono stati i primi
a indirizzarmi verso altro: che scegliessi pure Economia o
Legge o altro, ma non Medicina, il che, all’epoca (era il 1997),
avrebbe voluto dire almeno dieci anni di studi.
Alla fine scelsi un piano di studi della Bocconi per la legislazione
d’impresa, composto da un mix di materie scientifiche,
economiche e diritto, forse perché non avevo le idee chiare su
quali di queste mi piacessero veramente, ma così fu. Sarebbe
interessante se una app o quelli che negli anni Ottanta si
chiamavano librogame – libri in cui si potevano scegliere
finali differenti a seconda di quale direzione si voleva far prendere
al protagonista a determinati bivi narrativi – ci potesse
dire cosa sarebbe successo se avessimo compiuto una scelta
diametralmente opposta a quella fatta a quell’“incrocio del
destino”! Cosa sarei diventato se avessi fatto Medicina? Uno
studente fuori corso e alla fine un medico di famiglia seguendo
le orme paterne, o un chirurgo di fama internazionale? O
altro ancora? Non lo saprò mai e forse è meglio così.
Spesso mi sento chiedere: «Ma chi te lo ha fatto fare? Cosa
ti ha spinto ad andare in quei posti lì?» (come se poi quei
posti lì fossero abitati da alieni!). Per la risposta dovrei scrivere
un libro a parte e, forse, alcune motivazioni non sono chiare
nemmeno a me. Certo è che, essendo cresciuto nella Milano
degli anni Ottanta, e non essendomi mai mancato niente,
scoprire che, in alcuni Paesi di quello che una volta si
chiamava “terzo mondo”, ci sono persone che vivono in situazioni di
guerra perenne o con meno di due dollari al giorno, non mi ha
mai fatto sentire a posto con la mia coscienza.
Chiamatelo senso di colpa o utopia giovanile, ma sta di fatto
che, nella primavera del 1999, quando ho sentito per la
prima volta Teresa Sarti, ex presidente di Emergency, parlare
davanti a degli studenti bocconiani del dramma delle mine
antiuomo e delle conseguenze di questi ordigni su civili inermi
in Iraq e Afghanistan (e, tutt’ora, in molti altri Paesi), ho
come avvertito una scossa lungo la schiena. Un richiamo, un
campanello d’allarme che suona ogni volta che sento parlare
delle vittime di guerre, malattie, povertà, e che, per fortuna,
da allora, non ha mai smesso di funzionare.

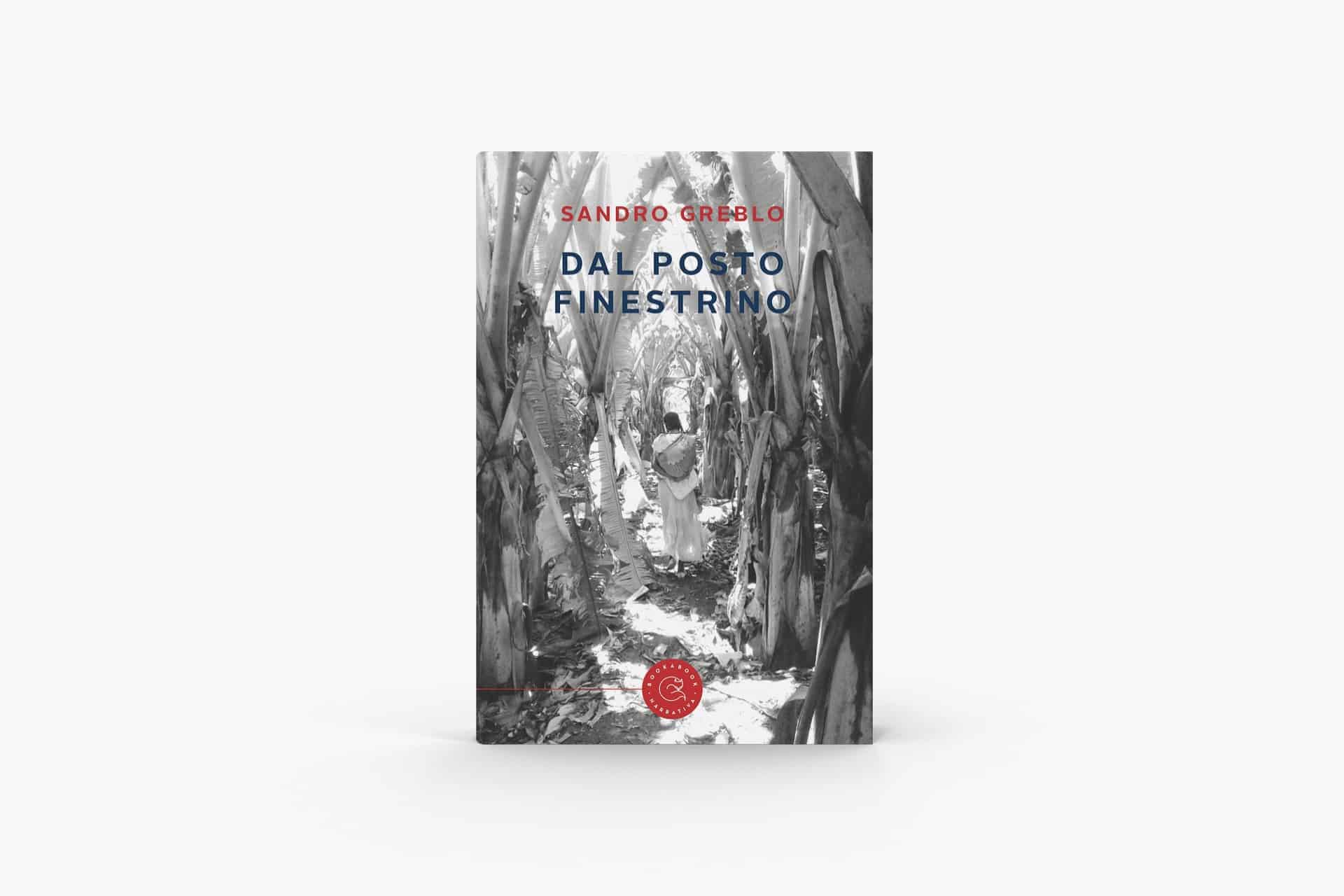



Commenti
Ancora non ci sono recensioni.