1.
Abbassai un finestrino di quei tre, quattro centimetri che bastano a far entrare un filo d’aria senza lasciare che entri anche la pioggia. Era già abbastanza umido così, lì dentro, meglio evitare di peggiorare la situazione. C’era un odore penetrante, di carta di giornale inzuppata, di stoffa bagnata, una cosa del genere. Non erano i miei vestiti. Ero montato in auto passando direttamente dall’appartamento alle cantine e, poi, ai garage, e gli abiti erano rimasti asciutti. Immaginavo fosse più che altro colpa dei tappetini, non proprio immacolati, ormai da tempo. Il miscuglio di polvere vecchia che li impregnava e di acqua di pozzanghera, portata dentro a più riprese, in quei giorni, dalle suole delle scarpe, faceva il suo effetto. Non sgradevole, ma preferibilmente evitabile. Son quei particolari che, in sé, non significano nulla, ma che possono vestire ancora più di grigio una giornata nata storta, che si somma all’umore storto di un periodo storto. Forse sul fondo della macchina, dietro e per terra, tra lo schienale del mio sedile e il resto della vettura, c’era anche l’ombrello che avevo usato il giorno prima e che dovevo aver dimenticato di tirar giù. Era fradicio e gocciolante. Pessima idea, non era da credere che la sua giacenza lì avrebbe migliorato le cose e gli odori. Tra un sospiro e l’altro annusavo. No, non era muffa, meno male. Solo una sublimazione di cane bagnato, con quella stagione di merda era normale. In altri momenti forse non ci avrei fatto caso, quella mattina, invece, sì.
L’idea di smontare dalla macchina e di entrare in quel ca-pannone infinito e senza finestre mi abbatteva. Non solo quel giorno, ma quel giorno più di quello precedente e, credevo, il giorno precedente un po’ più di quello a lui precedente, e il giorno precedente al precedente un po’ più di quello prima ancora. Ciò che si chiama una spirale negativa, riflettevo. Ed era una spirale che io, meccanicamente, disegnavo sul vetro alla mia sinistra, quello che avevo appena appena abbassato. La punta del dito incideva sulla superficie appannata un movimento ancestrale, vagamente druidico e tribale, rotatorio e, a uscire, un vortice via via più ampio e lento. Fermai il gesto e una goccia di condensa scivolò giù dal mio polpastrello, fin dove poteva scivolare, e si fermò contro la guarnizione di gomma, spalmandosi. Contemplai la mia opera d’arte quasi maori e, quando ne ebbi abbastanza, la spazzai via con il palmo della mano. La pelle emise un suono stridulo e irritante e allora la piantai lì, tanto mi fu subito chiaro che non sarei comunque arrivato facilmente in fondo a quell’ennesima giornata. Di certo non senza immolare sull’altare del nauseabondo dovere l’ennesima, piccola, frazione di me stesso. Un sacrificio. Un pezzetto ogni giorno. Chissà, prima o poi mi sarei dissolto, a furia di buttarmi fuori dalla macchina in questo modo.
Mi asciugai la mano sui pantaloni, senza che tornasse asciutta. Era fredda, inerte e nemica. La guardai un momento, ritrovando il percorso dei punti, quella cicatrice che nei giorni umidi diventava bianca, come un segno a pastello irregolarmente in rilievo. Tesi il palmo, per vederla deformarsi e schiarirsi ulteriormente. Il giochino mi annoiò presto e portai la mano alla maniglia, ma senza decidermi ad aprire. Avevo ancora qualche minuto di margine, poi sì, poi avrei ufficialmente fatto tardi al lavoro.Non so perché, ma girai la chiave e feci partire una spatolata dei tergicristalli. Una sola, nitida e pulita, e quasi senza rumori, efficiente abbastanza da sgombrare il parabrezza e permettermi di guardare davanti. Proprio la mossa che mi serviva per disperdere in un amen l’ultimo barlume di vitalità, indubbiamente. Il paesaggio che mi si presentò era triste come uno sposo mollato sull’altare, che si preoccupa di consolare i parenti più cari. Con sollievo, il vetro tornò subito a imperlarsi di spilli di pioggia e lo spettacolo si diluì e sfumò, quasi a esaudire una preghiera.
Dovevo scendere. Dovevo dovevo dovevo. Ma non scendevo. Ero convinto che uscisse musica, dal lettore CD. Invece, quasi con una specie di stupore, vidi che era spento. Forse non l’avevo nemmeno acceso, venendo via dal garage. In effetti, nel silenzio del parcheggio, si sentiva il lievissimo fruscio di gocce che seguitavano a depositarsi sul parabrezza, ormai privo di trasparenza. Un sottofondo fioco come neve. Era una pioggerella farinosa, omeopatica, così seria, professionale e calata nella parte che, in un concorso cinematografico dedicato ai film sui funerali, avrebbe vinto a mani basse la statuetta per la miglior interpretazione per il ruolo di attrice non protagonista. Era solenne e discreta, c’era e non c’era. Però c’era. Sopra questo rumore ininterrotto di vetro accarezzato, se ci si prestava attenzione, si notavano gli schiocchi del motore che si raffreddava velocemente. O forse era il cofano, che schioccava, non saprei. Cos’è che schiocca, quando la macchina si spegne? Il motore o il cofano? O tutti e due? Dovrò risolverlo prima o poi questo enigma, mi capita di pensarci spesso. Ecco cosa mi sorpresi a domandarmi, nemmeno fosse stato quello il principale dei miei problemi. Piuttosto, era la mano debole, appoggiata con due dita molli su una maniglia che non avevo nessuna voglia di tirare. Oltre che umidità, da tutti i pori trasudavo anche stanchezza. O come accidenti si può chiamare una demotivazione ansiosa e perspirante, che cerca di sgusciare fuori per sublimazione.

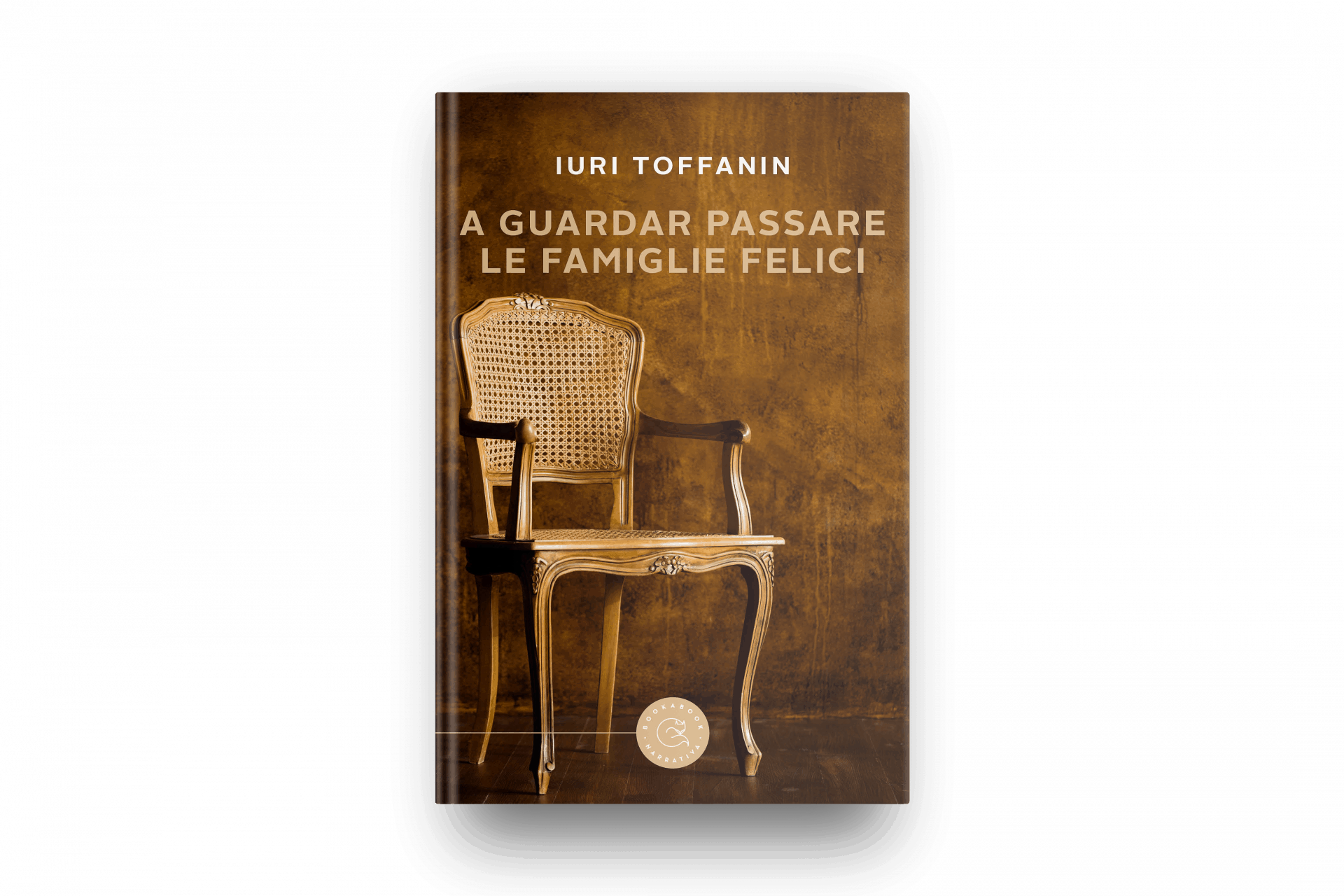

Marco Selvini (proprietario verificato)
Ho letto le bozze del libro: non vedo l’ora di avere la copia da mettere nella mia libreria.
Un romanzo avvincente, intrigante, con uno sguardo molto realistico ai sentimenti delle persone che lo popolano. Difficile non restare coinvolti, difficilissimo non lasciarsi travolgere dal finale calmo ma denso di sentimento.