Qui o altrove
Qui o altrove, dovunque siamo, portiamo dentro di noi una idea di noi stessi, esatta o inesatta, sana o malata, nobile o modesta, naturale e inconsapevole, o studiata ed elaborata in modo meticoloso. È il nostro personale “passaporto” con cui ci presentiamo al mondo e agli altri, ed è prezioso per noi più di quanto siamo abitualmente portati a credere. È un passaporto che la società dove ci troviamo può riconoscere o respingere, ma, in ogni caso, per noi stessi rimane un elemento particolarmente importante con cui vivere. In Pane e cioccolata, Manfredi ci racconta, come sanno fare solo i grandi maestri, della storia di un italiano emigrato in Svizzera per lavoro. Dopo una serie di vicissitudini sfortunate e degradanti, perso il lavoro e il permesso di soggiorno, decide di cambiare fisionomia, si tinge i capelli di biondo per sembrare più “tedesco” e rispettabile, e assume una postura e un tono altero e consono, per nascondere la sua vera identità e confondersi, mescolandosi meglio con gli svizzeri stessi. È nella nostra natura aver bisogno talora di nasconderci, tenere al sicuro dentro di noi delle parti importanti, che è bene non siano conosciute dagli altri e, nello stesso tempo, abbiamo anche bisogno di svelarci agli altri, o di essere scoperti, come meglio vedremo successivamente. Ma in un bar assiste a una partita di calcio dove gioca la Nazionale italiana di calcio. Appena la Nazionale segna un gol, sebbene una parte di sé, quella che vuole nascondersi, lo trattiene, esplode l’altra parte, quella che ha bisogno di svelarsi, e urla con entusiasmo di tifoso. È gol! È il riscatto, minimo, di cui ha bisogno. È l’identità di un italiano migrante, derelitto, disperato, negletto, che, incontenibile, urla. È una voce che grida: «Sono io, proprio io, e sono così». È l’identità a essere incontenibile, a uscire fuori urlando, rivendicando la propria presenza e la propria essenza. In questo altrove può essere un disperato, ma rimane integro nonostante il mondo si adoperi nel suo insieme a travolgere la sua integrità. Rimane il fatto che “è solo a favore dei disperati che è concessa la speranza”.
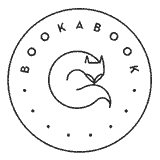


Commenti
Ancora non ci sono recensioni.