È in questo senso che si forma Luca Russo, il protagonista di queste pagine. Attraverso i suoi occhi noi possiamo vedere le diverse sfaccettature di una delle principali vertenze industriali della storia d’Italia. C’è la lotta contro i poteri che controllano l’azienda e non di rado cercano di calpestare i lavoratori; c’è lo scontro fra settori diversi della comunità locale, che a tratti assume i contorni di una “guerra civile” fra visioni del mondo quasi inconciliabili; e c’è la difesa strenua non solo del posto di lavoro, ma di un’identità, di una cultura, di un modo di stare al mondo. È questo forse il piano più vibrante, quello che conferisce al racconto i toni della tragedia.
Per i canoni della “società liquida” la flessibilità lavorativa è una cosa ovvia. Ma qui non ci troviamo semplicemente di fronte a individui che a un certo punto della loro vita si pongono il problema di ricollocarsi sul mercato del lavoro. Fabio Boccuni delinea una vera e propria “apocalisse” che, a differenza di quelle analizzate da Ernesto De Martino, non conduce ad alcuno sbocco positivo. Il mondo della fabbrica si avvia al crepuscolo, lasciando sul terreno esistenze frantumate e disperdendo un intero patrimonio di idee, di pratiche, di relazioni.
A farne le spese è soprattutto chi, come il nostro Luca Russo, di quella storia ha rappresentato la coscienza più lucida. Resta ancora della vita da vivere, certo. Ma è un vivere da spiantato, da disadattato, da esule. È un ritrarsi progressivo, fino quasi a diventare solo una voce che chiama dal sottosuolo.
Verrebbe da invocare una rigenerazione umana, che faccia almeno il paio con la rigenerazione urbana che in tanti si affannano a reclamare per le vecchie aree industriali. Ma per restituire senso agli esseri umani gli archistar servono a poco.
E una domanda allora sorge spontanea: questo nuovo mondo, questo mondo senza fabbriche, è in fondo un progresso?
Salvatore Romeo
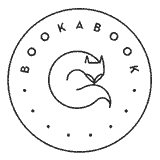













Commenti
Ancora non ci sono recensioni.