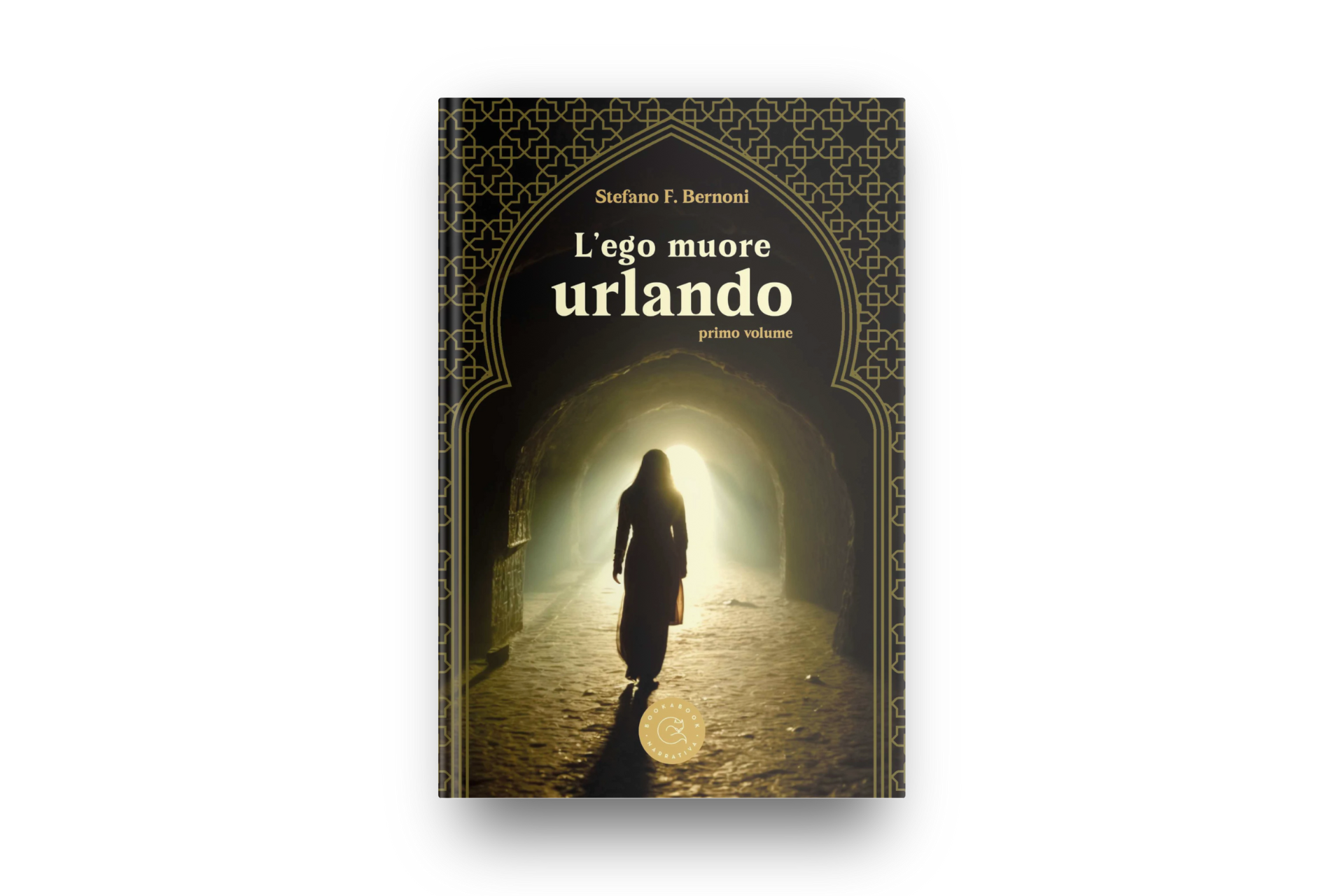
primo volume
CALCUTTA
I.
La città sotterranea
Che sarebbe stata l’estate più calda di sempre lo si era capito fin da quel giorno nell’ospizio dei morenti. Anche il vecchio Shubojoy, grondando sudore dalla fronte, mi guardava con disappunto. Ogni boccone che mandava giù, ogni grumo di cibo caldo che si faceva strada nel suo esofago, gli strappava un avido respiro da annegato che rinsavisce. Sussultava come se lo avessero immerso in acqua gelida e si fermava a bocca aperta: per un attimo non diceva niente, non si guardava intorno, non fiatava nemmeno. Sembrava impegnato a ponderare l’estrema futilità di ogni respiro che traeva da quell’aria contaminata, mentre il suo occhio semi-cieco, ostruito come da una frana di pelle cascante, mi scrutava con assoluta indifferenza. Masticava per un po’, o meglio ruminava tra le gengive sanguinanti, dopodiché, riaperta la bocca, lasciava che vi infilassi un altro cucchiaio di riso e lenticchie. Le labbra, nere come i lembi di una vecchia ferita, si avvolgevano intorno al cucchiaio, cercavano di risucchiarlo mentre lo sfilavo ancora mezzo pieno di cibo, attaccato a un filo di saliva che si tendeva a mezz’aria come la tela di un ragno.
Mi guardava e io ricambiavo con la stessa severità, in attesa che finisse di masticare, che ingoiasse e riaprisse la bocca, invitandomi a nutrire l’abisso di fame cui egli prestava le sue labbra e le sue gengive senza denti. Nella cataratta azzurra del suo unico occhio affondavano i secondi della mia giornata, silenziosi come sassi in un lago senza fondo. Mi sembrava, con quei cucchiai di riso, che stessi tenendo in vita non un vecchio moribondo ma il mondo stesso, creatura affamata dai mille orifizi.
Ogni tanto, con la pezzuola che tenevo nell’altra mano, mi sporgevo per asciugargli il mento e la bocca, da cui scacciavo un paio di mosche che gli ronzavano intorno, corteggiandosi a mezz’aria, volando con la smania di chi cerca l’uscita da quel palazzo austero, immerso nel biancore delle sue pareti immacolate.
Continua a leggereQuel mattino di marzo, nella mensa del reparto maschile, erano seduti intorno a me cinquanta ospiti vestiti alla stessa maniera, con il pigiama verde a maniche corte, senza mutande e senza calze, tutti rasati a zero e con lo sguardo chino sui piatti. Mangiavano con le mani, usando le dita a mo’ di cucchiaio per raccogliere il riso e intingerlo nel curry, ma se non erano in grado di mangiare da soli i volontari si occupavano di imboccarli col cucchiaio, cercando di fargli ingerire la dose minima di calorie giornaliere. Non era facile. Bisognava sopportare la sensazione del proprio corpo che si liquefaceva nell’umidità soffocante di mezzogiorno, non soccombere impietositi alla vista di quegli occhi incastonati come gemme nei loro volti scabrosi, imploranti dal fondo di un’anima che sembrava strappata di forza al tessuto della vita.
Il vecchio Shubojoy aprì la bocca quel tanto che bastava a infilare il cucchiaio. Mentre lo sfilavo come sempre mezzo pieno, fui investito dal fetore che emanava il suo corpo malato. Pur col brusio delle voci che echeggiavano in tutto l’ospizio, sentivo chiaramente il risucchio del ventre in cui gli intestini sembravano stiracchiarsi come serpenti, posseduti da una frenesia cieca e impersonale. Era questa macchina dagli sfiati nauseabondi ciò che lo teneva ancora in vita: per questo mi avevano incaricato della sua manutenzione quotidiana. E io mi ci dedicavo con la stoica rassegnazione di chi, pur non capendo o approvando la necessità di sfruttare questa macchina fino alla rottura del suo ultimo ingranaggio, ha quantomeno la decenza di non farne una questione di principio.
Nel ronzio della mensa che si svuotava lentamente, la maggior parte degli ospiti aveva finito di mangiare. Uno a uno si erano alzati in piedi, avevano scostato i tavolacci di alluminio e, se erano in grado di camminare da soli, erano usciti dalla mensa barcollando come ubriachi, i cateteri trascinati insieme agli avanzi di cibo e agli orli troppo lunghi dei pantaloni bagnati. Su piedi edematosi e monconi fasciati, su caviglie storte e dita amputate, se ne erano andati verso i bagni o verso i letti del dormitorio maschile, sostenendosi o intralciandosi l’un con l’altro. Come scarafaggi quando si accende la luce, gli ospiti del reparto maschile erano fuggiti in ogni direzione. Si erano riversati fuori dalla mensa, lasciando me e Shubojoy da soli al centro della stanza, esposti alla luce inclemente dei neon che evidenziava ogni ruga, cicatrice ed espressione del suo volto antico, rigato come una parete di roccia su cui un tempo scorreva una cascata. Intorno a noi le panche erano già state capovolte, i tavoli accatastati alla rinfusa per lavare il pavimento, le sedie a rotelle abbandonate in mezzo alla stanza, ancora sporche di cibo ed escrementi.
Rimanemmo soli per qualche minuto: io ad ascoltare in silenzio il ronzio delle mosche che continuavano a volare in cerchio; Shubojoy a masticare con sensualità e indifferenza, consapevole che ogni boccone poteva essere l’ultimo. Ogni momento, ogni respiro, ogni pensiero era come l’ultima mossa di una partita a scacchi in cui l’avversario, nella sua onnipotenza e perversione, ritardava il momento dello scacco matto, divertito dalla serietà che noi mortali mettevamo in ogni singola mossa.
Con la coda dell’occhio vidi alcuni volontari trascinare un paziente infermo su una sedia di plastica oltre la tendina che nascondeva l’ingresso dei bagni. Là dentro, come ogni giorno alla fine del pranzo, gli incontinenti e quelli che mangiando si erano sporcati il pigiama venivano portati per essere lavati e cambiati: usavano i bagni alla turca dove entravano a piedi nudi, a volte defecando già davanti all’entrata; si abbassavano i pantaloni e urinavano direttamente nel tombino. Se però non erano in grado di fare da soli, eravamo noi volontari a prenderli in braccio per adagiarli su una sedia bucata al centro, che veniva posizionata sulla turca. Eravamo noi a lavarli con acqua e sapone disinfettante, spugne e straccetti che, insieme ai vestiti sporchi, venivano poi gettati in un grande barile di plastica, pieno a metà di acqua e detersivo, da cui emanava l’odore tipico del lazzaretto, quel miscuglio acre – chimico e al contempo organico – di feci e candeggina, di sudore e disinfettante per ustioni, di frenesia batterica e pulizia. Era l’odore, ormai così familiare, della biancheria asciugata al sole dei tropici, dei corpi stagionati nell’olio di sandalo e canfora, negli unguenti per le ferite verminose che le suore novizie disinfettavano e pulivano come se fossero state spugne da strizzare vigorosamente.
Più volte al giorno, uno degli inservienti sciacquava il pavimento usando la canna dell’acqua. Si spingeva quella spuma di feci e urina verso lo scolo, giù nella Calcutta sotterranea, reame ctonio della materia decomposta che fermentava nell’oscurità delle fogne. Era, quel fetore, il sospiro caldo di una dea che mi iniziava ai suoi misteri. Era Morte, vecchia vedova dai denti cariati, storti e affollati come le grate arrugginite di quegli scoli infestati di larve e scarafaggi. Era Calcutta, giovane sgualdrina dagli occhi infiammati di febbre e desiderio, monatta che cammina tra i morti dispensando canzoni e unguenti miracolosi. Era Madre Teresa, lanterna nell’oscurità dei loro occhi cisposi, annebbiati dalle cataratte, il sospiro di sollievo sui loro volti angelici, rivoltati come viscere di topo sui marciapiedi della necropoli insofferente. In quel fiato caldo di escrementi, nel respiro delle fogne che si sollevavano come un fiume dagli scoli, avvertivo, per quanto vagamente, la presenza di una creatura ben più vasta di quell’ospizio, forse proprio una dea-città nei cui orifizi mi affacciavo con la sensazione vertiginosa di poter cadere all’infinito. Nella stagione eroica della mia gioventù vagabonda, ella era tutto ciò in cui mi restava di credere. Per questo la pregavo in silenzio di accogliermi tra le sue infinite spire di città materna e vorace: Leviatano che ha tetti di zinco al posto delle squame!
Troverai qui tutte le novità su questo libro
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
bookabook srl via Vitruvio 42 – 20124 Milano P.IVA 08455350960
Commenti
Ancora non ci sono recensioni.