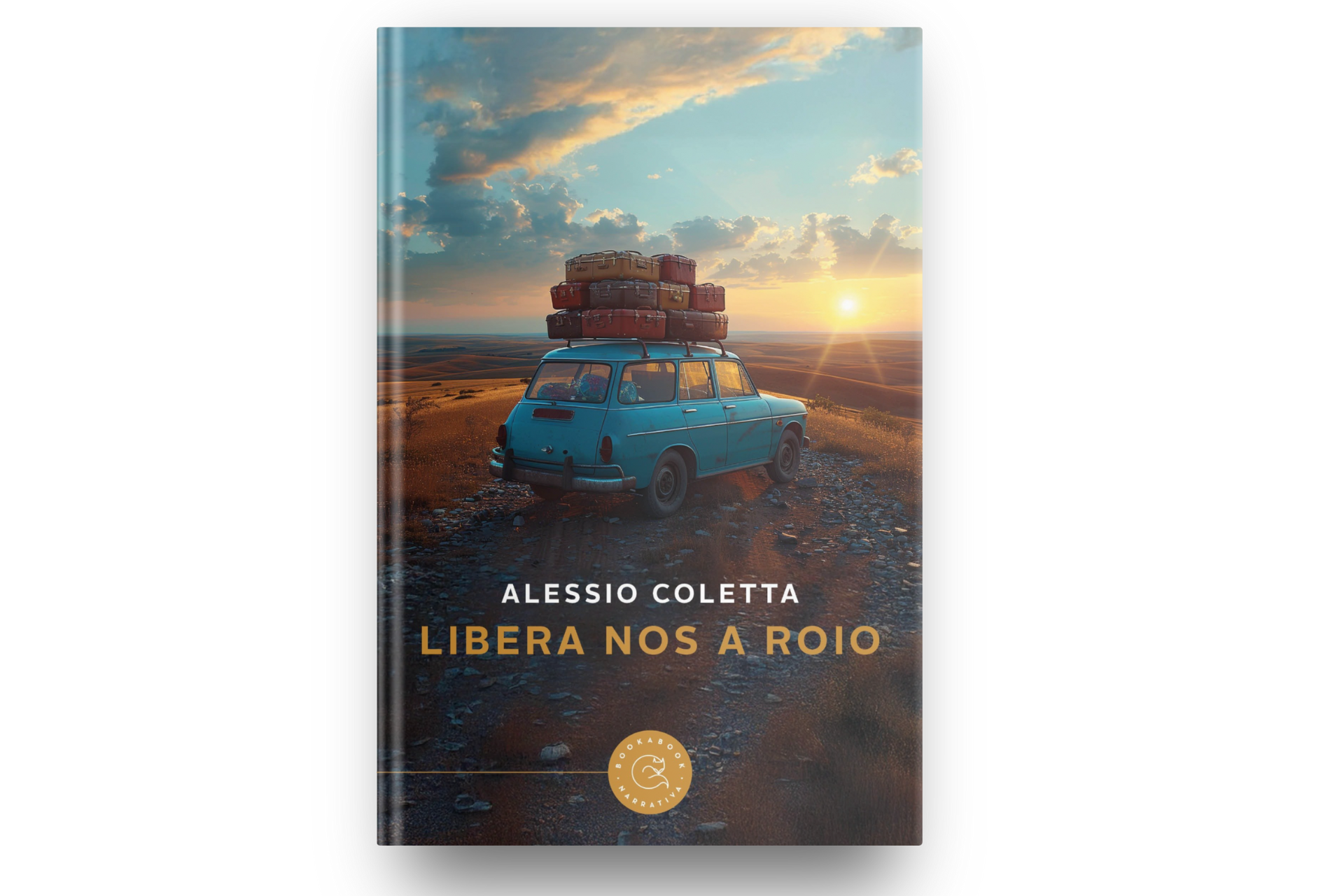
Prologo
Ernani, il bar. Vi si beveva e giocava a carte. Dire “vàjjë a Ernànë” era di per sé una confessione, un’ammissione di colpa.
Il rumore della saracinesca che Ernani tirava giù bestemmiando a tarda notte era il colpo di grazia per tutte le anime perse ancora vaganti per il paese.
La rua Mannara, budello stretto tra due case, dove si passava in silenzio assoluto e in fila indiana, e al fondo del quale si apriva un piccolo e nascosto belvedere, luogo deputato alla perdizione, al fumo, allo stravizio, alle trasformazioni licantropiche sotto gli occhi complici del monte Lupara. La frase “jèmmë a la rua Mannàrë” voleva dire: “è ora”.
Lë ggiàrdënìttë, i giardinetti. Il posto dei flirt pubblici, delle chiacchiere e dove andare a “pijja’ frìshchë”.
Lu shpiazzàlë dë Cìrë, lo spiazzale di Ciro. Tra rottami di automezzi abbandonati, perfetto luogo del crimine, dell’occultamento del cadavere.
La shtràdë, la via principale del paese a esclusivo transito trionfale per giocatori stanchi per la partita di pallone, per reduci della montagna, per parate di cacciatori di ritorno da macabre battute di caccia al cinghiale con vittime sul cofano. Dopo cena, vasca per la passeggiata.
Lu càmbë, il campo sportivo. Luogo vasto e buio, leggermente fuori dal paese verso la montagna, dove si andava a imboscarsi e ci si accorgeva con bell’anticipo di chi stesse arrivando su.
Lu bbìvië, il bivio, verso dove si cammina quando si è inquieti. Un tempo ci si fermava la corriera, era una specie di stazione: da lì si partiva o si vedeva partire; si tornava o si aspettava che tornasse qualcuno.
La piàzzë, dove ci si mette, dove ci si parcheggia. Perché in piazza non ci si va, ci si posiziona, ci si va a mettere, come una mercanzia; frequentemente si usa dire la frase “më vàjjë a mmèttë a la piàzzë”.
L’albèrghë, il glorioso hotel Sangrillà, che negli anni Cinquanta era un hotel di lusso con vista mozzafiato, ma negli anni Ottanta e Novanta si presentava in mezzo alla piazza del paese come uno spettrale casermone abbandonato. Së jàivë dèndrë a l’albèrghë solo per fare cose illecite.
La cchìjësë, la chiesa, luogo dove si va a farsi vedere… giusto per. Ricorrente era l’espressione “më vajjë a ffa’ vëde’ a la cchìjësë” quando le messe stavano per finire.
Lë Pèshchë e la Fundëcèllë, quartieri dove si va a finire quasi rotolando, like a rolling stone: “Cë si jèutë abbàllë pë’ lë Pèshchë? So’ fënèutë a la Fundëcèllë!”.
Lu Palàzzë, il quartiere della parte alta del paese. In passato era pieno di viuzze buie, case vecchie e pericolanti, trulli. A meno che non si abitasse lì, non vi era motivo di andarci e non ci si poteva certo finire rotolando. Era spesso usato per nascondersi o far perdere le proprie tracce.
La Pènnë, una delle estremità del paese, due case a strapiombo sulla roccia verso sud-ovest, covo di serpenti e rapaci. Luogo di poveri cani latranti, lì non passa mai nessuno e ci si può solo stare aggrappati, come il leggendario Pallìttë, un “romito”, come diceva nonno Peppe, che come dimora aveva scelto un buco in quella roccia “’mbàccë a la Pènnë”: la grotta Pallìttë.
Lë Papardèllë, quartiere con sole tutto il giorno e pieno di bambini che giocano dalla mattina alla sera.
Lu bbelvedèrë, punto panoramico sulla punta nord-est del paese, luogo di flirt proibiti in condizione di semi intimità, perché, siccome la strada vi sbuca stretta di colpo, come in un’arena, può irrompere chiunque da un momento all’altro.
La cabbìnë, luogo maleodorante dove ci si andava solo “arrètë”, dietro: l’espressione “arrètë a la cabbìnë” parla di bisognini veloci o, un tempo, di baci proibiti.
La vìë dë Mondëferràndë, ospizio a doppio senso di marcia.
La vìa nòvë, la via che porta fuori paese per destinazioni anche lontane, strada trafficata di camminanti, podisti, cani randagi, macchine, corriere, motorini e bici. Una via che una volta che l’hai presa non sai come e se ritorni. È la via della fuga, ma anche quella che porta al cimitero.
Lë trè ccrèuscë, meta di ogni breve passeggiata. Le tre croci sono l’unico punto da dove capisci davvero che cos’è Roio.
La bbenzìnë, la pompa di benzina. Punto di ritrovo di ragazzi sotto il sole cocente, odorante di nafte e miscele, tra motorini truccati, carburatori intasati, candele sporche. Luogo ideale per vantarsi di donne e motori e per raccontarsi balle. Luogo scomparso.
Lu càmbë da bòccë, reparto geriatrico intensivo.
La mundàgnë, la Lupara. Messa così, a oriente, la montagna è da sempre il vero luogo di spiritualità dei roiesi. Presenza paterna, dura e benevola, sovrasta il paese. Il roiese che voglia trovare se stesso ci si arrampica ostinatamente da secoli tra sterpi e spini fino a raggiungere la cràuscë, la Croce Santa Maria, ai confini con la selvaggia tribù dei castiglionesi. “Vajjë a la mundàgnë” non significa vado su di lei o verso di lei, ma significa vado “a” lei, purificato, pronto per un’iniziazione che alla scalata fa seguire la mensa e, ovviamente, una gran bevuta che renderà allegra la discesa.
Lu bbòshchë, il bosco, profilo supino, eterno e materno, col cielo sopra. Pancia grande e mammelle boscose colorano le stagioni verso occidente. Lui è lì, ma non ci si va più. I vecchi lo guardano sempre, gli altri gli rivolgono lo sguardo solo al tramonto.
La Majèlla. La Maiella è sempre là, ultima, immensa e imperturbabile. Tu lo sai che alla fine comanda lei e per questo è al centro di tutte le espressioni di meraviglia, così come di tutte le imprecazioni.
Continua a leggereNën d’àmmala’!
Nën d’àmmala’! urlava mia madre quando uscivo di casa, e in quell’avvertimento c’era qualcosa di oscuro, profetico, minaccioso. Scì scì, rispondevo, ma figuriamoci se pensavo a non ammalarmi, tra trattori, ruspe, sbanchi di terra, partite a pallone, gare a tappi di bottiglie, casette sugli alberi, nei campi, nelle grotte, gamberi al torrente, partite alla tedesca, tennis, biciclette, pugnette, bombe, bombette, briscola, scopa, tressette, zombafùössë, frëca’ lë marròcchë, tuzzula’ a lë pòrtë dë nóttë, scampagnate, sigarette, campane, nascondino, guardie e ladri con limite di nascondiglio “tutto il paese fìnë a lu bbìvië”… tutta vita, altro che malattie.
«Chë ssi fàttë» disse mia madre con tono dolente quando, scostata la cannizza, mi vide entrare in casa febbricitante.
«Nijëndë» risposi.
«Assèttëtë èssë, disgrasiàtë.» Mi indicò la poltrona sdraio di mia nonna e, tempo di sedermi, titlìk titlìk titlìk titlìk già era arrivata ciabattando a un centimetro dal mio naso e mi fissava ondulando la testa su un collo senza muscoli, emettendo un «Të si ammalàaatë» quasi strozzato in una cantilena di bile.
Dopo qualche “chi sci ’ccìsë” e dopo aver evocato lë mùörtë dë chi t’ha fàttë nàscë e ppàscë, allora partivano le 99 pòzze, pòzza shta’ cëcàtë lë fìjjë e cchi më l’ha dàtë, pòzza jitta’ lu sànghë, pòzz’ avàjjë, pòzz’ ave’ lë bbènë, pòzza jitta’ lu vëlènë, pòzza cala’ ’nu tòcchë, pòzza shcanda’, eccetera.
Insomma, queste erano le operazioni di “primo soccorso”. Poi cominciava la lunga degenza in casa, mentre fuori tutta la vita prorompeva di gioia, gioco, risate. A volte, Luciano, Mastroluco o Cico passavano a vedere se ero ancora vivo, ma le giornate da ammalato a Roio erano interminabili e le sere ancora di più: fuori sulle Pappardelle orde di amici giocavano a nascondino mentre noi in casa eravamo in silenzio nel grigio bluastro della televisione a vedere Portobello, la trasmissione più noiosa del mondo, che io non capivo e sono sicuro non capivano neppure i miei nonni e i miei genitori che pur la seguivano con tanta attenzione. Due ore di puntata nell’attesa di sentire parlare quel maledetto pappagallo che alla fine non parlava mai… una frustrazione infinita. E io morivo quando SU ZU KI! SU ZU KI! SU ZU KI! arrivava da fuori il coro che tutti quanti facevano allorché Cico, che era velocissimo, rimaneva ultimo e poteva fare tana libera tutti al lampione in punta alle Pappardelle lato Calzettara, scattando da sotto la panchina annànzë a la càsë dë za Mmaculàta Lattàndë: Cico aspettava che chi cercava arrivasse vicino a lui per poi uscire fuori improvvisamente e bruciarlo in corsa nel rettilineo. Non ce n’era per nessuno.
La febbre non passava… «Èmma, fa’ la pënëcëllëjnë» sentii mia madre dire a nonna Lucia, ed entrambe si voltarono sincronizzate verso di me.
La pënëcëllëjnë? E che è? Sicuramente qualcosa di brutto, pensai, a giudicare dai loro sguardi torvi.
«Chë è la pënëcëllëjnë?» chiesi.
«È ’na mëdëcëjnë» rispose mia nonna.
«Lë mëdëcëjnë së dànnë e së pìjjënë, mìca së fànnë» continuai petulante.
«No, la pënëcëllëjnë nën zë dà e nën zë pìjjë. La pënëcëllëjnë të la fìjë o të lë fànnë» rispose nonna enigmatica come una sfinge. Al mio sguardo perso, concluse: «So’ sërìnghë».
Mia madre, intanto, con un po’ di gobba prendeva mesta un pentolino, lo riempiva d’acqua e lo metteva sul fuoco.
«Sërìnghë? E cche ccàzzë, sùbbëtë lë sërìnghë, uaglio’, senza mànghë passa’ a lu mìjëdëchë…» biascicai cupo borbottando agitato come il maiale che ha capito che tocca a lui.
«E qquànda më n’avèta fa’ dë sërìnghë?» chiesi incazzato.
«Dìjëcë» rispose mia nonna con la calma e il tono rassegnato di chi conosce perfettamente diagnosi, prognosi e terapia. «Pèeeppë! Oi Pèeeppë! Va’ a lu bbàgnë e pìjjë la pënëcëllëjnë dèndrë a lu shtëipë, currë va’.»
Nonno camminando a modo suo come un vecchio robot, senza sollevare i piedi da terra, praticamente pattinando, raggiunse l’armadietto delle medicine in bagno, come gli era stato chiesto. Il caso volle che proprio in quel momento in televisione passasse la pubblicità della siringa Pic indolor, “la siringa niente male”, e io mi ero incantato a guardare la faccia del bambino della réclame che da preoccupata diventava addirittura sorridente dopo l’iniezione. Sarà così anche per me? È un segno? Fantasticavo ebete.
«Ma la pënëcëllëjnë më la faciàitë ’nghë la Pìc ìndolor?» chiesi.
Mi ignorarono.
Intanto nonno Peppe era tornato con una scatola piatta e lunga, l’aveva appoggiata sul tavolo e si era rimesso sulla sua poltrona sdraio.
«Pèeeppë! Oi Pèeeppë!» Di nuovo nonna Lucia riattiva nonno Peppe. «Va’ a la càmmërë e pìjjë la cascèttë ca shta dèndrë a lu taratèurë càndë a la fënèshtrë, cùrrë va’.»
Nonno, che si era appena seduto, ruggì: «’Natavòtë». Poi borbottando si rialzò e di malavoglia andò in camera da letto, ravanò a lungo nel cassetto del comò lato finestra che gli era stato indicato e tornò in tinello con un qualcosa tra le mani avvolto in un panno che era una canottiera di lana a costine ingiallite. Nonna aprì il panno sul tavolo della cucina e venne fuori uno strano oggetto, una vecchia scatoletta d’acciaio che sembrava arrivare direttamente dal Medioevo. Che sarà mai? Con la rapidità di chi quella scatoletta la conosceva bene, tra lo sferragliare di cinghie metalliche mia nonna sganciò la fibbia della barra che correva lungo il dorso del coperchio, che ribaltandosi divenne manico e trasformò la scatoletta in pentolino. Diabolico. Aperto il coperchio, tirò fuori una lamella d’acciaio tutta bucherellata e poi il corpo panciuto di una siringa di vetro con tacche graduate di colore rosso, uno stantuffo anch’esso di vetro ma satinato e un lungo e grosso ago con attacco in metallo.
Mi sentii svenire.
«Uaglio’, ch’èta fa’ ’nghë quèssë?»
Fui ancora ignorato.
Mia madre prese siringa, stantuffo e ago e li calò nell’acqua che già bolliva nel pentolino sul fuoco e chiuse la manopola del gas. Poi tornò al tavolo, prese la scatola del medicinale, la girò più volte per cercare la scadenza e poi tirò fuori sfilandola di lato una specie di cartuccera di plastica bianca scricchiolante con inseriti tanti flaconcini tozzi con testina metallica. Ne prese uno e rinfilò la cartucciera all’interno. Tornò ai fuochi e con un colino tirò fuori siringa, ago e stantuffo dall’acqua bollente, li mise in una mappina pulita e portò tutto sul tavolo. Qui montò il kalašnikov davanti ai miei occhi terrorizzati: tolse con un coltello la capsula d’alluminio dalla testa della boccetta, infilò l’ago all’interno attraverso il tappino di gomma che la chiudeva e mise la boccetta sottosopra tenendola insieme alla siringa con la mano sinistra e tirando lo stantuffo abilmente con la destra, fermandosi ogni tanto a dare schicchere con le dita e a far tornare un po’ in dentro lo stantuffo per eliminare bolle d’aria. L’operazione durò un paio di minuti circa e, quando il liquido fu tutto nella siringa, dopo averla estratta la direzionò al lampadario per vederla meglio premendo leggera sullo stantuffo fino a far zampillare fuori un paio di gocce. Mia nonna intanto aveva poggiato sul tavolo alcol e ovatta.
Si girarono sincronizzate verso di me. Pronti.
Io mi alzai in piedi, andai su e giù e, dopo un paio di “Në’ lla vòjjë fa’ la sërìnghë” senza nessun riscontro da parte loro, chiesi dimesso di poter stringere tra i denti un fazzoletto. Mi diedero un tovagliolo di cotone spesso. Mi calai pantaloni e mutande e mi misi sul divano in silenzio a faccia in giù stringendo il tovagliolo tra i denti. Senza farsi attendere mia madre passò una volta sola dall’alto verso il basso nella parte superiore della chiappa sinistra il batuffolo imbevuto di alcol e partì veloce. Tac (altro che Pic…). ’Na curtëllàtë, uaglio’. Poi cominciò lentamente a spingere dentro la medicina con lo stantuffo nel bruciore che si faceva sempre più forte… màmma mè chë dëlòrë! Ed era solo la prima di dieci.
Per far sì che non si formasse un nodulo, ogni sera dovevo cambiare chiappa, diceva mia madre. Il risultato fu che mi vennero due noduli, uno per chiappa, e dopo qualche giorno non potevo neanche più stare seduto.
Le febbri grazie a dio se ne andarono prima che finissi il ciclo di punture e potei tornare alla vita.
Quando finalmente uscii di casa, mia madre urlò sulla soglia: «Nën d’àmmala’!».
«Scì scì» risposi, e richiusa la porta më grattëivë lë pàllë fìnë a la piàzzë.
Lu malùöcchië
Lu Mazzamarìllë të tìrë lë pìjëdë dë nòttë! La Paèurë l’hànnë vìshtë ’nghë la càppë e la landèrnë a la vìë dë l’Ëmbèrë! Lu malùöcchië të lë jèttënë quànda të vèdënë magnìë! Të pò capëta’ ’na shtràjä biànghë o ’na shtràjä nàirë!
Era l’epoca delle sedute spiritiche arrètë a l’albèrghë, in quella che era una giungla di vegetazione e arredi da esterno abbandonati.
Dal piano terra si saliva a quelli superiori dell’albergo passando attraverso un pannello senza vetro della balaustra della seconda rampa di scale, che erano percorribili solo fino al primo pianerottolo perché bloccate da un’inferriata. Quando arrampicandoti un po’ entravi di testa in quel pannello, come Alice attraverso lo specchio passavi una specie di “gate” che ti faceva piombare negli anni Cinquanta e Sessanta, quando il glorioso hotel Sangrillà, imponente in piazza con i suoi sei piani, prosperava di turismo bene e di boom economico. Le porte che si trovavano sui pianerottoli a destra e a sinistra erano rimaste aperte, ed entrati negli appartamenti ecco gli arredi raffinati, i telefoni neri a cornetta, le stoviglie di cristallo, l’argenteria e le suppellettili di lusso, tutto ancora lì come se l’hotel fosse stato evacuato all’improvviso. Sul tetto, un grande lastrico solare senza ringhiera ti faceva sentire un’aquila sul cucuzzolo a guardare un panorama mozzafiato volto al tramonto.
Abbandonato da trent’anni, l’albergo era tutto sporco, scricchiolante e spettrale con le sue tende strappate svolazzanti dai vetri rotti delle finestre. Sembrava di essere all’interno del Titanic sotto gli abissi, o all’Overlook Hotel di Shining trent’anni dopo la morte di Jack Torrance, che forse lo potevi trovare ancora lì immobile dietro a qualche porta gialla e blu, i colori dell’hotel.
Era anche l’epoca dello Zio Tibia e dei film dell’orrore: La macchina nera, La casa di Mary, Nightmare, Poltergeist, L’esorcista, La maledizione di Damien, Suspiria, Phenomena. Tutti i miei amici amavano i film di paura, mannaggia a loro, e se li raccontavano eccitati ed entusiasti, mentre io rabbrividivo al solo sentirne parlare e stavo zitto dileguandomi elegantemente da ogni discussione a riguardo per non rivelare che in realtà a me quella roba mi faceva cacare sotto e dovevo tornarci io di notte abbàllë pë’ lë Pèshchë.
Ma chi mi terrorizzava di più era lu Mazzamarìllë. Quel maledetto bambino morto prima del battesimo, che veniva fuori di notte a tirare i piedi guarda caso proprio a te che non c’entravi un cazzo, mi ha fatto passare notti nel terrore, e anche la Paèurë, dopo che avevo fatto il leone con gli amici in piazza o a guardie e ladri, me l’aspettavo cappata con la lanterna dietro agli angoli o semplicemente lungo le stradine delle Pesche, quando a notte fonda tornavo a casa camminando correndo. Del malocchio invece non mi curavo, mi sembrava una cosa davvero sciocca.
Uscii da casa di mio nonno Peppe con la solita fella di pane di Egidio da competizione.
Uöjjë e sàlë ’nghë ’na pèmmadòrë spresciàt’ assòbbrë. E vvìdë chë mìjëgnë! diceva mio nonno sorridendo e porgendomela come oro. Ma, Pappardelle in fiamme nel mezzo pomeriggio, subito lì sulla destra, contro al muretto verde scrostato, seduta alla solita sedia di legno e paglia, Elìsë dë Frajëinë, vecchia occhialuta con barba e fazzuolo, tutta nera come la morte, proprio mentre addento la desiderata fella mi punta l’indice della mano destra e mi urla in una specie di terribile rutto strozzato e soffiato: «Pòzza shtramalëdëjë!».
A quell’augurio, a quel congiuntivo ottativo in dialetto, un brivido mi corse lungo la schiena e bloccò all’istante il mio slancio famelico. Tempo di arrivare davanti a Romolo, all’angolo in fondo alle Pappardelle, mi piomba sulla testa e sugli occhi una coltre di oblio e pesantezza, un malessere che puzzava di inferno. Feci dietro front e ritornai a casa di nonno. Entrai senza spostare la cannizza verde con tutta la fella ancora intatta in mano.
Mia nonna subito: «Jù! Alèzië, chë ssi fàttë!».
Io ero catatonico, lì impalato con ancora qualche cannizza sulle spalle. Si affacciò fuori dalla porta e poi tornò verso di me. «T’hànnë fàttë lu malùöcchië!» fu la diagnosi immediata.
Mi prese la fella, mi fece sedere e mi mise una mano sulla fronte che scottava. Poi disse alcune parole a mio nonno e uscì di fretta. Dopo cinque minuti tornò e mi disse: «Va’ a La calzëttàrë ca t’ëngàndë lu malùöcchië, cùrrë shcàppë».
Obbedii, come un automa uscii, presi a sinistra e mi trascinai da La calzettara, una delle tre sorelle di mio nonno. Erano cinque, tra fratelli e sorelle, ancora tutti viventi, che insieme facevano più di quattrocento anni. I più vecchi erano Cesarèttë e za Mariàittë dë Mondëferràndë; dë Mondëferràndë perché quando le femmine roiesi si sposavano fuori paese, prendevano formalmente la cittadinanza del marito, anche se poi la realtà era che diventavano apolidi, visto che i compaesani del marito l’avrebbero sempre considerata straniera. Poi c’era za Rusìnë La calzëttàrë, za Angiulìnë La bbiòndë e quindi l’ultimo, mio nonno Peppe.
La calzettara, dunque, era una vecchina piccola piccola, con i capelli color ferro raccolti in un mini tuppo in alto sulla testa, che un giorno glieli ho visti sciolti mentre Marìë dë Rocchèttë glieli pettinava e mi sono spaventato perché arrivavano a terra. Essendo paralitica fin da quando, bambina, prese la poliomielite, si spostava per la casa seduta su una seggioletta di legno e paglia che lei afferrava con le mani ai lati della seduta e, facendo oscillare il corpo, riusciva a spingere in avanti come andasse sui trampoli. E andava anche veloce.
Le volevo bene a La calzettara e lei ne voleva a me, anche se non si ricordava mai il mio nome. Quando passavo davanti alla sua porta chiamava tutti i maschi di famiglia: Cèsërë, Alèzië, Giòrgë, Pèppë, Iènzë, Zènë.
«Alèzië, za Rusi’, so’ Alèzië!» rispondevo avvicinandomi sorridendo.
«E sscì sscì, Zènë, vìë’ a écchë vìë’.» Mi faceva cenno di entrare. Le facevo un piccolo favore prendendole il pètino, il pettine, in un cassetto, o un banano, una banana, dalla fruttiera sul tavolo, un sugo di frutta in frigo, e poi mi diceva: «Va’ a lu shtëipë». Io obbedivo, aprivo l’anta centrale della credenza dietro al tavolo e vi trovavo un portamonete di pelle nera morbida con chiusura clic clac. Mi faceva segno di aprirlo e dentro ci trovavo sempre duemila lire arrotolate.
«Accàttëtë lu ggelàtë» mi diceva, e io al volo mi precipitavo da Ernani a comprarmi il King Cono, il gelato più grande che c’era.
Insomma, salgo i due scalini della veranda scoperta esterna sulle Pappardelle ed entro nell’antro buio della Calzetta.
«Za Rusi’?» dissi spostando la cannizza.
Era vicino alla porta che mi aspettava.
«Vìë’ vìë’, Zènë, assèttëtë.» Mi indica una sedia del tavolo.
Io andai senza la forza di dirle “So’ Alèzië no Zènë, za Rusi’”, e lei venne dietro di me trampolando con la sua sediolina verso il tavolo sul quale c’erano un piatto, una tazzina e un bicchiere pieno d’acqua già preparati.
Za Rusìnë versò nel piatto dell’acqua dal bicchiere e poi dopo aver intinto il pollice della mano destra fece tre volte il segno della croce sulla mia fronte, pronunciando sottovoce parole veloci e strane che sembravano preghiere. Si fece quindi lei tre volte il segno della croce e dopo, toccando i bordi del piatto in alto, in basso, a sinistra e a destra, con le dita fece meccanicamente sempre tre volte il segno della croce ripetendo formule sottovoce. Io, intanto, oltre a sentirmi peggio di prima, ero anche cacato sotto di paura.
Prese poi la tazzina sul tavolo. C’era dell’olio dentro. Ci bagnò l’indice della mano destra e fece cadere alcune gocce nell’acqua del piatto. Ricordo che le gocce si allargarono fino quasi ai bordi. Dopo aver osservato attentamente il fenomeno, La calzettara mi disse di andare a buttare l’acqua nel lavandino e mi raccomandò di fare molta attenzione a non farla cadere per terra. Le riportai il piatto e lei ricominciò da capo, versò acqua all’interno, ci bagnò il pollice e mi fece i tre segni della croce in fronte. Sconfortato dedussi che il primo tentativo non fosse andato a buon fine. E allora altro giro altra corsa tra avemarie, ora pro nobis, croci, gocce d’olio, ma anche quella seconda volta le gocce si allargarono. Io ero sconfortato e sempre più febbricitante.
La calzettara mi guarda, mi prende la mano e molto seria mi dice: «Va’ a La calandrèllë cùrrë shcàppë».
Esco dunque sulle Pappardelle, quartiere che fino a quel momento avevo creduto fosse solo un grande asilo a cielo aperto, ma che ora mi appariva come realmente era, un asilo a cielo aperto sul quale svolazzavano su e giù streghe nere e streghe bianche. La luce mi abbaglia, vado a destra, entro da mia nonna e le dico che il rito non aveva funzionato e che La calzetta mi aveva detto di andare da La calandrella. Mia nonna subito mi prese per mano, uscimmo di casa, andammo a destra, passammo davanti alla sedia vuota accanto al muretto dove prima era seduta la vecchia strega che mi aveva fatto il malocchio, e dopo due case, prima lei e poi io entrammo da La calandra.
Le vecchie si parlarono rapidamente e poi mia nonna uscì. Marìë La calandrèllë era più giovane di za Rusìnë La calzëttàrë, e anche più energica e risoluta.
Troverai qui tutte le novità su questo libro
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
bookabook srl via Vitruvio 42 – 20124 Milano P.IVA 08455350960
Commenti
Ancora non ci sono recensioni.