Giorgio M. Ghezzi, con questo suo bel libro, mi ha posto una quantità di interrogativi, e non mi ha fatto un piacere: quando non so rispondere alle domande che mi pongono o che mi pongo tendo ad ammalarmi di tutte le malattie psicosomatiche che conosco, compreso il ginocchio della lavandaia. In questo caso le cose sono andate peggio del solito, perché cosa realmente voglia dire essere genitori e se la sterilità sia una malattia o un disagio sono stati il problema di quasi tutta la mia vita, e non sono per niente sicuro di averlo risolto. Così farò ciò che sono solito fare quando sono in difficoltà, vi dirò alcune delle cose che so, tanto da mettervi sulle spalle il peso e la responsabilità di trovare una risposta. Con una precisazione: sono di pessimo umore perché ho appena sentito in TV che una bambina (una bambina!) è stata presa a revolverate da un delinquente e forse morirà. E con la premessa, doverosa, di farvi sapere che, almeno secondo il mondo cattolico, io sono un untore.
Continua a leggere
La prima cosa che il lettore potrebbe chiedersi, ma questa è forse l’unica domanda che trova una risposta semplice, è la ragione per cui a un uomo (meglio, a un intellettuale) venga in mente di scrivere un libro che parla dei problemi della genitorialità. Credo che la riposta sia questa: esiste su questi temi un classico conflitto di paradigmi, uno dei più forti e più interessanti che la nostra società abbia dovuto risolvere in questi ultimi secoli, e le persone che riuniscono (non è frequente) intelligenza e sensibilità e capacità di compassione sentono il bisogno di interrogarsi, di guardare dentro il proprio cuore, di aprirlo alla curiosità e all’interesse della società tutta. Di questo non sono sorpreso, non mi sembra nemmeno una domanda “vera”. La prima vera domanda che è invece doveroso porsi quando si parla di padri e di madri riguarda il vero significato di questi termini: si tratta di un istinto come quello, che so, di sopravvivenza, o di un sentimento? Il numero di bambini che non nascono perché i genitori hanno scoperto che si tratta di femmine è talmente elevato, in molti paesi asiatici, che ai medici è proibito per legge far diagnosi di sesso, quando eseguono ecografie in gravidanza. E il numero di bambine che i genitori vendono ai mercanti di prostitute è tanto elevato che mi sono costretto a dimenticarlo, tanto mi fa orrore. Ci può essere un istinto dietro queste scelte? Tuttavia anche il numero di donne pronte a sacrificare la propria vita per salvare quella del figlio è straordinariamente elevato. È sufficiente un sentimento per vincere un istinto che certamente esiste, quello della sopravvivenza? Non lo so, parliamone.
Scrive Élisabeth Badinter, una filosofa francese che viene considerata in questo campo l’erede di Simone de Beauvoir, che nel 1780 il prefetto di polizia di Parigi, un signore di nome Lenoir, constatava non senza una punta di amarezza che, su ventunomila bambini che nascevano ogni anno nella città, solo mille venivano allattati a casa con latte materno; mille sempre a casa da una balia bagnata; gli altri fuori, a sfidare il destino. Moltissimi morivano senza aver conosciuto la propria madre. Quelli che tornavano a casa, ci trovavano una sconosciuta; non esiste prova che questi ritorni fossero felici.
Come spiegare l’abbandono di un neonato in un tempo in cui il latte materno era prezioso per sopravvivere? Come giustificare un simile disinteresse per il bambino? Come accadde che la madre indifferente del Settecento si trasformò nella madre pellicano dell’Ottocento e poi nella madre disattenta e gelida di oggi? Dove è finito l’istinto materno che per opinione generale accomuna gran parte degli esseri viventi? Noi abbiamo oltretutto un’opinione ambigua della maternità, secondo cui la funzione materna cessa solo quando la madre ha partorito l’adulto, essendo l’associazione di uno stato fisiologico particolare con una funzione a lungo termine: nove mesi per la gravidanza, un tempo indeterminato per allevamento ed educazione.
È passato molto tempo da quando Simone de Beauvoir ha rimesso in discussione l’istinto materno, seguita da psicologi e sociologi in maggior parte donne: siccome erano femministe si è preferito credere che la loro illuminazione fosse più militante che scientifica. Scrive Badinter che oggi si riconosce che il comportamento materno non derivi dall’istinto ma si continua ugualmente a pensare che si tratti di un sentimento così forte e universale da avere per forza qualche cosa da spartire con la natura. È cambiato il vocabolario, non le illusioni. Ci rifiutiamo di accettare che l’amore di nostra madre non sia quello che leggiamo nel libro di lettura e non vogliamo mettere in discussione l’amore di nostro padre. In realtà l’amore materno – di quello paterno preferirei non parlare – è solo un sentimento umano, incerto, fragile e imperfetto, e forse non è inciso profondamente nella natura femminile. Ci sono differenti modi di esprimerlo, che vanno dal più al meno passando anche dal nulla. Lo dice Badinter, madre di tre figli. E, tra le righe, scrive che bisogna chiedersi come sempre: cui prodest?
Come considerare poi l’attuale conflitto di paradigmi secondo cui da un lato ci si sente genitori solo nella certezza di un garantito rapporto genetico, dall’altro si inneggia a una genitorialità basata unicamente sulla responsabilità e sulla compassione? Gli antropologi e i sociologi si trovano prevalentemente d’accordo nel dire che il nostro modello tradizionale di genitorialità – tra l’altro, da tempo in crisi per ragioni culturali – non è certo l’unico possibile, come numerose ricerche empiriche hanno confermato. Nelle società umane sono rintracciabili modelli differenti di iscrizione sociale del dato biologico, modi differenti di pensare a come si può essere padre e madre, ed è quindi possibile immaginare che anche su questo tema sia in atto uno scontro di paradigmi, con le conseguenze che sono abituali in queste circostanze: la protesta di chi è fedele al vecchio, le pressioni di chi sostiene il nuovo, i molti (quasi sempre inutili) tentativi di mediazione.
Antropologi e sociologi affermano in sostanza che l’istituto naturale della maternità e della paternità è discutibile, tanto da mettere in dubbio persino l’esistenza di un istinto genitoriale espresso in termini biologici, e ritengono che esso rappresenti piuttosto un mito che l’Occidente ha enfatizzato. Questo mito si incentra su una determinata visione dell’uomo e pretende di definire in base a essa la nostra identità. In realtà, immaginare di poter derivare da eventi biologici definizioni che abbiano carattere simbolico si è rivelato, come è noto, del tutto errato.
Se è vero che il concetto di genitorialità è prevalentemente simbolico, bisogna accettare l’idea che i genitori di un bambino sono quelli che la società indica. Per molti secoli, per esempio, è prevalsa l’idea aristotelica secondo la quale la madre sia solo il “fertile terreno” nel quale l’uomo pianta il suo seme, che lei custodisce “perché un dio non lo colga”, per usare le parole di Eschilo. Lo dice persino Engels, che cita Bachofen e Morgan e sembra dar ragione a Eschilo, il quale condanna la passività femminile perché la rende solo materia, volgare materia che solo i misteriosi poteri biologici del seme riescono a rendere madre (“Lui, sì, è padre, che d’impeto coglie…”). E tutta la difesa che Apollo fa di Oreste nelle Eumenidi è ispirata a questa sprezzante valutazione del ruolo materno che addirittura cancella il matricidio dall’elenco dei crimini. Eppure, l’interpretazione che Bachofen dà dell’opera di Eschilo, il quale riteneva che questa consegna dei poteri tra gli dei dell’Olimpo – Atena e Apollo contro tutti – segnasse il passaggio dal matriarcato al potere del maschio, non doveva proprio piacere a Engels, che amava poco la religione.
D’altra parte, esistono esempi di genitorialità opposti. Nelle isole Trobriand la figura del padre non esiste: padre è solo colui che vive con la madre, non è il genitore del figlio, e la donna è resa fertile da microscopiche entità, in genere lo spirito di un parente, che introducono i figli nel suo utero. È evidentemente una società che ha tendenze animistiche e risolve il problema della discendenza maschile con l’avuncolato, che fa dello zio materno il vero padre dei bambini. Questa avuncoli potestas era conosciuta in Europa almeno dai Lici (ne parla Erodoto) e dai Germani (la cita Tacito). Non è affatto detto, però, che l’animismo porti a queste conclusioni: nel Senegal, per esempio, dove la maternità ha un grande valore sociale, anche il ruolo paterno gode di grande prestigio, mentre presso alcune zone del Brasile la maternità è considerata una sorta di maledizione e in Nuova Guinea i bambini sono figli esclusivi della divinità. E poi c’è il levirato, e poi ci sono numerosissimi altri modelli, a ognuno dei quali si riconoscono importanti qualità positive nell’educazione e nella crescita dei bambini.
In società come la nostra, a fianco del modello prevalente ne esistono altri. Il 20% dei bambini viene educato da un padre diverso da quello biologico, e lo sa; poco meno del 10% si trova nelle stesse condizioni senza esserne a conoscenza. Un numero imprecisato di figli viene educato in famiglie monoparentali e l’ISTAT, nel suo rapporto del 2014 sulle tipologie familiari, ha segnalato che le famiglie monogenitoriali, le quali rappresentano ormai una realtà consistente in molti paesi europei ed extraeuropei, in Italia sono cresciute in dieci anni del 25% e sono oggi il 15,3% delle famiglie.
Dopo avere a lungo cercato, devo dire di non aver trovato un solo documento solido che asserisca che per curare un figlio sia assolutamente necessaria la doppia genitorialità. Si consideri con attenzione il termine che ho usato: necessaria. Le affermazioni relative al fatto che avere due genitori “sia preferibile” sono prevalentemente empiriche, non si basano su ricerche prospettiche e usano strumenti valutativi discutibili. Devo dire per correttezza che anche la documentazione che ho consultato e che afferma che non si riscontrano elementi negativi considerando i risultati dell’educazione impartita da genitori dello stesso sesso è scientificamente discutibile. L’idea che i genitori possano essere più di due è antica quanto il mondo ed è passata intatta attraverso le più diverse influenze culturali fino a raggiungere la nostra società. Il racconto Storia del re e del cadavere, scritto in sanscrito circa seicento anni prima della nascita di Cristo, descrive i tre padri di un giovane re, mettendo dunque a confronto tre diverse figure genitoriali: quella basata sulla legge e sul contratto, quella biologica e quella costruita sull’autorità morale dell’educatore. Il racconto non si pronuncia, non fa scelte, ma crediamo che già l’aver presentato il problema in questi termini rappresenti una scelta di campo.
Mi sembra interessante riassumere quanto scritto da William James in un saggio del 1890 intitolato Principi di psicologia: l’istituto naturale della maternità e della paternità non esiste affatto e rappresenta solo un mito molto enfatizzato in Occidente. Si tratta di un’affermazione incentrata su una certa visione dell’uomo, tipica della nostra società, in cui la scienza, e in particolare la medicina, pretende di avere la chiave della nostra identità. Bisogna invece riflettere sul fatto che questa pretesa sia soltanto un’illusione o, più esattamente, il mito su cui si è fondata in Occidente l’immagine della maternità e della paternità. In effetti, in altre parti del mondo, altre culture hanno creato sulla genitorialità miti molto diversi. Dunque, così come è biologicamente vero che una gravidanza è il prodotto della fecondazione di un ovulo per opera di uno spermatozoo, allo stesso modo è sbagliato trarne una qualsiasi definizione di paternità e maternità, definizione che è di ordine simbolico e non di ordine biologico. Il semplice buon senso mostra d’altra parte che quando un uomo e una donna aspettano un bambino e dicono di averlo concepito insieme, la prova biologica di ciò è difficile da ottenere ed è in genere solo la loro parola ad affermare che è così e che lo spermatozoo fecondante non è di provenienza diversa.
Dire che siamo esseri parlanti equivale a dire che siamo esseri intelligenti, ed equivale anche a dire che siamo indirizzati a essere molto di più della nostra biologia. Parlare del desiderio di avere un figlio, parlare dell’essere genitori significa trascendere l’ordine biologico per accedere a un altro ordine, quello su cui ci basiamo in quanto esseri umani, e cioè l’ordine del senso. Non esistono altri genitori che quelli culturalmente definiti tali, e cioè quelli che una certa cultura attribuisce a un certo bambino. Da ciò scaturisce l’esistenza di diversi modelli possibili di maternità e di paternità.
In effetti, l’antropologia ci mostra che: il padre di un bambino non è necessariamente il suo genitore biologico; egli non è necessariamente l’uomo che vive con la madre; al momento del concepimento del bambino, può essere morto da molto tempo; può essere una donna; può essere dio; la madre di un bambino non è necessariamente la sua madre biologica; può essere sua nonna; può essere sua zia; una donna sterile può essere la madre di un bambino che le viene attribuito secondo le regole della circolazione dei bambini propria della sua cultura. A tutte queste modalità di filiazione viene riconosciuta legittimità sociale.
Anche nella nostra società si è comunque fatta strada, con la lentezza che contraddistingue tutte le modificazioni del senso della morale comune, l’idea che alla genitorialità tradizionale si possa affiancare quella di una paternità e di una maternità basate sulla promessa di presenza: siamo i tuoi genitori perché staremo vicino a te, per far sì che la tua qualità di vita sia la migliore possibile e per garantirti le cose sulle quali ogni bambino dovrebbe poter contare.
Come si può capire, si tratta di una genitorialità virtuosa quanto quella tradizionale, che include la donazione di gameti, la donazione di embrioni e l’adozione, un’idea di “etica del dono” che si affianca ad altre forme di donazione più prettamente biologiche, come quella di sangue e di organi. Tutti questi gesti oblativi, sia biologici sia sociali, si inscrivono idealmente all’interno di un principio di solidarietà generale che deve certamente essere difeso dall’ingerenza del mercato, ma che non può essere negato per paura di vederlo inquinato da interessi commerciali. La paura, la diffidenza preventiva che il nuovo suscita, l’abuso del principio di precauzione sono atteggiamenti che dovrebbero essere contrastati nel solo modo legittimo nelle società democratiche: attraverso la lettura attenta della carta costituzionale.
In realtà, quello che oggi pensano un uomo o una donna a proposito del significato della genitorialità è molto difficile da immaginare. In gran parte dipende dall’educazione che hanno ricevuto, dalla loro visione del mondo, dal loro senso comune, dalle loro esperienze di vita. Ciò è particolarmente vero per le donne, per le quali è sempre stato poco importante il concetto di genitorialità genetica. Alcune di loro sono persuase dell’importanza della responsabilità, altre desiderano avere un’esperienza gestazionale, altre non sono per niente sicure della scelta che viene loro attribuita ma non hanno il coraggio di contestarla. Non può essere privo di importanza il fatto che quando il genitore sostituito è il maschio, può accadere, e in realtà accade con una certa frequenza, che si verifichi un pentimento tardivo; cosa che – a quanto ne sappiamo – non è mai accaduta quando si tratta di una donazione di gameti femminili. In realtà, parlare delle donazioni di gameti maschili e femminili come se fossero una sola cosa è scorretto: sono diverse le motivazioni dei genitori, diverse le reazioni del genitore sostituito, diverse le conseguenze sull’equilibrio della famiglia. Del resto gli psicologi si sono sempre trovati d’accordo nel ritenere che gli uomini desiderino un figlio per continuare a vivere in lui e per dare al nome della famiglia la possibilità di continuare a esistere nel tempo, mentre le donne, assai meno attente alla genetica, desiderano soprattutto avere tra le braccia qualcuno da poter amare, educare, del quale essere responsabili.
Non sono sicuro che le cose che ho scritto possano aiutarvi a leggere e capire questo (ripeto) bel libro. Ma, per mia fortuna e per la fortuna degli scrittori di Prefazioni, i libri ben scritti non hanno alcun bisogno di noi.
Carlo Flamigni
Tre brevi avvisi al lettore
Questo libro è autobiografico: sono io il protagonista degli episodi che troverai narrati e sono mie le riflessioni che lo costellano. Pertanto questa mia opera ha ottime possibilità di finire fra i tuoi libri da leggere che non leggerai mai.
Non c’è finzione letteraria, solo cronaca.
Questo libro racconta la storia di una coppia che affronta l’avventura dolorosa e complessa della ricerca di un figlio. Un’avventura senza lieto fine.
Premessa: a chi si rivolge questo libro
Il libro è un oggetto che si offre in modo universale, indiscriminato, aperto. Sugli scaffali di un amico, in libreria, in Autogrill, al supermercato, sulla scrivania di un collega, fra le mani del vicino in treno: un libro, anche quando pare giacere silenzioso, richiama l’attenzione e lancia un messaggio a chi passa. Chiunque egli sia. E a chi quel messaggio lo accoglie, il libro concede di farsi toccare, aprire, sfogliare, portare via.
Dunque, a chi si rivolge questo libro? A tutti, ovviamente. A tutti coloro che, avendone visto la copertina o letto il titolo o saggiato le pagine o valutato l’impaginazione, decidono di portarselo via e leggerlo. Questo libro, come ogni libro, si offre a tutti. Ma un libro che racconta l’avventura dell’infertilità di coppia ha tre gruppi di lettori che non possono non leggere questo libro. E così questo libro si rivolge: a chi ci sta passando; a chi c’è passato; a chi sembra ignorare che tutto ciò possa accadere.
Chi ci sta passando è alla ricerca – talvolta ansiosa, talvolta disperata – di strumenti per affrontare il presente, per non sentirsi solo e sguarnito di fronte a una complessità faticosa che rischia di travolgerlo. Chi ci sta passando ha a disposizione i consulti e i responsi degli specialisti che offrono un quadro scientifico, tecnico e tecnologico dei problemi da affrontare, delle opzioni possibili, delle incognite e delle possibilità. Se ha la forza di accettarne l’utilità, ha a disposizione la psicologia, che lo supporta e lo accompagna nell’elaborazione degli accadimenti. Ha a disposizione le chiacchiere dei mille forum e blog sul tema. Ha a disposizione il compagno o la compagna o la famiglia o gli amici. Chi ci sta passando ha a disposizione libri scientifici e divulgativi sul tema, fior di scienziati e autori ne hanno scritto e ne scrivono. Chi ci sta passando ha una miriade di fonti di informazione e modalità di accedere a strumenti che possano accompagnarlo nel vivere il presente. Questo libro vuole essere uno strumento in più, denso di limiti: non offre la precisione dello specialista, non carezza la psiche né prescrive psicofarmaci, non è vasto né veloce né superficiale come il girovagare su Internet, non ha il calore affettivo dell’amicizia e dell’amore. Non ha tutto ciò, ma è un libro che vuole offrirsi a chi lo legge con la semplicità di uno specchio in cui è possibile riconoscersi almeno una volta e dire: «Sì, è successo anche a me». O riconoscere i propri sentimenti, trovarli rappresentati in un episodio ed etichettati con la parola giusta. O ancora riconoscere i sentimenti di chi ci è vicino e potergli dire: «Ti capisco». O porgere al proprio compagno il libro e dire: «Leggi! Forse così comprenderai meglio».
A chi ci è già passato ho poco da dire, poiché probabilmente ha con sé un bagaglio di storie ed emozioni sufficiente per scrivere cento altri libri: a loro spero di offrire un’occasione per ritornare con serenità sul proprio passato, con l’augurio che la parola “fine” al termine di queste pagine sia d’aiuto per archiviare le proprie sofferenze.
A chi, infine, non ci è passato e quasi sembra ignorare che l’infertilità possa essere una evenienza, a chi rimane meravigliato o perplesso o diffidente nell’incontrare una coppia senza figli, a chi applica con loro, forse inavvertitamente, le categorie della normalità, a chi non ha mai visto da vicino questa sofferenza e quindi non riesce a capire, a chi se ne fa beffe, a chi evoca la colpa e il peccato, a chi tutto spiega con un imperscrutabile disegno, a chi si vergogna di chiedere, a chi ha paura di fare una gaffe, a chi mancano le parole, a chi vorrebbe essere vicino ma non sa come. A tutti loro e a mille altri ancora, questo libro giunga come un bicchiere di buon vino bevuto con gli amici: scioglie la lingua e accompagna in un percorso di nuova conoscenza.
Appoggiato sul comodino, nascosto in una borsa, imboscato in una libreria affollata: quale che sia il destino di questo libro, qualunque sia la fine di queste pagine, il loro successo sarà nell’aver portato qualcuno a dire: «Ora ho capito».
Lavoro (1). Presentiamoci!
Lavoro in una grande azienda, con un ruolo di una qualche responsabilità: risorse umane ed economiche da coordinare, progetti da gestire e poi l’immancabile proliferazione di relazioni con capi e collaboratori, incontri e riunioni – o meglio, meeting: nelle aziende si dice così per essere à la page –, lavori di gruppo e gruppi di lavoro. È esperienza comune a chi si trovi oggi a lavorare in una organizzazione, dalla piccola impresa padronale alla multinazionale, in ruoli di grande responsabilità così come in posizioni operative, l’utilizzo del gruppo come modalità di lavoro in grado di rispondere a qualsiasi bisogno e di far conseguire qualsivoglia obiettivo. Almeno così pare. “Costituiamo un gruppo di lavoro!” è il mantra del management contemporaneo, toccasana per ogni malessere organizzativo, panacea per qualsiasi problema aziendale. Forse solo un placebo da somministrare in dosi massicce quando non si sa bene che pesci pigliare, una buona soluzione per deresponsabilizzare i singoli e investire dei problemi una nuova entità: il gruppo.
Nella sua definizione più semplice, un gruppo di lavoro può essere identificato come un insieme di due o più persone che interagiscono per raggiungere un obiettivo comune, generalmente caratterizzato da alcuni elementi costitutivi che possono essere così riassunti: un risultato atteso, la definizione di un metodo, l’identificazione di ruoli, l’affermazione di una leadership, la condivisione di modalità di comunicazione e l’emergere di un clima di lavoro. Certo, la letteratura sui gruppi di lavoro è pressoché sterminata e molti addetti ai lavori potrebbero agevolmente criticare, integrare, emendare, smontare e rimontare questa mia definizione. Potrebbero, gli addetti ai lavori, discettare sul tema per ore e ore, per pagine e pagine, con dotta dovizia di particolari e sfumature. Confesso che li leggerei con attenzione, perché il tema mi interessa. Ma qui mi preme evidenziare un dato fondamentale: il “gruppo di lavoro”, per costituirsi come tale, attraversa fasi di sviluppo che richiedono la creazione di coesione fra i suoi membri, basata sulla loro interazione, la quale non può che partire da processi di conoscenza reciproca. In altre parole, qualsiasi lavoro di gruppo prende il via con una immancabile, ineliminabile e inevitabile presentazione di sé agli altri. E così veniamo al punto.
Avevo trentasette anni quando ho cambiato ruolo all’interno dell’azienda di cui faccio parte: già da almeno un lustro io e mia moglie eravamo alle prese con le nostre défaillances riproduttive e, quasi ci fosse bisogno di movimentare un poco la nostra vita personale complicando quella lavorativa, in quel periodo ho accettato una proposta di cambiamento che ci avrebbe portato in un’altra città. Il mio inserimento nel nuovo ruolo sarebbe avvenuto, neanche a dirlo, catapultandomi in un gruppo di lavoro i cui membri erano i futuri colleghi e il cui obiettivo era definire insieme le strategie future della funzione. Un compito sfidante, un gruppo di professionisti di varia esperienza ed estrazione supportati da un facilitatore, un esperto che ci avrebbe accompagnato da essere un’accozzaglia di estranei a un gruppo coeso di colleghi affiatati e proiettati verso un obiettivo comune. Fantastico.
Ricordo bene l’inizio del nostro percorso: convocati per una tre giorni in un accogliente resort nell’Appennino tosco-romagnolo, la nostra prima attività fu la preparazione di una presentazione in cui ognuno avrebbe dovuto fornire ai colleghi quelle che riteneva fossero le informazioni più rilevanti, i tratti che meglio definivano la propria personalità e connotavano la propria storia personale e professionale. La mia presentazione andò molto bene: efficace, ficcante, spiritosa. Riuscii a trasmettere un’immagine di me sufficientemente onesta e accattivante quanto basta. Ma qualcosa non mi tornava. Un piccolo tarlo mi accompagnò fino a sera.
E così, complice un dopocena discretamente alcolico, quando mi ritrovai da solo nel letto sontuoso di un resort quasi di lusso, ripercorsi le presentazioni dei colleghi per rendermi conto che seguivano tutte una costruzione standardizzata, una cadenza precisa e ineluttabile: «Buongiorno a tutti» (esordio), «mi chiamo XYZ» (informazione ridondante poiché ci eravamo già presentati in precedenza e in alcuni casi già ci conoscevamo), «ho X anni e da Y lavoro in azienda» (informazioni a scarso valore aggiunto: l’anagrafe non definisce la personalità, così come l’anzianità aziendale non definisce la professionalità). Rotto il ghiaccio e scaldata la voce, ciascun collega aggiungeva lo stato civile, con due varianti fondamentali: 1) «Non sono sposato/a», con seguito di battuta più o meno sagace sull’attesa dell’anima gemella; 2) «Sono sposato/a e ho N splendidi figli» con seguito di commossa elencazione di nomi ed età, nonché delle più recenti soddisfazioni che le creature avevano portato all’orgoglioso genitore. A seguire il racconto della propria storia professionale: ruolo attuale e incarichi passati, esperienze e competenze maturate, consueti corollari sui meriti propri nel raggiungere gli obiettivi e/o sull’incapacità altrui nel riconoscere il proprio potenziale.
La piccola stonatura – solo a sera, nel letto quasi sontuoso, me ne resi conto – era tutta mia: la declinazione del mio stato civile era rimasta zoppa. «Sono sposato.» Punto. Suona assai diverso da: “Sono sposato e ho due splendide bambine, Irene e Sofia, Irene ha tre anni, Sofia undici mesi… undici mesi compiuti ieri, e dovreste vedere come gattona!”. È quasi una questione di musicalità. “Sono sposato” non ha ritmo, sembra un’incompiuta, una registrazione interrotta prima dell’esplodere della melodia. Avevo provato a introdurre un motivetto orecchiabile: «Sono sposato. Con Giulia. Ci siamo sposati nel ’99». Ma non era la stessa cosa. Mancava qualcosa.
Forse nessuno se ne era accorto né ci aveva dato peso: d’altronde a trentasette anni hai ancora una vita davanti per mettere su una famiglia, e poi, chissà, forse immaginano che tua moglie sia molto più giovane di te, con ancora anni e anni di gioiosa fecondità da vivere con serenità. E invece.
E invece, quel giorno, la presentazione dei membri di un gruppo di lavoro mi ha aiutato a comprendere – sarebbe successo altre volte, così da ricordarmelo di quando in quando – che l’immagine di noi che proponiamo agli altri si compone di pochi tratti, poco più di una carta d’identità: decliniamo le nostre generalità, aggiungiamo il nostro stato civile e la professione e diamo una pennellata di colore con quello che la vita ci ha fino a quel momento riservato.

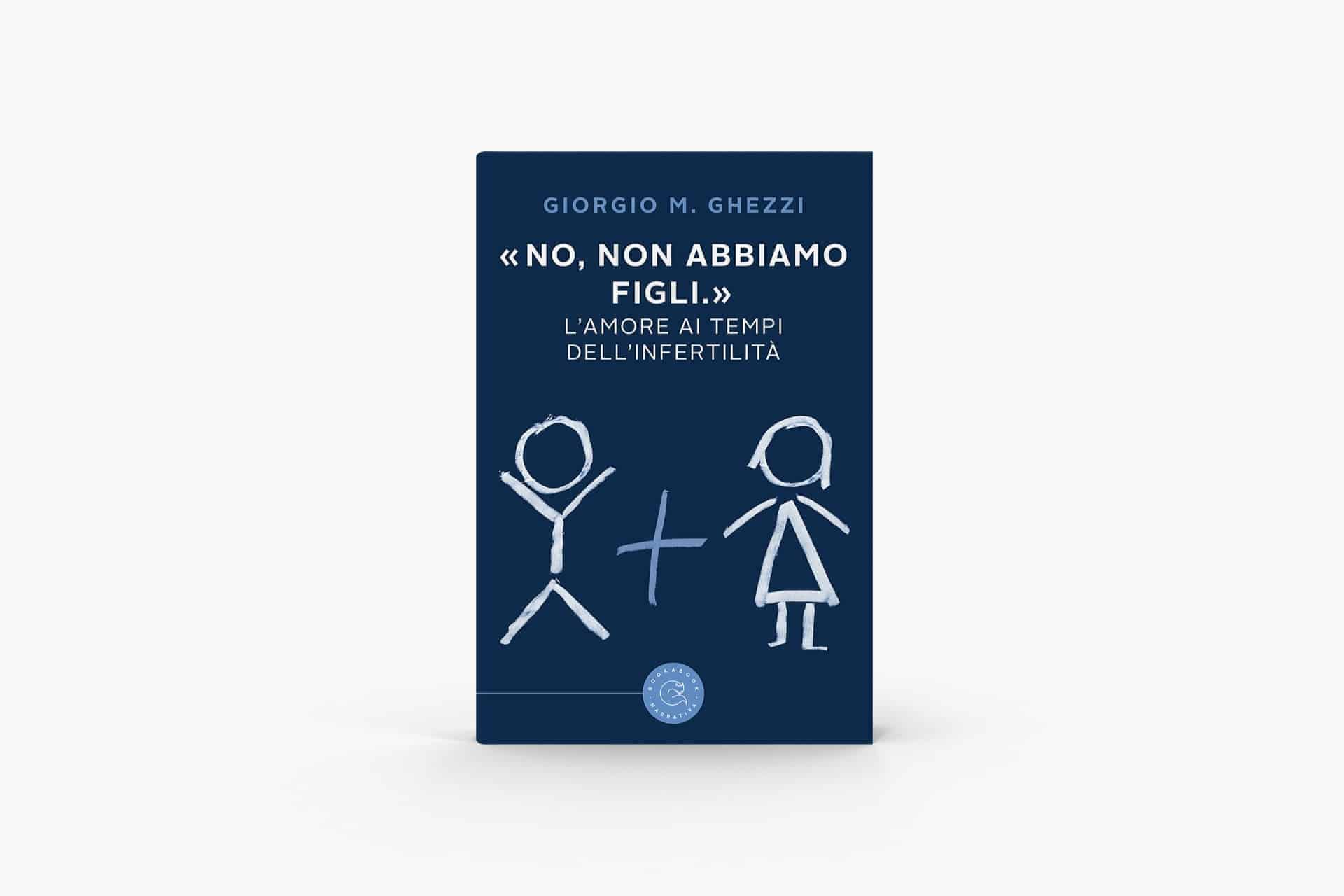


Umile.soldatino
Un libro che dovrebbero leggere tutti perché dà spunti di riflessione per chi ha figli e per chi non ne ha. È un libro sincero, delicatamente commovente e sagacemente ironico che traendo forza da una storia vissuta rende partecipi e permette di vivere (o rivivere se ci si è passati) insieme al narratore i sentimenti tabù di chi non riesce ad avere figli. Un libro di cui si sentiva la mancanza.
wikicecca (proprietario verificato)
Un tema complesso e delicato trattato con sincerità, intelligenza, leggerezza e profondità allo stesso tempo. E non pensiate che sia rivolto solo a chi non ha figli. Io ne ho ma una lettura come questa è preziosa per imparare a non dare niente per scontato. Consigliaterrimo.
cristina.cagliari.e (proprietario verificato)
Una condivisione personalissima e profonda, ironica e a tratti feroce di esperienze, emozioni e sentimenti.
Ho letto il libro in un soffio e ho aspettato a scrivere un commento perché l’ho sentito talmente sotto pelle da restare senza fiato e senza parole.
Ho sorriso al sottile umorismo e agli accenni colti, ho pianto consapevole di essere stata in tempi lontani “a volte vittima e altre carnefice di indelicatezza”. In ogni caso è un sollievo che se ne possa parlare.
Un libro così mancava, grazie Giorgio per il tuo coraggio.
Ora vorrei proporlo a tutti anche se temo di peccare nuovamente di indelicatezza.
Nel dubbio intanto lo rileggo, come qualcuno suggeriva con calma e con un buon bicchiere di vino.
germana_dellicastelli (proprietario verificato)
Un libro profondissimo e sincero: ho apprezzato tanto il coraggio di Giorgio di raccontarsi in modo così vero e schietto, di renderci partecipi della sua sofferenza nella ricerca della paternità ma anche delle soluzioni che ha trovato per superare lo sconforto e dare un senso ai pensieri, alle emozioni, agli accadimenti. Mi sono commossa ed emozionata di continuo nella lettura e le parole di Giorgio mi hanno permesso di mettere a fuoco ancora di più quanto il fatto di poter diventare genitori è un’eventualità, non una certezza né un diritto che ci si guadagna o si acquisisce per merito. L’ho trovato un libro estremamente contemporaneo, in cui moltissime coppie potranno ritrovarsi e trovare conforto. Giorgio ci racconta della sua vita anche con grande ironia e spessore culturale. E lo fa con il cuore aperto, e questo è l’aspetto che, fra i tanti, mi è piaciuto più di tutti!
ameacci (proprietario verificato)
Ho letto la storia autobiografica di Giorgio (e di Giulia) tutta di un fiato! Grazie per l’ironia e la leggerezza (ho riso), grazie per la profondità dell’emozione (ho pianto), grazie per i riferimenti colti che mi rivenderó davanti ad un bicchiere di buon vino ma soprattutto grazie per aver condiviso e perché ora che so non daró più per scontato. Recensendo questo libro, per una volta, non faccio un favore allo scrittore ma a chi lo leggerà!