L’odore acre mi aveva assalito, scavando a fondo nello stomaco e strappandomi conati rabbiosi. La vista di quella melma verdastra, densa e bavosa, aveva quasi innescato una reazione a catena. Per ore avevo strofinato il pavimento con litri di candeggina, nel tentativo disperato di cancellare quell’immagine dalla testa e liberarmi di quell’odore marcio che sembrava essersi infilato nei pori.
L’aria umida pungeva la mia pelle accaldata.
A ogni mio sospiro, nuvolette di condensa si formavano davanti a me.
Mi strinsi nella giacchetta di jeans, ma non bastava a difendermi dal freddo della notte.
Sapevo che quella sera mio padre aveva bevuto più del solito e, a ogni passo, pregavo di trovarlo svenuto sopra al divano: «Non farmi trovare guai» era la mia richiesta costante.
Quando finalmente arrivai a casa, notai subito che le luci erano spente. Un buon segno. Papà, in genere, lasciava tutto acceso, come se fosse più facile continuare a vivere con la luce accesa piuttosto che affrontare il buio della notte.
Stavolta, niente.
Nemmeno il solito bagliore blu della TV che si intravedeva dalla finestra del nostro appartamento, quella luce che sembrava l’unica cosa viva in quella casa. Un silenzio più pesante del solito avvolgeva l’edificio.
Tirai un sospiro, un po’ incredula, ma ormai mi ero abituata anche a questo: il guaio, in fondo, non arriva mai come te lo aspetti.
La porta non era chiusa a chiave. La spinsi piano, quasi con la delicatezza di chi sa che ogni suono può far esplodere il silenzio. Nel buio, mi diressi verso il bagno, come se ogni angolo della casa fosse stampato nella memoria, un percorso già tracciato che non richiedeva nemmeno un pensiero. Dall’ingresso si apriva direttamente sul salone, che non avevamo mai cambiato da quando mamma aveva messo mano all’arredamento. Il divano accanto al vaso di kenzia ormai ingiallita, la parete attrezzata, e il grande tavolo in faggio con le sue quattro sedie.
Ogni cosa al suo posto, come un triste ricordo.
Peccato che molte di quelle cose fossero ormai ridotte in frantumi, proprio come la mia vita. Non vedevo l’ora di buttarmi sotto la doccia calda, immaginando già l’acqua che scivolava sulla mia pelle infreddolita.
Stavo per afferrare la maniglia della porta, quando una mano mi afferrò violentemente per i capelli. «A quest’ora torni a casa?» ringhiò mio padre alle spalle, il suo alito fetido che mi colpì come una mazzata, cogliendomi completamente di sorpresa.
Non lo avevo sentito arrivare. Da dove diavolo era saltato fuori?
Mi teneva la testa indietro, strattonandomi per la treccia mentre mi insultava con tono velenoso.
Sentivo la sua rabbia, una rabbia insensata e incontrollata.
«Ho appena finito di lavorare» provai a spiegare con voce tremante, il cuore in gola, già preparandomi al peggio.
Con una mano cercavo di liberarmi dalla sua presa, mentre con l’altra tenevo stretti i capelli, che tirava come fosse un guinzaglio.
«Te la fai con quel maiale del barista?» urlò, spingendomi contro il pesante tavolo di legno.
Ogni volta riusciva a inventarsi un pretesto per vomitarmi addosso il suo senso di fallimento. Le sue paranoie erano sempre le stesse: gelosia, ossessione, la paura che un giorno me ne sarei andata, alimentando la sua furia.
Il colpo alla schiena mi tolse il respiro, ma non mi arresi. Tentai di scappare, ma inciampai in una sedia che cadde con un rumore sordo. E lui non perse occasione per scagliarsi contro di me, come sempre.
Non ebbi neanche il tempo di rialzarmi che sentii la punta delle sue scarpe conficcarsi nello stomaco. Un dolore lancinante mi paralizzò per un istante, poi mi tirò su con violenza e cominciò a schiaffeggiarmi.
I primi colpi furono acuti, ma presto il dolore svanì. La violenza mi anestetizzava, mentre il ronzio nelle orecchie, simile al fischio di un arbitro, copriva le sue imprecazioni.
Mi rannicchiai, portandomi le ginocchia al petto e proteggendo il viso con le braccia, nel vano tentativo di parare l’assalto. Dopo una serie di calci sferrati a caso, insoddisfatto, mi agguantò di nuovo per i capelli e mi trascinò verso la porta, barcollando.
Dopo la paura iniziale, che aveva sovrastato persino il dolore, restava solo un vuoto emotivo, simile alla rassegnazione.
Il pensiero che mi ronzava in testa era uno solo: Quando finirà? ripetuto come un mantra inutile, mentre la freddezza razionale si faceva strada, cercando una via di fuga che, come al solito, non arrivava affatto.
L’umiliazione cresceva a ogni colpo, camminando fianco a fianco con il senso di impotenza che mi serrava il petto.
Provai a spostarmi, ma il mio corpo tremante, rannicchiato a terra, ostacolava ogni tentativo di liberarmi. Lui, senza esitazioni, riprese a colpirmi con l’anta blindata, come se volesse buttarmi fuori dalla sua vista, come se fossi nulla più di un ostacolo. Ogni colpo mi spezzava di più, ma non c’era respiro, solo il suono del metallo che si infrangeva contro la carne.
Con uno sforzo che sembrò venire da un altro corpo, riuscii a mettermi a carponi. Faticai a muovermi, ma continuai a strisciare, ogni movimento una tortura, fino a raggiungere il pianerottolo. Ma prima che riuscissi a respirare, un ultimo calcio nel sedere mi scaraventò giù, facendomi rotolare giù per i gradini, fino a schiantarmi nel cortile. Un colpo per gradino, e ognuno mi inghiottiva un po di più. Ma la caduta sembrava non finire mai. Quando finalmente toccai terra, il silenzio che mi avvolse era totale.
Per fortuna, a quell’ora non c’era nessuno per strada, tranne qualche gatto randagio che si aggirava come un’ombra. L’autunno avanzato, con l’aria fresca e tagliente, non invitava nessuno a restare fuori troppo a lungo.
Tutto sommato, mi era andata bene: era durata poco, anche se era stato più violento del solito. Rimasi immobile, cercando di stirare i muscoli del viso, ma non risposero. Mi sfiorai le labbra gonfie con le dita, erano insensibili, come dopo un’anestesia dal dentista. L’unico dolore che continuava a spezzarmi il respiro era quello allo stomaco.
Non avevo più lacrime da versare, né rabbia da controllare.
L’abitudine aveva seppellito anche il rancore e la delusione.
Mi sentivo vuota, come un vecchio oggetto abbandonato da tempo.
La cosa che più mi colpiva, però, era l’indifferenza con cui pensavo a mio padre. Come se la sofferenza fosse diventata parte del mobilio che occupa angoli invisibili della casa.
Ero ancora stesa su un fianco quando una leggera pioggerellina iniziò a cadere. Un cane randagio, malandato quanto me, mi si avvicinò e mi guardò con gli occhi indulgenti, come se capisse la mia tristezza. Dopo avermi leccato la mano un paio di volte, mi si sdraiò accanto.
«Ciao piccolo» sussurrai, con la voce rotta dalla sofferenza che ogni movimento mi procurava. L’aria era impregnata dal profumo della pioggia e delle foglie umide, ma dal marciapiede sentivo anche l’odore pungente della pipì dei cani.
Una grossa macchia ingiallita alla base del primo gradino, dimostrava che quello era uno dei loro pit stop consueti.
Il mio piano era semplice: restare lì finché non fossi riuscita ad alzarmi, poi trovare un angolo qualunque nel parco e aspettare l’alba. Di solito finiva così, raggomitolata nel bagno pubblico, seduta sulla tazza con la testa appoggiata alla porta sudicia.
Una sistemazione di tutto rispetto.
Il cane vicino a me sospirò, accovacciandosi meglio dopo un paio di giri su se stesso. «Non dovresti bagnarti» gli sussurrai. «Stai già messo male.» Allungai una mano tremante per accarezzargli la zampa, grata almeno di quella compagnia.
Avevo sempre desiderato un cane, ma mia madre aveva trovato ogni volta una scusa: troppo impegnativo, troppo sporco, troppo di tutto. In realtà detestava l’idea di avere un animale in casa. Sentii delle voci in lontananza. Qualcuno si stava avvicinando, e non volevo che mi vedessero lì, buttata a terra come un mozzicone di sigaretta.
Se mi avessero scambiata per un’ubriaca, forse avrebbero provato a infastidirmi. Se avessero capito la verità, sarebbero partite chiamate, domande, rogne che non potevo permettermi. Ancora qualche mese e sarei stata maggiorenne. La luce in fondo al tunnel era vicina, non volevo inciampare proprio adesso. Provai ad alzarmi, raccogliendo le forze rimaste. Il cane si spostò appena, guardandomi con aria giudicante quando un piccolo lamento mi sfuggì.



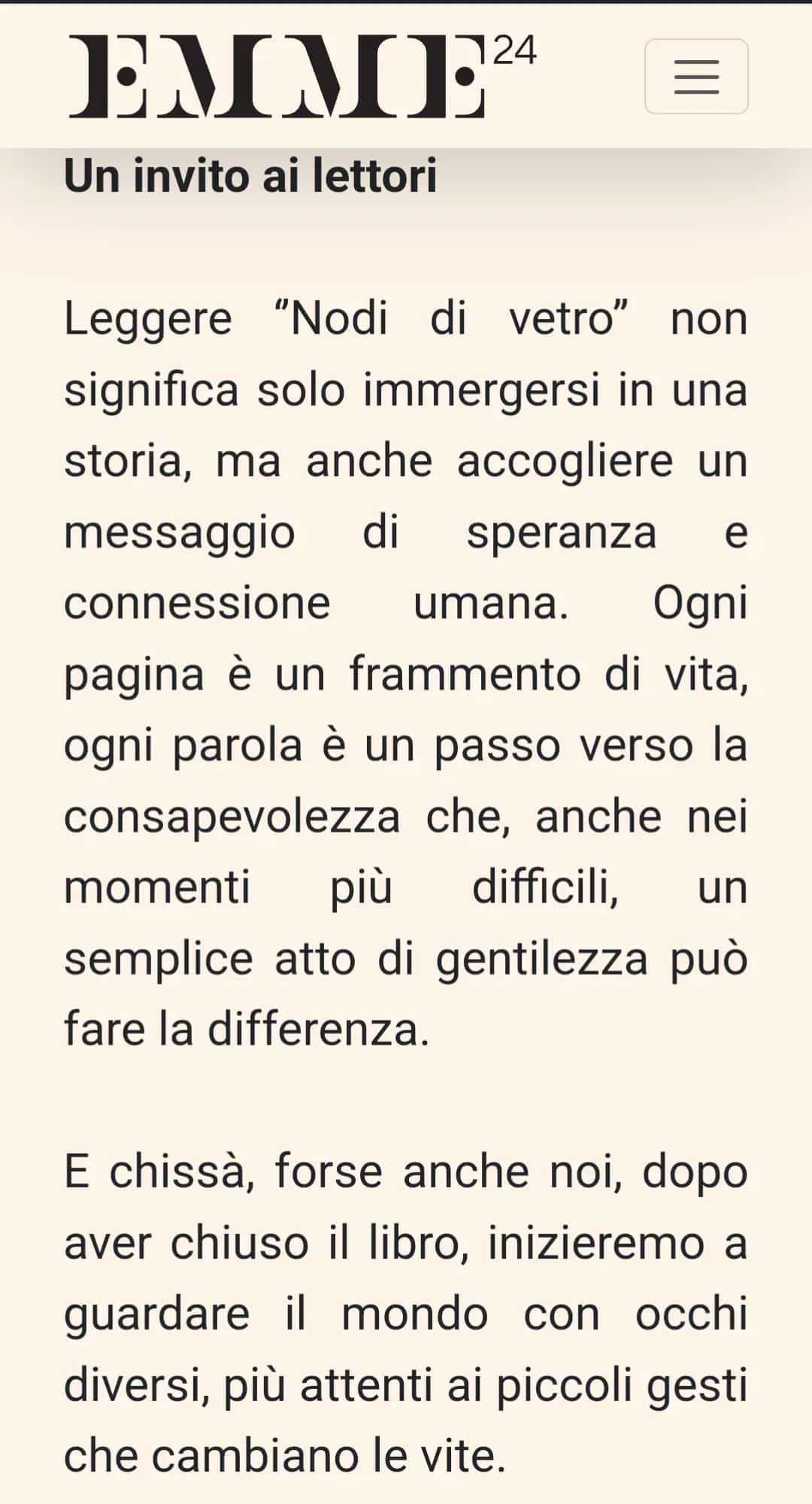




Commenti
Ancora non ci sono recensioni.