CAPITOLO 1
E ADESSO?
Una settimana. Un periodo di tempo ciclico della durata di sette giorni, ciascuno dei quali èda intendersi come giorno solare medio costituito esattamente da ventiquattro ore.
Continua a leggere
Quante volte da ragazzo ho visto una delle tante settimane andare via come il vento, senza nemmeno sentire la traccia del suo passarmi oltre. Quante ne ho perse. Quante ho sperato di non vederne. Quante di non ricordarmene una volta finite.
Quando c’è la vita, una settimana è come un granello di sabbia perso in una spiaggia. Insignificante e inutile. Impossibile notarne la presenza. Eppure c’è. E la differenza la fa. Da bambino non lo capivo. A dirla tutta nemmeno mi ponevo questo genere di problemi.
E invece ora? Dovrei? Che fare? Preoccuparmene? Trattarla alla stregua di quelle passate?
Mah, no. Non posso di certo farlo. O no?
Sono in ritardo di una mezzora buona dall’appuntamento con quello stronzo del mio editore. Sì, Mario Civetta. Ma dico io: puoi chiamarti Civetta e pubblicare libri? Se si legge di fretta il cognome, con mille altri casini per la mente, si può addirittura confonderne le lettere e metterci un bel “Cilecca”. Sì. Un bel “Mario Cilecca”. Che poi, a dirla tutta, gli si addice parecchio.
Non dovrei parlare così dell’uomo che mi pubblica i romanzi, dice mia figlia Sofia. Mi dice in continuazione, le volte che riesco a passare del tempo in sua compagnia, «Papà, non puoi dare del figlio di puttana al tuo editore, come pensi che ti farebbe sentire se scoprissi che lui alle tue spalle, magari con i suoi figli, ti chiamasse “Timbretto”, eh?».
E sbuffa. Sbuffa sempre troppo quella ragazzetta di vent’anni. Ma dico io, che avrà mai da sbuffare sempre, alla sua età. Io mica lo so se sbuffavo così tanto alla sua età. Io non sbuffo. Semmai, soffio. Sì, forte, con una bella potenza di narici. E poi sparo parolacce. Una dietro l’altra. Ma sempre mia figlia, mi riprende: «Papà, sei uno scrittore. Diamine» (che usi vocaboli come “diamine” mi fa ridere, di gusto. Anzi, io non rido. Soffio. Sì, dalle narici.); e poi prosegue: «Devi parlare bene, questo si aspettano da un personaggio della tua categoria. Altrimenti, se volevi dire tutte quelle parolacce, te ne sceglievi un’altra».
Io non sono d’accordo con Sofia. Né sul fatto che il mio editore possa insultarmi a mia insaputa dandomi del “timbretto da strapazzo”, storpiando peraltro un cognome con una sua dignità, né tantomeno ritengo che ci abbia preso con la questione della categoria, che non me la sono scelta io, ma mi ci sono ritrovato, vorrei sottolineare, e che le parolacce sono come il pepe sulla cacio e pepe. Uno scrittore deve, e sottolineo deve, mettersi in bocca quante più parolacce possibili. È segno di onestà, questo è risaputo, e io sono un paroliere o che so io, uno insomma che per campare s’è messo a vomitare parole che insieme stiano bene, e nel farlo non ho peli sulla lingua né tanto meno mezzi termini. Se mi va di dire «Cazzo», lo dico.
Cazzo.
E se mi va di dire «Porca puttana, questa è una cazzo di sfiga», lo dico. Con tanto di sottolineatura. Perché come altro si può descrivere la mia situazione? Sfiga. Una cazzo di sfiga.
Comunque, sono in un fottuto ritardo. E che sia fottuto il ritardo bisogna proprio dirlo, altrimenti non lo si chiamerebbe “ritardo”, si direbbe “una bella scampata”. Invece niente, sto in ritardo, sono con la mia vespetta che di portarmi dall’altra parte di Roma, nello specifico a piazza Mazzini, al bar che ha una saletta rialzata, non ne vuole sapere.
Fa più capricci di mia figlia Sofia, ma almeno lei non mi dice che devo smettere di mettermi in bocca parole scomode.

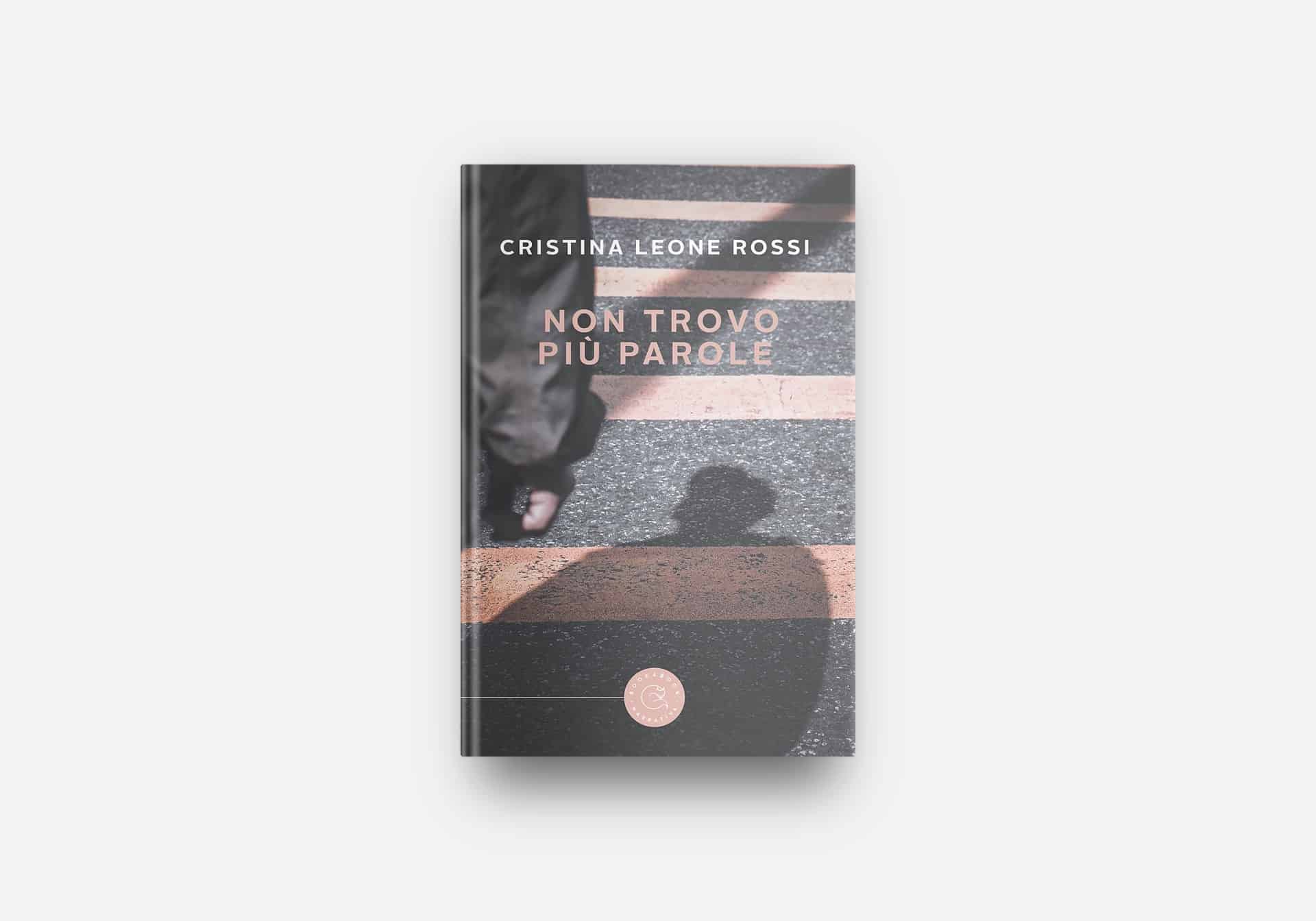



Federico Riccardo (proprietario verificato)
Un grande esordio!