I. RISVEGLIO
Una luce accecante nell’oscurità. Forse è questo che percepisce un bambino strappato via dal ventre della madre, da un nulla indefinito senza tempo e senza nome, e scaraventato in un nulla che ci illudiamo sia tutto. Gli occhi si schiudono da un lungo sonno, il cuore palpita fragorosamente, il primo vagito spalanca le porte della vita: è così che assaggiamo per la prima volta la paura dell’ignoto, tra un turbinio di emozioni contrastanti, gettati in un mondo che non ci appartiene.
Questa sensazione è quanto di più simile a ciò che sperimentai quel dì nefasto, le cui tracce sono ormai sbiadite nella mia memoria, quando fui rapito alla vita e mi risvegliai in questo luogo. Non mi resta molto tempo, presto verranno a prendermi: chi siano e da dove vengano non so, né perché mi abbiano rinchiuso qua. Forse qualcuno leggerà la mia storia, scritta su queste immense pareti che mi circondano da quel lontano giorno. Allora ricordavo ancora il mio nome.
</p>
II. PANE E INCHIOSTRO
Il sapore del pane, il sibilo del vento, il fruscio delle foglie, il calore del sole, le risate dei bambini: immagini sfocate, frammenti di un passato perduto, di quando si viveva là fuori.
Come un cieco mi faccio strada tra i ricordi dell’uomo che ero, scrollando le vesti di anime mute, che non mi parlano e non ascoltano più: e mi sovviene la vicenda di quell’eroe greco, Orfeo, un folle che credeva di poter riportare in vita la compagna defunta, ma che per l’ansia di riaverla la perse per sempre. Così brancolo tra i fantocci del mio passato, cercando risposte. Ma, come mi volto a interrogarli, svaniscono nei meandri della mia psiche.
Eppure, tra tutti, un ricordo si staglia vivido davanti ai miei occhi, e non fugge: una distesa boschiva appare in lontananza, come un’ampia macchia dalle tinte rosse, gialle e ocra sulla tavolozza di colori di un pittore maldestro. Il sibilo del vento si diffonde per il bosco e la campagna circostante, portando sin qui il respiro della foresta e accarezzando la mia pelle, una sensazione piacevole che non avvertivo da molto tempo: dev’essere autunno. Provo un fastidio alle pupille, che mi costringe a chiudere per un attimo le palpebre: non ricordavo più che effetto potesse avere la luce del sole sugli occhi, il calore che riscalda la mia pelle. Sento dei passi alle mie spalle e delle risa, mi volto e scorgo una grande casa di campagna, di quelle col tetto spiovente in mattoni, ampie finestre luminose e un piccolo terrazzo che dà sulla strada: dei bambini giocano proprio lì, sul terrazzo di quell’abitazione, che non ricordo di aver mai visto nonostante mi appaia familiare. Questi ragazzini sono così spensierati: uno di loro ha un grande cappello di paglia, le lentiggini sul viso rotondo, una chioma bionda e orecchie a sventola, sembra essere il più grande. Gli altri due, altrettanto grassi e pieni di sé, ma visibilmente più piccoli di quello che pare essere il loro leader, giocano tra loro con una palla di stoffa consumata e rattoppata.
Ma, più di tutti, mi colpisce un ragazzino diverso dagli altri, seduto all’ombra di un pino, poco lontano dai suoi coetanei: ha un’aria malinconica, il viso scarno e le braccia ossute, deboli. Indossa una maglia consunta dal tempo e un pantaloncino di velluto bluastro, unico capo elegante su quel corpicino così cagionevole.
Quelle fragili mani sono tutte prese in un’attività che sembra assorbirlo completamente: tiene una pergamena in una mano e ci scrive sopra con una penna d’oca, intingendola freneticamente in un calamaio ai suoi piedi.
Accanto a lui un cesto con del pane, fresco, croccante, molto diverso da quello che… Mentre mi lascio andare a questi pensieri, improvvisamente si volta a guardare verso di me, come impaurito, con dei grandi occhi verdi e uno sguardo penetrante come la lama di un coltello. Ma proprio allora la visione si interrompe bruscamente e vengo riportato alla mia squallida realtà da un suono stridulo che ho imparato a conoscere fin troppo bene: il rintocco che batte l’ora del pranzo.
Prima di uscire dalla cella, però, noto sul pavimento il calamaio e solo un tozzo di pane: ho dovuto barattare il resto per avere altro inchiostro.
III. L’ORA DEL RANCIO
Le giornate nella prigione sono scandite dal suono assordante della campana della torre di osservazione, secondo un sistema di intervalli regolari: un rintocco secco batte l’ora del pranzo, in un luogo che qui chiamano il “porcile”. Ci radunano tutti in un corridoio stretto e lungo, buio e maleodorante, che conduce sino a una sala coi tetti bassi, incrostati di muffa e fatiscenti. L’aria è resa irrespirabile dal fumo denso che viene dalle cucine e dal lezzo delle stesse vesti con cui ci siamo risvegliati qui dentro: è tutto ciò che ci lasciano della vita di prima.
Alcuni di noi sono arrivati qui da poco, e non ricordano nulla del loro passato. Altri hanno ricordi confusi, vaghi, e vi si ancorano ben stretti, come fosse il loro tesoro più prezioso, diffidando di tutti e di tutto qui dentro. Altri non ricordano più neanche il loro nome: io appartengo a quest’ultima categoria. Ma tutti abbiamo una cosa in comune: non sappiamo il motivo per cui ci troviamo qui, di quale colpa ci siamo macchiati per finire in quest’inferno, né chi ci abbia trascinati in questo luogo.
Ognuno ha la propria teoria sui guardiani delle prigioni: alcuni dicono siano uomini brutali, ricchi e potenti, capaci di tutto; altri credono persino che dietro le loro armature nere come la pece si celino creature abominevoli, assetate di sangue umano, e attribuiscono a questo le sparizioni di alcuni detenuti. Si tratta solo di storie, dicerie, che tengono impegnate le nostre menti per non rischiare di impazzire in questo labirinto senza uscita: o almeno così preferisco pensare. Quel che è vero, però, è che quotidianamente qualcuno scompare: nel caso in cui riesca a fuggire, nessuno ritorna per raccontare dove sia stato, e come biasimarlo.
In un tempo che mi appare oggi remoto, un uomo catturò la mia attenzione tra i detenuti: non sembrava uno di noi. A differenza degli altri prigionieri, era un signore distinto, sulla mezza età, in giacca e cravatta, pantaloni di seta nera e un paio di scarpe da passeggio. Portava con sé una ventiquattrore da lavoro. Mi incuriosì il suo portamento elegante, impeccabile, in un luogo come quello e davanti a un pasto ripugnante. Mi avvicinai per osservarlo meglio, qualcosa mi affascinava in lui.
«È veramente un pasto disgustoso, dico bene?» mi disse, con un tono di voce caldo, protettivo, paterno.
«Nulla di diverso dal solito, patate crude e pezzi di interiora andati a male!» risposi io, colto di sorpresa.
«Almeno ci lasciano anche il pane.»
Come avrei potuto dargli torto. «Da quanto tempo sei qui?» gli chiesi, abbassando lo sguardo, con un inconsueto sentimento di riverenza.
«Be’, da quando i miei capelli erano ancora folti e neri. Ormai, come vedi, la calvizie ha cominciato il suo lento processo.»
La fronte ampia e nuda confermava le sue parole, pronunciate con una dose di amara ironia.
«E… della tua vita di prima ricordi qualcosa?» chiesi io, curioso di conoscere la risposta di quell’uomo così bizzarro.
«Non molto… Ricordo di essermi svegliato qui, con una ventiquattrore in mano e quest’abito indosso. Da allora non l’ho più tolto, è l’unica cosa che mi è rimasta del mio passato, chiunque io fossi. Sono invecchiato qui dentro, e in tutto questo tempo trascorso a riflettere in prigione sono riuscito a ricordare soltanto un episodio di là fuori, sempre che non me lo sia immaginato, che mi tormenta ormai da anni.
«La notte dopo il “risveglio” avevo un gran mal di testa, e ho deciso di addormentarmi prima del solito. Ed è stato allora che la mia mente ha cominciato a ricordare: dei volti di fanciulli in lacrime, che mi dicevano “Padre, non lasciarci!” e una donna dai capelli bruni, alta, bellissima, ma con gli occhi spenti. Mi sembrava di conoscerla da molto tempo, eppure non mi guardava. In mano avevo la mia ventiquattrore e quest’abito addosso: davanti a me una porta massiccia, spalancata. Gli istanti trascorsi sulla soglia mi parvero interminabili, il corpo e la mente erano come paralizzati; avrei voluto dire qualcosa a quella donna, a quei poveri fanciulli, ma la lingua era come intorpidita, le labbra serrate, incapaci di emettere alcun suono, per quanto mi sforzassi. Quindi i miei piedi ricominciano a muoversi, come dotati di vita propria, un passo dopo l’altro, al di là della soglia, un passo dopo l’altro, vorrei fermarmi, tornare da quella gente, parlare con loro, ma una forza misteriosa mi conduce lontano, un passo dopo l’altro, non sono più padrone del mio corpo, la voce si strozza nella gola, un passo dopo l’altro, e quel pianto di infanti si fa sempre più flebile, come un’eco che parte da lontano e via via si dissolve, un passo dopo l’altro, il mio animo vorrebbe gridare, scalciare, scoppiare, un passo dopo l’altro: poi, tutto tace. Allora il sogno si è interrotto, e mi sono svegliato di soprassalto, con una grande amarezza nel cuore e un fardello da cui non sono più riuscito a liberarmi.
«Tante volte mi sono chiesto il significato di quella parola, “padre”: quando la pronuncio è come se l’animo si riempisse di una sensazione di dolcezza, non riesco a spiegarne la causa, ma quelli sono gli unici attimi in cui riesco a sorridere e a dimenticare il mio tormento! Ed è da quella notte che qui dentro tutti mi conoscono col nome di “padre”. Darei qualsiasi cosa per rivedere i volti di quei fanciulli, per chiedere loro chi siano e chi sia io, ma ormai ho abbandonato ogni speranza…»
Dette queste parole, il suo volto si incupì, mi rivolse un cenno di saluto, e si diresse verso il corridoio che portava alle celle, con la sua ventiquattrore in mano.
Improvvisamente avvertii una strana morsa al cuore, e mi misi a correre verso di lui urlandogli: «Padre, aspetta!». Ma quando raggiunsi il corridoio era già sparito nell’oscurità della prigione.
Se n’è andato, pensai, colto da un profondo e inspiegabile senso di vuoto e attanagliato dal dubbio che quell’uomo avesse omesso qualcosa. Non c’è più nulla che io possa fare.
E mi allontanai anch’io, un passo dopo l’altro.


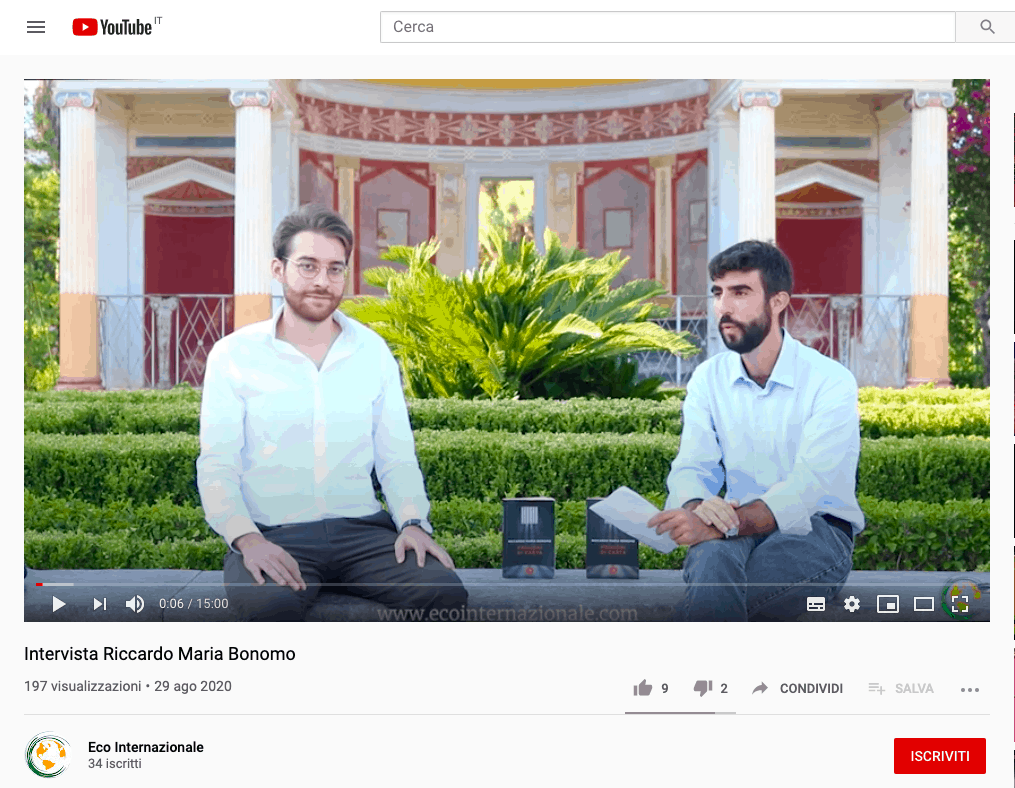



andreacarla.ajello (proprietario verificato)
Il solo fatto che questo romanzo non sia facile da classificare in un genere ben preciso lascia capire che sia piuttosto singolare. Fantasy, psicologico, distopico..o tutte queste cose assieme. L’intento dell’autore è sicuramente quello di guidare il lettore attraverso un viaggio negli abissi della propria coscienza e offrire spunti di riflessione sulle proprie scelte e sulle conseguenze che queste hanno sulla propria vita. Sono le scelte che fai a determinare chi sei: questo è uno dei messaggi più importanti che il romanzo mi lasciato e non è mai troppo tardi per essere ciò che vuoi essere. Gabriel attraverso questo viaggio riacquisisce la sua identità e molto di più, impara a conoscere le sue paure, i suoi limiti e i suoi punti di forza e solo accettandoli riesce a superare sé stesso , rinnovandosi come persona agli occhi di tutti gli altri e soprattutto di sé stesso. Il motivo per cui questo romanzo andrebbe letto risiede nel fatto che non può annoiare né deludere nessuno dal momento che ogni lettore può trovarvi le proprie risposte. Il tutto è raccontato con una scorrevolezza e una capacità narrativa fresca , frizzante che fa sì che il lettore si immedesimi nei personaggi a tal punto da voler sapere come andrà a finire la vicenda di ciascuno di loro. Per tutte queste ragioni vi dico che se volete leggere un libro accattivante e allo stesso tempo che vi aiuti a riflettere su voi stessi, dovreste senza dubbio aggiungere questo romanzo sul vostro scaffale.
Sara Rubino (proprietario verificato)
Questo libro può essere definito come una continua ricerca di risposte alle mille domande che ci poniamo. Andando avanti si trovano altre domande. Effettivamente, che vita sarebbe se finissimo le domande?
Tratta forse della paura più comune specialmente tra i giovani, la paura di essere se stessi. Ho vissuto questa paura in prima persona e mi sono ritrovata nel libro, questo mi ha fatta sentire meno sola e mi ha aiutata a pormi le domande giuste. La chiave siamo noi e questo libro ne è una dimostrazione.
Nonostante il tema possa sembrare pesante vi è anche sarcasmo, sorpresa e tanta scoperta.
La lettura è scorrevole, una parola segue l’altra senza farti mai annoiare. Consigliatissimo!
martinaburrafato (proprietario verificato)
Prigioni di Carta è un libro particolare: è molto più di quello che vuole apparire. È intrigante con la sua atmosfera cupa di prigione nascosta e segreta. Questo mondo di carta è pieno di prigionieri che perdono la memoria e dimenticano chi siano stati, cosa abbiano fatto e le persone che hanno amato. È forse l’incubo in cui nessuno vorrebbe essere intrappolato ma è anche probabilmente la paura più comune. È un mistero che si attorciglia su se stesso nella continua ricerca della propria memoria, o di qualunque cosa possa condurre alla luce in fondo al tunnel. È il tentativo di lottare contro le proprie paure e contro un mondo che non si conosce, e la speranza di uscirne fuori con qualcosa che abbia ancora valore.