Glucksmann, se dovesse svettare, diventerebbe uno splendido esempio, ma oltre a essere personaggio molto originale, è anche molto francese. E questo libro spiega bene quanto la Francia sia diversa dall’Italia. Per esempio nella sua classe dirigente. In Francia gli intellettuali pesano nella discussione pubblica e non sono diventati, come da noi, appendici e megafoni della politica.
Ma proprio la configurazione istituzionale-elettorale finirà per tracciare il percorso di Glucksmann. Gli autori auspicano che l’ascesa del leader di Place Publique possa far scuola dalle nostre parti, dove in effetti la sinistra ha una configurazione movimentista e demagogica in tutte le sue anime: non era mai successo dal 1945 in poi. Ma intanto è Glucksmann che dovrà chiarire cosa voglia fare “da grande”.
Quel che di lui sappiamo con certezza riguarda la sua “mobilità”: come molti “millennians”, lui, che appartiene a un’altra generazione, non si adatta ai ruoli fissi e dopo un po’ sente il bisogno di cambiar vita. Ha lasciato – e non era scontato – i filosofici porti paterni e ha fatto la scelta della politica, prima parlando con il “noi”, poi prendendosi le sue responsabilità di leader politico. Ma anche il suo tragitto non è stato rettilineo: Alternativa Liberale, Nicolas Sarkozy, Benoît Hamon – ex socialista di sinistra dalle molte sconfitte –, Place Publique, ora gruppo europeo socialista e democratico. Lui sa bene che nel percorso che può portarlo all’Eliseo per le “mezze ali” esistono regole obbligate.
E d’altra parte le spine lungo il percorso sono visibili. Sebbene si sia spesso interessato al destino delle “persone comuni”, finirà per pesare il suo DNA “bobo”, così come la sua posizione su Gaza non lo aiuterà in una gauche ricca di manicheismo “pro pal”. Gran parte del suo futuro, Glucksmann se lo giocherà al primo turno presidenziale: se conquisterà il primo posto tra i candidati di sinistra e di centro-sinistra, al secondo turno la disciplina repubblicana difficilmente lo tradirà. Ma per conquistarsi la rampa di lancio, Glucksmann difficilmente potrà ignorare il consiglio del vecchio Jacques Attali, uno tra gli intellettuali più longevi della scena pubblica francese: “Non deve apparire come un lupo solitario, deve rassembler”.
Destino e Storia
(di Roberto Sajeva)
Quando ero giovanissimo, diciamo circa una ventina di anni fa, la politica italiana era fortemente influenzata, sia in senso positivo che negativo, dall’11 settembre, dal movimento no global, dal movimento pro global, e così via. Tuttavia, in Italia mancava – e manca tuttora – una classe culturale all’altezza. Questo perché la classe culturale italiana è fondamentalmente postcomunista e non ha mai fatto, come si suol dire, i conti con i propri errori. Dall’altra parte, la destra italiana è una destra che, per fare un esempio, cita Prezzolini, che è certamente una figura intelligente, ma di certo non un filosofo, un intellettuale, o un colosso su cui fondare un’identità culturale solida.
Di conseguenza, in Italia c’era, e c’è tuttora, un unico punto di contatto tra la sinistra e una destra liberale: il Foglio di Giuliano Ferrara. Ci ha provato anche il Riformista a ricoprire questo ruolo, ma più che altro si è limitato a fare da “grillo parlante” all’orecchio sordo del PD, offrendo molti buoni consigli dedicati più al pre-PD – cioè ai DS e alla Margherita – che al PD stesso. Ma perché faccio riferimento a questi discorsi?
Perché ciò che in Italia era un dibattito limitato ai giornali – essenzialmente ai due sopracitati, il Riformista e il Foglio – ovvero una riflessione sulle alternative politiche da costruire nel nuovo millennio nel contesto della “superpotenza unica” (che già allora doveva confrontarsi con il multipolarismo, embrione di ciò che oggi è una realtà consolidata), in Francia, invece, era portato avanti dai grandi filosofi. E in Francia i filosofi sono personaggi pubblici.
In Italia, al contrario, abbiamo solo figure come Cacciari o, in parte, Galimberti. Tuttavia, il campo di studio di Cacciari è piuttosto di nicchia e sembra non armonizzarsi molto con la sua identità politica, che cerca invece di essere pragmatica e mainstream. Galimberti, invece, si dedica prevalentemente alla divulgazione dei temi a lui cari, senza un reale impatto sul dibattito pubblico.
I filosofi francesi, invece, si impegnano sia nella traduzione della loro filosofia in termini politici sia nell’educazione del pubblico e dell’elettorato. In Francia, infatti, esiste un’espressione legata all’elettorato che in Italia sembra quasi assurda o utopica: si parla, infatti, di “elettorato razionale”. Un concetto che è centrale nella nascita di Place Publique.
A questo punto, è necessaria una piccola digressione sulla politica francese.
Ah! ça ira
La nazione francese si trova attualmente nella sua Quinta Repubblica. Come noto, le Repubbliche francesi non si avvicendano in maniera paragonabile a quanto accaduto con la nascita della nostra “Seconda Repubblica” (espressione puramente giornalistica, solo successivamente scientifica, per comodità): ovvero un cambio di attori politici e istituzionali, di legge e dinamica elettorale, eccetera. Certo, il cambio di passo non è stato affatto banale, dato che quei partiti potevano vantare una parte nella vittoria nella Seconda guerra mondiale, erano autori e referenti della Costituzione, rappresentanti dei vincoli interni e soprattutto esterni. Ma tutto sommato, strutturalmente, la Repubblica italiana è rimasta la stessa: la prima e unica Repubblica, nata con il Referendum del ’46 e battezzata con la Costituzione del ’48.
In Francia l’espressione è invece molto più tecnica e segnala discontinuità profonde.
Dopo la Seconda guerra mondiale, si stabilì nell’Esagono la Quarta Repubblica, che crollò nel ’58 a causa della crisi algerina e dell’incapacità di gestire la questione coloniale. Fu allora che riemerse Charles de Gaulle, il quale, tra il 1958 e il 1962, introdusse una nuova riforma costituzionale, dando vita alla Quinta Repubblica.
Oggi, la Quinta Repubblica ha superato per durata la Terza Repubblica (1870-1940) e rappresenta quindi il periodo istituzionalmente più stabile e coerente della Francia a partire dalla Rivoluzione francese. Tra Napoleone, Restaurazione e altri eventi storici, non si era più vista una tale continuità istituzionale, nonostante la Quinta Repubblica abbia attraversato momenti di grande tensione: tentativi di colpi di stato, decolonizzazione, attentati, ribellione parlamentare contro il presidenzialismo, il Sessantotto (che in Francia fu molto più radicale che in Italia), eccetera eccetera.
È importante soffermarci un istante sulla figura di De Gaulle, perché fu lui, che vantava la vittoria nella Seconda guerra mondiale, a creare una Repubblica a sua immagine e somiglianza. Mentre i vincitori italiani (i partiti riuniti in comitato) avevano dato un’impronta costituzionale consensualistica e socialmente partitocratica (parlamentarismo con esecutivo debole), De Gaulle, uomo solo al comando, costruì un sistema presidenziale fortissimo, quasi monarchico. La Costituzione francese, nata in opposizione ai partiti, attribuì al presidente un ruolo centrale, relegando il Parlamento a un ruolo marginale.
Fino agli anni Ottanta, i partiti in Francia non avevano nemmeno uno statuto giuridico: erano semplici associazioni, flessibili ma anche facilmente eliminabili. In effetti, per ragioni di ordine pubblico, era comune che un partito venisse dichiarato fuorilegge. Questa debolezza istituzionale riguardava anche i sindacati, riflettendo un problema comune ai corpi intermedi europei, che spesso preferivano non istituzionalizzarsi per evitare non solo il rischio del corporativismo, ma anche lacci e lacciuoli. A dire il vero, questo accadde anche in Italia, dove allo stesso modo non si ebbero partiti e sindacati pienamente formalizzati: qui, però, avvenne proprio perché la loro autorevolezza si nutriva di ambiguità.
De Gaulle criticava apertamente i partiti, preferendo invece comitati elettorali e gruppi di consiglio politico che lo supportassero alle elezioni.
In Francia tutto ruota attorno alla Presidenza, mentre il Parlamento è un organo con un potere limitato, che esercita una rappresentanza imperfetta e ha poca influenza decisionale. Persino il budget nazionale è gestito dall’esecutivo. Il Parlamento ha tuttavia un margine di controllo sull’esecutivo, la mozione di censura, anche se raramente viene utilizzata: se troppo reiterata destabilizzerebbe il sistema e minerebbe anche la posizione di visibilità dei parlamentari, i quali, pur essendo in buona sostanza inutili, ottengono un’importante esposizione pubblica grazie al loro ruolo.
In questo contesto, il Parlamento francese è uno strumento di visibilità più che di potere decisionale. È interessante notare come, al contrario dell’Italia, i partiti francesi non siano mai stati centri di formazione della classe dirigente. E questo è uno dei motivi centrali della digressione, perché è un argomento forte dei nostalgici della partitocrazia italiana nonché un punto caro ai populisti francesi.
In Francia, la formazione della classe dirigente passa per le scuole di eccellenza come Sciences Po e l’École Nationale d’Administration (ENA), istituzioni che però sono finite sotto accusa per la loro esclusività e per aver creato una casta (endogamica) di “mandarini”. Tutto ciò riflette un sistema politico burocratico, un apparato concentrato sulla figura del presidente, ovvero l’ambizione massima (e forse minima) di chiunque entri in politica. Una destinazione.
In Francia, il concetto politico di base è infatti il destino. La Francia è un Paese convintamente universalistico, che pensa di avere un destino nel mondo. Gli elettori, o meglio, gli uomini politici, parlano di destino nazionale quando si riferiscono alla propria carriera politica. Il destino è la parola chiave. In Italia la parola chiave sembrerebbe invece essere “storia”, siamo un Paese storicistico in cui il filo rosso che conta è quello che lega il presente al passato, ai principi piuttosto che alla destinazione. Da qui l’evidente crisi di missione connaturata alla nostra nazione. Che ci stiamo a fare qui? La Francia di voto in voto prova a rispondere (spesso male!) a questa domanda che noi però neanche ci poniamo.
La Presidenza della Repubblica francese è il mandato diretto più importante in Europa, nato come simbolo di disintermediazione e di contrasto al parlamentarismo. Il presidente utilizza strumenti come il referendum non tanto per promuovere la democrazia diretta, ma per scavalcare il Parlamento, consolidando il suo potere decisionale.
La popolazione francese, consapevole di questo sistema, ha sviluppato strategie per influenzare il potere presidenziale. Una di queste è l’uso della violenza politica, che in Francia ha un ruolo storico e culturale. Episodi come quelli dei gilet jaunes sono esempi di proteste razionali in cui il popolo utilizza la violenza come strumento dialogico per ottenere risultati. Questa dinamica è profondamente diversa da quella italiana, dove la violenza politica è stata in gran parte dissolta o relegata a contesti estremi e in cui la contestazione avviene per pancia più che per calcolo.
Anche il sistema elettorale francese riflette questa peculiarità. Un noto motto recita: “Al primo turno si sceglie, al secondo si elimina”. Mentre in Italia vige una costante lotta tra ingegneria elettorale ed elettorato, che finora si è manifestata più o meno in questa evoluzione: voto utile, voto di protesta, astensionismo secondo il motto “tanto peggio tanto meglio”.
Le elezioni presidenziali francesi, con il loro sistema maggioritario a doppio turno, riducono il peso dei partiti e favoriscono un’elezione plebiscitaria del presidente. Le elezioni intermedie, invece, sono spesso utilizzate come strumento per inviare segnali politici. Per esempio, è comune che in alcune regioni elettori di sinistra votino per l’estrema destra in elezioni locali considerate irrilevanti, solo per influenzare il dibattito nazionale in vista delle presidenziali. A dire il vero, questo accadeva maggiormente fino a qualche anno fa, prima della nuova riforma degli enti locali, ma lo scarso radicamento di Macron nelle amministrazioni non lascia ancora capire se qualcosa sia cambiato davvero.
Questo contesto elettorale ha reso possibile il recente slancio di Raphaël Glucksmann, entrato in campo grazie alle elezioni europee che, essendo basate su un collegio unico proporzionale, permettono una rappresentazione più vicina al panorama politico complessivo.
I socialisti, intesi come socialisti democratici, riformisti, in Francia sono in genere una minoranza a sinistra. Solo in alcune fasi hanno ottenuto più voti dei comunisti o dei socialisti massimalisti. Tuttavia, i socialisti sono gli unici che riescono sempre a organizzare le coalizioni per far vincere la sinistra. François Mitterrand è il caso più famoso, con l’Épinay, il Congresso di unificazione della sinistra. Il tentativo che sta facendo ora Glucksmann è proprio questo: per l’ennesima volta, in Francia, c’è un forte revival massimalista, e quindi si cerca di cavalcare quest’onda. Bisogna vedere se questa scommessa avrà successo. O se sarà possibile inventarsi una via alternativa verso Palais de l’Élysée.
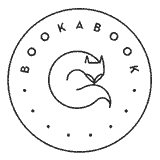
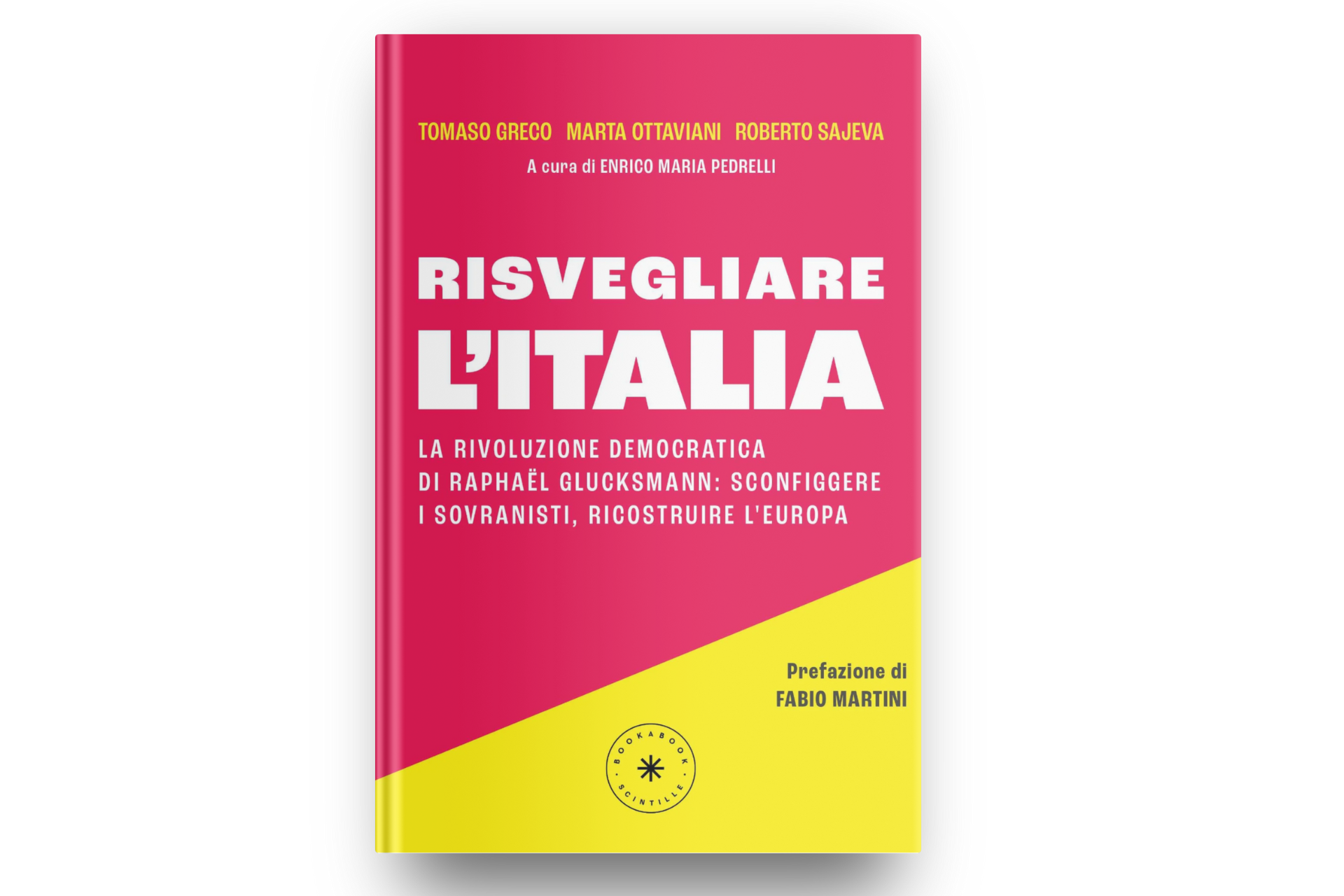
Commenti
Ancora non ci sono recensioni.