La migrazione della nostra specie è ancora oggi, dopo decine di migliaia di anni, motivo di fastidio per coloro che si ritengono nativi unici delle terre a cui i migranti approdano. Mentre la migrazione di animali, uccelli e placche continentali non sembra offendere o stupire nessuno, quella degli umani è un fenomeno osteggiato e continuamente sottoposto a drastica revisione, fino a farlo diventare strumento di distrazione di massa. In realtà il nostro migrare è una caratteristica connaturata che lascia un marchio indelebile nella storia personale, nell’albero genealogico e perfino nella mappa genomica di ogni singolo essere umano. Nessuno escluso. Nemmeno chi non si è mai mosso da dove è nato.
Prologo
Pietro, detto Piero, camminava sempre spedito, risoluto, attento. L’età non gli permetteva di correre, nonostante si sentisse ancora bersagliere. Marciava, però, come se dovesse attraversare velocemente una terra piena di seccature. Pericoli, perfino.
Da quando era mancata Serafina, camminava tutti i giorni per ore, preferibilmente di pomeriggio. Il mattino lo dedicava quasi maniacalmente alle pulizie del suo piccolo alloggio, al piano rialzato di un triste condominio, in una triste strada della città di Pinerolo.
Il percorso spesso comprendeva la salita che da dietro il cimitero va verso la collina. Raramente ci entrava, nel cimitero. Non era il tipo di vedovo che passa a salutare la tomba della moglie, per mormorarle un “ciao” o toccarle il viso di ceramica. Gli bastava sfiorare con gli occhi lo spazio che l’aveva accolta. La terra ai piedi della Val Lemina, da cui la sua Fina era emigrata nell’estate del 1948.
Dal primo marito, l’alpino Bonetto Pietro, sposato nel 1942 e partito subito per la Campagna di Russia, Fina non aveva mai ricevuto nemmeno una lettera. La fine della guerra non l’aveva liberata dalla paura che fosse morto, ma non le aveva nemmeno dato una speranza che fosse vivo. Ferito, mezzo congelato, forse. Ma vivo.
Poi era arrivata la notizia che temeva. Il marito era stato dichiarato disperso. Per la legge dell’epoca, Serafina era una vedova di guerra.
Perciò quando, un giorno piovoso, dal reparto gabbie della RIV di Villar Perosa l’avevano chiamata su al primo piano, negli uffici, “Fina, ti vogliono in Svezia, corri!”, non aveva esitato a firmare la richiesta di partire. Si sarebbe lasciata dietro la sua valle svuotata e un’Italia che ancora si asciugava le lacrime.
«Guarda che ti mandiamo a Göteborg, dove c’è già una bella squadra, gent ch’a travaja, gente che lavora e che non ha tante storie per la testa. Magari trovi anche marito.»
Il cugino svizzero
Un giorno d’estate, al rientro dalle ferie, mia moglie venne fermata da una collega nei corridoi del municipio di Pinerolo.
«Ciao, scusa, non ti ho più vista e mi sono scordata di dirtelo. L’altra settimana sono venuti da me due stranieri che volevano informazioni sul vostro conoscente del Sudafrica.»
«Che conoscente, scusa?»
«Ma sì, quello che era migrato con i tuoi suoceri anche in Svezia.»
«Ah, zio Piero.»
«Sì, il signore che ha perso la moglie tempo fa.»
«E chi erano questi forestieri? Che cosa volevano?»
«Non mi hanno detto chi erano, o meglio non l’ho capito. La moglie però parlava abbastanza bene l’italiano. Mi hanno presentato un documento con sopra stampato il nome di quel vostro amico e una data. Avevano scoperto che uno con lo stesso nome abitava a Pine-rolo, ma poi hanno saputo che era morto. Volevano capire se la data che c’era sul documento corrispondeva alla data di nascita del signore deceduto.»
«Che data era?»
«Non me lo ricordo, ma dagli atti di morte ho visto che sì, quel Piero era nato proprio nel giorno stampato sul documento. Ho risposto che era sepolto qui e che se era un loro famigliare e volevano vedere la tomba dovevano rivolgersi al custode del cimitero. Mi hanno lasciato un numero di telefono. Ricordami di dartelo.»
«Vabbè, chissà chi erano…»
Alla pausa caffè quel pomeriggio mia moglie rivide la collega.
«Eccoti il numero di quegli stranieri. Di’ a tuo marito di provare a sentirli. Parleranno inglese, sono sicura.»
«Ma noi che c’entriamo? E poi, ci sono i parenti di Torino. Si metteranno in contatto con loro, no?»
Zio Piero era morto agli inizi del 1999, sette anni dopo zia Serafina, una ventina d’anni dopo il ritorno in Italia. Piero e Serafina non erano proprio miei zii: erano stati nostri amici da sempre, perché avevano fatto la stessa nostra vita da migranti, negli stessi paesi e negli stessi anni. Negli stessi quartieri, anche. Di Piero i miei genitori conoscevano anche il padre, un muratore bresciano morto anni prima, e un fratello, Vico, che abitava a Torino con moglie e figlia. Di Serafina, invece, si sapeva poco, se non che proveniva da una remota e pove-rissima frazione collinare di Pinerolo.
Qualche mese dopo la morte di Piero, il fratello, erede unico, iniziò a svuotare il suo alloggio per poterlo mettere in vendita e invitò mia madre a tenersi qualche ricordo della coppia, vista l’amicizia che risaliva a cinquant’anni prima. Mia madre scelse delle fotografie, dei quadretti di artigianato africano e, chissà perché, quattro sedie da cucina.
La settimana successiva la collega tornò all’attacco su mia moglie.
«Allora, li avete sentiti, quei due?»
«Per dire loro che siamo dei ficcanaso? Nemmeno per sogno!»
«Ma no, tuo marito può dire che sono stata io a darvi il numero e a chiedervi di contattarli.»
Pur sapendo che il patrimonio di Piero era passato di mano per successione, quasi cinque anni prima della visita dei due sconosciuti stranieri alla sua tomba, mi venne il dubbio che sotto sotto ci potesse essere una questione di denaro. Speravo di non finire coinvolto in qualche pasticcio o truffa internazionale. Telefonai comunque al numero, che aveva un prefisso svizzero, ma rispose la segreteria telefonica. Prima in tedesco e poi in inglese, una voce maschile mi informò: «Avete raggiunto la casa di Rudi e Lisa Müller. Siamo momentaneamente assenti. Lasciateci un messaggio e il vostro numero. Verrete richiamati.»
In inglese, lasciai il mio numero di casa, aggiungendo che conoscevo da sempre la persona di cui avevano cercato la tomba al cimitero di Pinerolo. Per qualche giorno non arrivò alcuna comunicazione. Finché un lunedì, sempre in inglese: «Buongiorno. Mi chiamo Rudi Müller. Lei ha telefonato dicendo di conoscere Piero Uberti. Mi potrebbe dire da quanto esattamente lo conosce?»
Per una deformazione quasi professionale, il mio terzo orecchio analizzava in tempo reale quanto mi veniva comunicato. L’inglese era lento, corretto, l’inflessione vagamente germanica, ma c’era una nota di morbidezza stonata, quasi una cantilena.
«Praticamente da quando sono nato.»
«E quando è nato?»
«Nel 1952.»
«Ah, abbiamo pressappoco la stessa età. Io ho due anni in più. E dove è nato?»
«A Göteborg. In Svezia.»
«So bene dov’è Göteborg. Ci sono nato anche io.»
Un compaesano, dunque. Ecco spiegata la lieve cantilena. Nella mia mente passarono mille pensieri, come se il mio cervello volesse anticipare tutti i possibili scenari che avrebbero potuto aprirsi continuando la conversazione.
«Che strana combinazione! Ma lei come fa a conoscere Piero?» gli domandai.
«Piero non l’ho mai conosciuto, ma so chi è.»
«Non capisco.»
«Era mio padre.»
Dalla cornetta risuonarono mute ma fortissime le prime otto note della Quinta Sinfonia di Beethoven, quelle che rappresentano il “destino che bussa alle porte”.
«Credo che lei si riferisca a un’altra persona. Vede, Piero e la moglie Serafina erano amici di famiglia. Ci conoscevamo da sempre. Abbiamo vissuto gomito a gomito in Svezia e in Sudafrica per anni. Poi, quando sono tornati in Italia qualche anno dopo di noi, abbiamo ripreso a frequentarci. E di certo non avevano figli. L’avremmo saputo sicuramente, non crede?»
«Sì, capisco, ma anch’io ho saputo soltanto nel 1986 di essere figlio naturale di un italiano. È stato poco prima che mi sposassi.»
Nel frattempo, mia moglie, che non conosce l’inglese, seguiva la mia metà della conversazione senza capirci nulla. In modo insistente, gesticolando, mi chiedeva: «Chi è? Che dice? Che vuole?».
Con mani frenetiche, io le rispondevo: «Stai buona, aspetta, te lo dico dopo, non scocciare!».
Tirai un respiro e mi chiesi come fosse possibile che i miei genito-ri non avessero mai parlato della possibile esistenza di un figlio illegittimo. Sapevano tutto di zia Fina e zio Piero. La loro amicizia era così forte e antica che io e mio fratello li avevamo accettati come degli zii veri, due importanti nodi di una più ampia rete famigliare non ufficiale. Una struttura con una funzione aggregante perfino maggiore dell’altra nostra rete di sangue, quella ufficiale ma remota dei parenti rimasti in Italia.
Cercai di pilotare la conversazione verso uno sbocco pratico: «Va bene, ammettiamo che sia vero, che cosa vuole sapere da me?».
«Tutto quello che c’è da sapere di mio padre. Vorrei parlare con chiunque l’abbia conosciuto, rintracciare altri amici se necessario. Chi altro, secondo lei, potrebbe averlo frequentato?»
«Sicuramente aveva molti amici dai tempi della Svezia e del Sudafrica, ma alcuni sono morti da tempo. A Pinerolo c’è la famiglia di Franco, il socio di mio padre: loro se lo ricordano sicuramente. E poi di Piero c’è un fratello, con moglie e figlia. Abitano a Torino.»
«Come? Ci sono parenti stretti ancora in vita? Questo cambia tutto. Io non so assolutamente niente di lui. Per metà della mia vita il mio pensiero fisso è stato scoprire chi fosse mio padre, anche per capire chi sono io. L’unica immagine che ho di lui è quella che ho visto recentemente sulla sua tomba.»
«Se vuole, mi lasci il suo indirizzo e-mail e io le posso mandare foto di lui e di sua moglie, scattate in mille posti diversi.»
«Preferirei vederle di persona.»
«Allora deve tornare a Pinerolo, non crede?»
Ci scambiammo gli indirizzi e-mail e Rudi mi disse che mi avrebbe scritto per dirmi quando sarebbe tornato in Piemonte.
Il giorno dopo, però, mi mandò un messaggio: non sopportava l’attesa. Potevo mandargli qualche foto già da subito? Lo accontentai volentieri, dopo tutto ci legava un’eventuale pseudo-cuginanza. Me lo immaginai, commosso, ad aprire i file delle foto di suo padre ritratto in pose e occasioni diverse: in riva al mare a Göteborg, in Mozambico, per le strade di Durban, al fiume Vaal sul confine con lo Stato Libero di Orange con la nostra combriccola, sul battello del lago Plitvice nella Jugoslavia degli anni Sessanta, al matrimonio di mio fratello, infine in giacca e cravatta al ristorante cinese Ming Saan di Johannesburg.
Dopo nemmeno due settimane dalla nostra prima conversazione telefonica, Rudi e Lisa arrivarono a Pinerolo. Andai a incontrarli nel loro albergo in centro. Mi offrirono un caffè e lui mi parlò della sua ricerca, durata anni, e di come fosse arrivato a individuare a Pinerolo la presenza di Piero, purtroppo già deceduto e tumulato.
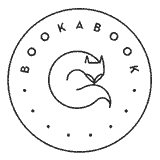

















MICHELANGELO NEGRO (proprietario verificato)
bravo Enzo!