A mio padre d’altro canto non l’ho detto perché non capirebbe. Lui è in viaggio da cinque anni nella galassia di Alzheimer. Fa cenno d’intendere ma poi dimentica. Allora mi guarda come se mi vedesse per la prima volta, quando prendiamo l’anima dagli occhi che incontriamo, ed è già da un’altra parte, nel tempo che non c’è. È un viaggio in peggioramento costante, calmo e automatico. Confonde nomi, giorni e luoghi. Mi chiama Samuele, e io non so chi sia ma soprattutto chi sia stato questo Samuele. Ho chiesto anche a mio fratello, ma anche lui non sa darsi una spiegazione. Mi ha detto che papà è uscito fuori di testa e basta, succede a tanti anziani, ma Paolo non sarebbe Paolo se non fosse a ogni costo tranchant.
«Torni domani, Samuele? Ci vediamo domani?» Mi sorride aguzzando un po’ gli occhi afflitti dalla cataratta, lui che non sorrideva mai.
«Domani non posso, devo lavorare. Ma tornerò presto» rispondo io, senza chiamarlo papà.
«Presto domani?» Si preoccupa.
«Sì, va bene, domani» mento.
Scambia Helena, impeccabile badante ucraina, sessant’anni, forse poco più o forse poco meno, a volte per sua madre, a volte per sua moglie. È vivo, ma in un certo senso è anche morto. Mia madre è morta davvero da cinque anni e riposa al Cimitero maggiore o Musocco, non lontano dai nonni, e per arrivare al loro sepolcro devi prendere un pulmino, come in gita. Non vado davanti alla sua lapide da molto tempo. Dei cimiteri non tollero l’odore dei fiori, e per noi che siamo pur sempre animali l’odore alla fine è tutto. E poi quel silenzio costretto che copre le tombe come una cappa. Quel loro essere sorde e mute che ti fa sentire più solo. I visitatori a passo lento, il capo chino, quei maledetti mazzi di fiori in mano tra le pareti abitate dai morti.
A mio fratello invece l’ho detto, o meglio, l’ho scritto. Ha dieci anni esatti più di me, Paolo, e il nostro è un rapporto epistolare di natura squisitamente digitale. Vive da ventidue anni negli Stati Uniti, a Chicago, dove si muore di freddo e dove ha sposato una splendida donna dai capelli rossi. Ha la frangetta e gli occhi verde smeraldo Shira, la pelle molto chiara e persino qualche lentiggine. Credo che abbia sangue irlandese ma non ho mai approfondito. Vivono in un bell’appartamento con vista sul Lago Michigan, che è più bello quando d’inverno ghiaccia. È un lago così grande che d’estate somiglia al mare, secondo Paolo, ma il fatto che è chiuso e immobile lo riempie d’angoscia. Un mare zoppo, l’ha definito. Ha due gambe fantastiche sua moglie Shira, oltre a una pluriennale relazione extraconiugale con un top manager in giacca e cravatta, di cui Paolo si è fatto una ragione solo per opportunismo. All’inizio ovviamente non la vedeva così. Shira è vegana e lavora alle risorse umane di una grande azienda farmaceutica, guadagnando un sacco di soldi, mentre mio fratello da qualche tempo fa il responsabile bar in un rinomato disco club. Si chiama Next ed è una specie di monumento in città per gli amanti del genere. La disparità dei due redditi è pari a quella tra i nostri caratteri. Prima ha gestito un locale tutto suo, sempre notturno, ma gli affari con la crisi finanziaria del 2008 hanno cominciato a girare male e così, d’accordo con la moglie, socia e principale finanziatrice, l’ha venduto senza rimetterci la pelle. Paolo non si rassegna al passare delle stagioni e pur avvicinandosi ai cinquanta non può fare a meno di fare le ore piccole. Adora vedere entrare dalle finestre la luce dell’alba, mentre io ne ho il terrore. Dice che ragiono come un settantenne e probabilmente ha ragione. Shira non l’ho mai conosciuta, nessuno della mia famiglia l’ha mai conosciuta di persona in realtà, e ovviamente non ho mai conosciuto il suo amante in giacca e cravatta, ma devo ringraziare entrambi perché è merito loro se io e mio fratello ci siamo avvicinati dopo un’infinità di tempo. Non riavvicinati, perché io e lui non siamo mai stati vicini. Siamo stati sostanzialmente invisibili l’uno per l’altro nei quattordici anni in cui abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto piccolo borghese. Diplomato al liceo scientifico Alessandro Volta e quasi laureato in Giurisprudenza in Statale, durante un week-end in compagnia di amici nelle Langhe, Paolo ha conosciuto l’allora giovane Shira in un ristorante. Erano a due tavolate vicine e, complici i vini nobili del Piemonte, si sono piaciuti e poi innamorati. Anche Paolo era molto bello, me lo ricordo. Ai tempi non aveva le braccia piene di tatuaggi e nemmeno gli orecchini. Lei è venuta a stare un paio di settimane a Milano da un’amica, dopodiché è tornata negli Stati Uniti. Sono rimasti in contatto per alcuni mesi, telefonandosi e scrivendosi con passione, fino a quando Paolo ha abbandonato l’università – gli mancavano due esami e la tesi – ha chiesto dei soldi in prestito a mio padre ed è partito per Chicago. Dopo un paio d’anni era sposato. Ce lo comunicò al telefono, i miei sorrisero e gli mandarono dei soldi. Non hanno fatto figli e non sono mai tornati in Italia. Nemmeno per il funerale della mamma, e questa è l’unica cosa che non gli perdono. Ci ha chiamato mediamente due volte al mese e i miei sembravano non soffrirne. Però ci ha mandato un sacco di cartoline dai suoi tanti viaggi, che mia madre ha conservato in una scatola per scarpe grigio topo. Oltre a moltissime foto digitali al mio indirizzo di posta elettronica. L’oggetto era sempre lo stesso. Foto per voi. E anche il testo. Spero stiate bene, un bacio americano a tutti e tre, il vostro Paolo.
In seguito alla sua partenza indolore non sono diventato il cocco di casa, perché mamma e papà erano due analfabeti emotivi e poi non avevano preferenze, né in fatto di figli né credo in altri campi. Ogni scelta è una rinuncia e loro non avrebbero mai rinunciato al proprio analfabetismo sentimentale. La vita, in fin dei conti, è continuata come se nulla fosse.
In casa mi sono sempre sentito un figlio unico senza i vizi né i privilegi di questa condizione, ma con addosso il peso di una strana assenza, quella di mio fratello, che ai miei occhi era un po’ vivo ma anche un po’ morto. Per dirla meglio, Paolo non ha mai incarnato la figura del mito e nemmeno quella dell’esempio irraggiungibile: per me è stato semplicemente un coinquilino fantasma, dotato di stanza autonoma, tra l’altro, uno sconosciuto quasi sempre fuori casa che a un certo punto, come tutti, ha trovato di meglio da fare. Andava a scuola regolarmente e il pomeriggio lo passava a studiare a casa di amici. A cena mangiava in fretta e furia, vorace, e poi guardava la TV in camera sua, oppure usciva. Tra di noi non ricordo litigi o risse per futili motivi e nemmeno fra lui e mamma e papà. Credo che fossero confortati dal fatto che, in fin dei conti, era un ragazzo che non aveva mai dato seri problemi, né a scuola né fuori. Di me e lui in casa non ho grande memoria.
Ogni tanto mi chiedo che fine fa tutta la vita che non riusciamo a ricordare e soprattutto cosa la viviamo a fare. Ricordo che una volta stordì una cimice, era in camera sua e io andavo in prima elementare, mi chiamò.
«Gabriele, vieni a vedere!» sentii urlare. Entrai. «Siediti, guarda un po’.» Era sotto la finestra, in tuta, inginocchiato. Le tende erano aperte, fuori potevi vedere ottobre, le foglie sugli alberi del giardino condominiale gialle e rosse che bruciavano dentro prima di cadere a terra morte. Ai piedi del letto le sue scarpe da ginnastica puzzavano. Mi guardò per farmi complice. Mi avvicinai, ma restai in piedi. La cimice, tra il verdognolo e il marroncino, dibatteva le zampine capovolta sul pavimento come una tartaruga rovesciata. Lui, col sadismo degli adolescenti, tirò fuori l’accendino che usava mamma per accendere i fornelli a gas e prese a bruciacchiarla, così, per il gusto di torturarla. Le zampine scomparvero fumando e la cimice passò in fretta a miglior vita, lasciando come testamento l’inequivocabile puzzo marcio. Io vomitai di getto: tre conati, due a vuoto e il terzo a segno, sequenza che sarebbe stata il mio marchio di fabbrica.
«Coglione cacasotto, adesso chi glielo dice alla mamma?!» Si arrabbiò molto, e mi tirò un pugno sullo stinco. Non piansi, ma nemmeno pulii la piccola chiazza di vomito giallastro, lasciandola lì a testimonianza della mia disobbedienza civile. Me ne tornai in cameretta e non gli parlai per qualche giorno, fino a quando un pomeriggio non trovai una confezione di Crystal Ball sul mio cuscino con un bigliettino azzurro su cui aveva scritto in uno stampatello stentato: Per Gabriele, da tuo fratello Paolo. Quando telefonava dall’America, solitamente all’ora di cena italiana, voleva sempre parlarmi, ma io non sapevo cosa dire.
«Gabriele, c’è Paolo dall’America!» gridava la mamma con una punta di orgoglio. Credo volesse farsi sentire dai vicini, fargli capire che aveva un figlio dall’altra parte del mondo che stava facendo fortuna. Mi avvicinavo al telefono svogliato. Balbettavo: «Sì, grazie», «Tutto bene tu?», «A scuola tutto bene», «Lì come va?» e poco altro. Le nostre domande e risposte cambiarono di poco col passare degli anni e anche quelle tra lui e i miei a dire il vero. «Sei in salute?», «Hai bisogno di soldi?», «Il lavoro come procede?», «Fa molto freddo?», «Tua moglie sta bene?». Quella della telefonata intercontinentale era una cerimonia immutabile, come una messa. Una volta mi chiese se mi avrebbe fatto piacere andarlo a trovare, visitare l’America. «Certo, magari l’estate prossima.» Ma dell’America non me ne fregava niente.
Durante quelle telefonate capii di odiare il telefono. Mi mette in imbarazzo, lo trovo d’intralcio alla comunicazione fra esseri umani, almeno per quelli che mi somigliano. Purtroppo sul lavoro sono costretto a utilizzarlo, ma ai miei interlocutori, italiani e stranieri che siano, confido sempre di prediligere la posta elettronica. Scripta manent, mi giustifico. A chi non capisce l’ironia, consiglio di cercare su Google.
Poi, la sera di Natale del 2009, l’arrivo di una sua e-mail, anomala come l’onda di uno tsunami. Allora Paolo aveva la mia età, io abitavo a Roma ed ero tornato a Milano per le feste. Avrei conosciuto Johanna dopo nemmeno un mese.
Non c’erano foto allegate e l’oggetto recitava: Periodo Nero. Era lunga, interminabile, ed esordiva con: Ciao, fratellino. Mi premetteva che la sua vita si stava spaccando in tanti piccoli pezzi, la moglie era innamorata di un altro, il suo locale era in vendita, con le pezze al culo, non aveva dei veri e propri amici, si sentiva in colpa per aver abbandonato mamma e papà. Che l’America era un posto infido, individualista, dove le persone sono automi che si valutano in base alla dichiarazione dei redditi. Che gli mancavamo, noi e l’Italia, ma non sapeva come dircelo e cose del genere. Comunque tutto era crollato come le torri del World Trade Center quando aveva scovato la password del cellulare di Shira e aveva avuto accesso ai suoi messaggi. Lei ovviamente non sospettava nulla. La cosa che lo stava mandando fuori di testa non era tanto l’essere stato tradito, quanto ingannato: Shira e tale Ryan si scambiavano battute in cui lo prendevano in giro e lo bistrattavano come un fallito. Lui le aveva scritto: Il tuo maritino è guarito dalla depressione? E lei aveva risposto: Al suo suicidio sarai il primo a saperlo, con tanto di risate a crepapelle in forma di emoticons. Paolo avrebbe voluto uccidere entrambi, ma non ne aveva il coraggio e non credeva che mai lo avrebbe trovato. Non per paura della pena di morte (allora nell’Illinois era in vigore, sarebbe stata abrogata un paio d’anni dopo), ma per la squallida codardia ereditata da papà.
Io non credo che papà sia un codardo, ho altre opinioni, forse altrettanto negative, ma io e Paolo non ne abbiamo mai parlato.
Scusa lo sfogo, fratellino, ma non so più dove sbattere la testa. Sento che tu puoi capirmi. Voglio dire che secondo me oggi siamo alla pari. Devo dirti la verità, quand’eri più piccolo credevo che fossi matto, forse addirittura autistico. Ti ricordi quando pisciammo dal balcone sul giardino del condominio e qualche giorno dopo arrivò la lettera dell’amministratore? Mamma e papà non ci parlarono per quindici giorni e a te niente, non fece né caldo né freddo. Non offenderti, ma ammetto che mi facevi un po’ paura, fratellino.
Lessi tutte quelle righe nervose e a tratti adolescenziali, sconnesse come un quadro di Braque. Provai imbarazzo. Cosa voleva da me mio fratello, che era vivo ma anche un po’ morto? Non ero arrabbiato. Piuttosto infastidito, perché la mia amata routine era stata turbata senza rimedio. Dopo una e-mail del genere non avrei più potuto far finta di niente. Risposi come l’impiegato di un customer center.
Ciao, Paolo, grazie della tua e-mail. Mi dispiace molto per quello che scrivi. Posso esserti d’aiuto in qualche modo?
Mi diede un appuntamento per una videochiamata su Skype per il giorno dopo, il giorno di Santo Stefano.
Gabriele, certo che non sto bene, sentiamoci domani pomeriggio alle sedici, ora italiana. Non dire niente a mamma e papà.
La notte dormii male chiedendomi dove volesse andare a parare il mio sconosciuto fratello maggiore e cosa si aspettasse di ottenere da me, che non avevo amici o quasi, e stavo bene così. Lui che era stato solo una voce nel telefono e di tanto in tanto un’apparizione sullo schermo del computer.
Chiusi la porta a chiave, misi le cuffie. Ci salutammo come due parenti a un colloquio in carcere. Io ero nervoso ma lo nascondevo bene. Lui era gonfio, impacciato, la barba lunga, gli occhi lucidi che non riuscivano a fissare lo schermo. Portava una canottiera bianca, le braccia completamente tatuate. Era teso come se fosse in crisi d’astinenza da qualcosa. Era tanto che non lo vedevo in video, mi sembrò più brutto, i capelli sporchi. Era invecchiato di dieci anni. Nella sua stanza era accesa una radio in cui delle voci chiacchieravano allegramente in inglese. Dopo un paio di minuti di convenevoli mi fissò attraverso lo schermo.
«Oh, guardati un po’» esordì dopo un colpo di tosse.
«Che c’è?» mi spaventai.
«Ti sei fatto proprio un bel ragazzo.» Sorrise.
«Grazie» risposi.
Si accese una sigaretta. Ne accesi una anch’io.
«Ma fumi?» mi fece. Non era contrariato, solo stupito.
«Purtroppo.»
Pensai a quanto fosse triste la mia famiglia, in cui nessuno sapeva niente dell’altro. Ci salutavamo, parlavamo, ma non ci dicevamo niente.
«Mamma e papà?»
«Niente, solitamente fumo sul balcone. C’è un posacenere che svuota la mamma.»
«Ah, ok. Lì come va?»
Fumava con voracità, come quando mangiava a tavola, gli occhi bassi, la forchetta veloce tra il piatto e la bocca.
«Bene, mamma e papà sono andati a fare una passeggiata, poi vanno a messa.»
«E tu?»
«Io normale.»
La risposta lo deluse, lo vidi. Allora mi decisi.
«E tu, invece? Tosto quello che hai scritto, mi spiace.»
«Tosto? Ma come parlate a Milano?!» E scoppiò a ridere.
«Bho.» Sorrisi. «Mi è venuta così.»
«Io una merda» disse lui.
«Non sei malato, vero?»
«Ma va, toccati le palle.» Si sforzò di ridere mentre faceva il gesto.
«Certo» risi anch’io, sollevato perché un po’ il dubbio nella notte m’era venuto.
Bevve dell’acqua, come a una conferenza. Io rimasi fermo.
«Senti, una cortesia, puoi chiedere a papà se mi fa un bonifico da cinquecento euro?»
«Certo.»
«Non è urgente. Digli che ho dei problemi con la banca e sono incasinato con i lavori di ristrutturazione al locale. Glieli restituisco entro un mese. Non ho voglia di chiederglieli che poi mi tempesta di domande. È un problema per te?»
«No, ci penso io.»
«Meno male. Se ti chiede altre spiegazioni, inventati delle scuse.»
«Ok.»
«Poi devo chiederti una cosa importante, però devi essere sincero.»
«Dimmi.» Non sapevo cosa pensare, forse era pieno di debiti e si era messo seriamente nei guai. Avevo paura di quello che avrebbe potuto chiedermi.
«A te farebbe piacere se ti mandassi delle e-mail ogni tanto? A te personalmente, intendo» tagliò corto. Tirai un sospiro di sollievo, non me l’aspettavo.
«Certo, perché non dovrebbe?» Sorrisi, sentendomi dentro una gioia inaspettata da non saper gestire. Come se qualcuno mi avesse perdonato una colpa che non sapevo di aver commesso.
«Sono contento, Gabry, davvero. Vi chiamo il 31 per farvi gli auguri.»
È sempre stato così mio fratello, uno che compie azioni inaspettate e decisive per sé e per gli altri all’improvviso, come a seguito di personalissime epifanie.
«Va bene, allora ciao, Paolo.»
Tirò su col naso. «Ciao, fratellino, stammi bene e rispondi alle mie e-mail.» Mi fece l’occhiolino e cliccò sull’icona della cornetta rossa.
Da allora, pian piano, siamo diventati grandi amici di penna, l’uno il confidente dell’altro. Ci abbiamo messo un po’ a scaldarci come si deve, almeno un anno, ma oggi posso dire che mio fratello è un amico. Da allora rare videochiamate e tantissime e-mail in cui non parliamo del passato né dei nostri genitori, che non hanno mai saputo nulla di questo cambio di rotta. È strano: è come se non fossimo mai stati fratelli. D’altra parte, lo sappiamo entrambi, il passato è una bottiglia rotta e raccogliere i pezzi può sempre farti male. Piuttosto ci teniamo aggiornati sui fatti principali delle nostre biografie in corso di scrittura e sugli argomenti più disparati: Trump, la guerra dei dazi, i cambiamenti climatici, le tasse non pagate dalle Big Tech, il sangue innocente in Siria. Lui ragiona in modo novecentesco e spesso ridicolmente ideologico, io gli do corda e lo assecondo perché mi diverto. Il fuso orario ci aiuta: gli scrivo sempre attorno all’una di notte, quando lì sono le sei del pomeriggio, e lui mi risponde all’alba, quando qui è ora di pranzo. Portiamo da sempre, entrambi, la croce degli insonni. Mi sono sempre chiesto cosa se ne facesse Paolo delle sue notti insonni in casa, se trovasse anche lui insopportabile il rumore del frigo, il ticchettio dell’orologio in cucina, e il russare a intermittenza regolare di papà. Se pensasse in quelle ore sospese le stesse cose che pensavo io, all’inizio o alla fine dell’universo, a come doveva essere Milano quando non era altro che la capitale dell’Impero Romano d’Occidente, dal 286 al 402 d.C. Al posto di Piazza Duomo cosa c’era precisamente? Sono andato al Museo Archeologico un giorno e ho scoperto con dispiacere che l’anfiteatro monumentale di Milano, il nostro Colosseo, non era lì ma addirittura fuori dalle mura cittadine.
Sono dieci anni che ci vogliamo molto bene da lontano e ci raccontiamo piccoli aneddoti, importanti e non. Parliamo di musica e di mille altre cose. Malediciamo la politica italiana, anche se non siamo mai stati annoverabili fra la cittadinanza cosiddetta attiva, e ci consigliamo soprattutto libri – saggi e romanzi – di cui scriviamo recensioni informali e accaldate che somigliano più a consigli per gli acquisti. Tutti e due leggiamo molto, un paio di libri alla settimana in media.

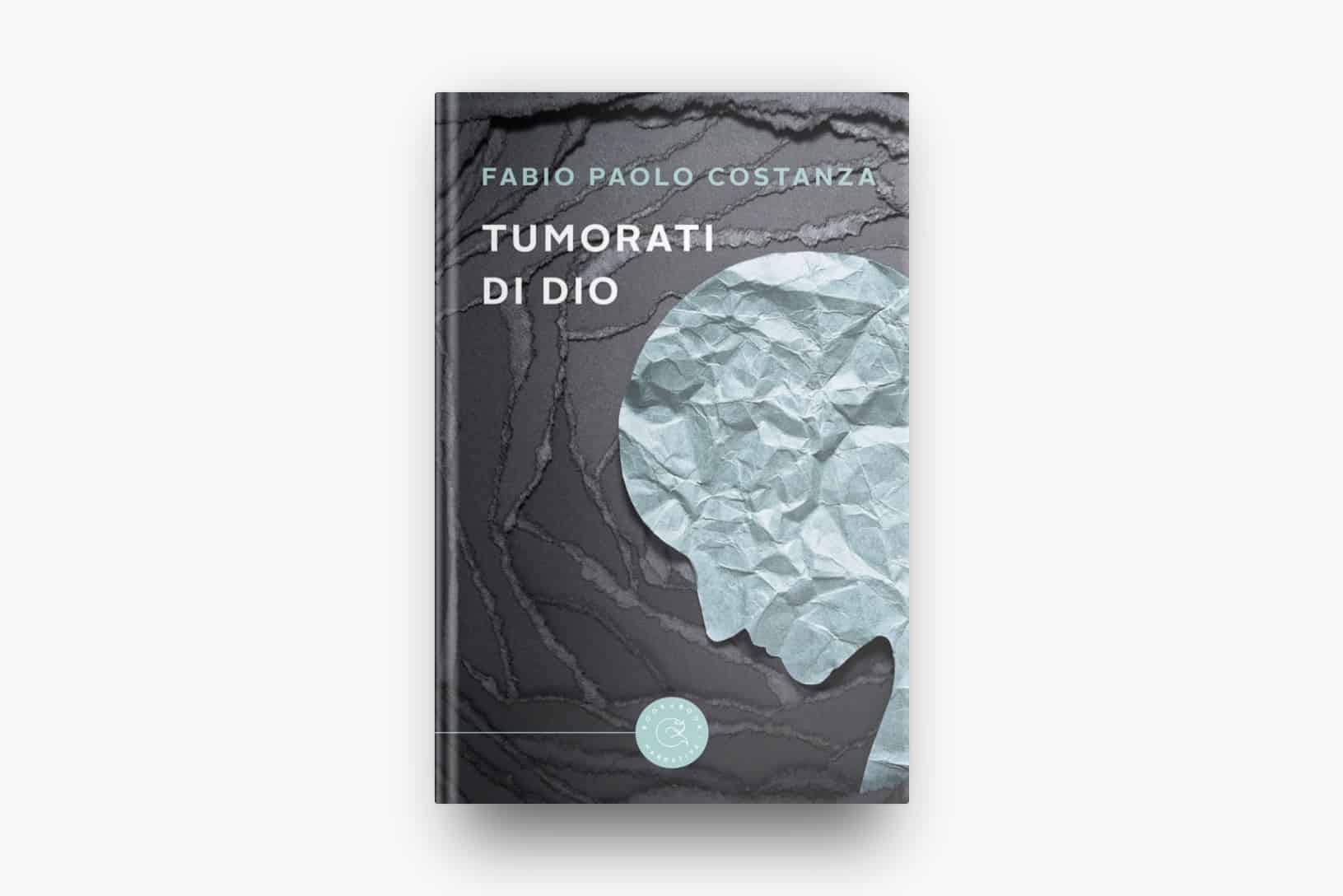


Commenti
Ancora non ci sono recensioni.