Rimase fermo senza fiato sull’erta che portava a Sant’Amasio, una frazione di Arpino nella Alta Terra di Lavoro, all’epoca sotto la provincia di Caserta. Si sedette sul sasso che per tante ore gli aveva dato compagnia quando pasceva le pecore da bambino, e l’emozione lo colse. Aveva creduto di non poter rivedere quei posti rimasti lontani, per lui, nel tempo e nello spazio. Ripensò alla sua infanzia quando, seduto proprio in quel punto, immaginava cosa potesse esserci oltre la riga dei monti, là dove la luce schiariva. Bevve con lo sguardo il familiare orizzonte come un assetato. Gli sembrò stretto rispetto a come se lo ricordava. Le sassose cime azzurrine che chiudevano la gola erano aride come nel passato.
Riconobbe da lontano il biancheggiare di quel rado gruppo di case, quasi ovili, solo ripari per uomini e bestie. Dimore arroccate su una pietraia dove le pecore, confondendosi con i massi, non trovavano altro che sterpi da brucare. Lassù, il vento sradicava i semi vuoti appena li piantavi inquella terra a strapiombo sul Rapido, un torrente in secca il resto dell’anno, come tutto il resto intorno.La sua famiglia stava alPilota, un casale del proprietario delle greggi, affossato in una valletta proprio sotto la chiesa del santo protettore lacontrada. Ne occupavano solo una stanza, come ciascuno dei nuclei familiari di altri lavoranti che vi abitavano. La zona era chiamata così forse perché da qui partivano tutti gli ordini del padrone. Ci vivevano altre famiglie, una per stanza, assieme aglianimali; nell’aia, un pozzo spesso asciutto.Michele era ormai vicino e vedeva il fumo uscire dal lato della casa dove stavano i suoi. Cominciò a tremare. Una folata d’aria gli riportò tutto in mente, e gli occhi presero a bruciargli, ma non per la polvere. Quanto tempo era passato da quando era partito.L’uomo, sopravvissuto alla Prima guerra mondiale, era stato congedato il 24 agosto del 1919 dopo aver raggiunto, da Como, Civitavecchia, sede del reggimento. Gli avevano pagato il premio di congedamento con quasi trecento lire e un pacco di vestiario. Decorato con due croci di guerra e tre medaglie, da soldato semplice era stato promosso Sergente istruttore degli Arditi per i meriti conseguiti durante la Grande Guerra. Con tutte queste novità, sperava di poter trovare nella sua famiglia un po’ di calore. Stava tornando a casa dopo tante peripezie, con il piccolo meritato gruzzolo, certo che, immaginando la situazione disastrata dei suoi familiari, almeno per questo sarebbe stato riaccolto con gioia.Era un civile, adesso, la guerra era finita. Tuttavia sentiva di aver perso status, potere sociale e identità, lontano dal mondo militare, dai commilitoni, dai compagni con cui aveva condiviso pericoli e sofferenze e con cui aveva vissuto senso di appartenenza e legami profondi. Sopravvivere senza certezza del domani era pane di tutti i giorni, allora. Bastava respirare, essere rimasti vivi aspettando l’alba di un altro giorno, ignorando se fosse l’ultimo. Senza divisa e senza gradi non aveva autorità, era nudo, impotente e indifeso come un neonato. Ora c’erano altre incertezze: il futuro, non quello immediato. Adesso poteva, doveva pensare a questo tipo di futuro, ed era l’incognita maggiore. Aveva una nuova sfida da affrontare, ma si sentiva forte, aveva una ragione per lottare: un amore. Erano in tanti a casa sua. Sperava che qualcosa fosse cambiato tra loro adesso. L’ondata di ricordi gli tolse il respiro come la salita che non finiva mai.
Era il primogenito, l’orgoglio del padre. Che fosse il prediletto, il padre glielo dimostrava in segreto, da quando si era risposato. Quanti progetti aveva fatto su di lui: da grande lo avrebbe mandato a studiare al Tulliano da convittore, se fosse riuscito a risparmiare. Il collegio fondato da Gioacchino Murat aveva grandi tradizioni umanistiche. Ci avevano insegnato Barnabiti e Gesuiti. A quel prestigioso Convitto, ad Arpino, ci andavano i figli di famiglie potenti per diventare a loro volta persone ricche e importanti. Michele era sveglio e intelligente e il padre, con grandi aspettative su di lui, glielo aveva promesso quando stavano soli, sui pascoli, mentre gli accarezzava la testa. Non poteva far vedere alla sua matrigna quanto gli voleva bene. Intanto l’uomo metteva da parte per quel grande momento, facendo la cresta sui soldi del cacio che rivendeva. Li teneva nascosti sotto un masso al pascolo, per non farseli prendere dalla moglie.Sempre a insaputa della donna, aveva chiesto al parroco, don Antonio, di insegnare il latino al figlio, quando andava a servire messa o dopo il catechismo. La scuola era una camera su una stalla a Casalvieri, dove s’imparava soltanto a leggere, scrivere e far di conto, e il ragazzo vi andava a malapena quando faceva brutto tempo e non usciva con le pecore. Don Antonio non se lo fece dire duevolte. In segreto sperava che Michele, dagli occhi brucianti e vivi, entrasse in seminario e si facesse prete. Assieme all’antica lingua, il vecchio sacerdote gli spiegava la liturgia, leggendogli passi della Bibbia, preparandolo spiritualmente, in cuor suo, per l’ordinazione. Michele aveva tredici anni quando un giorno, appena rientrato dal pascolo, vide una valigia di cartone pressato fuori dalla porta, con una sacca di tela attaccata al manico.Si chiese stupito chi fosse arrivato. Dentro la cucina, che era quasi tutta la casa, c’era solo Maria, la matrigna, con un signore. Lo aspettavano. La valigia era per lui. La donna ci aveva piegato il suo vestito della Prima Comunione, la Bibbia regalo di don Antonio di quell’occasione, panni da lavoro, gli scarponi che il padre gli aveva comprato a Natale e il Rosario della sua povera madre.Credendo che lo mandassero a studiare al Tulliano, seguì quel tale: lo chiamavano zi’ Mimme, nessuno sapeva il vero nome. «È venuto direttamente a prenderti a casa» disse ladonna con enfasi, dando importanza a questo particolare di non poco conto. Mentre parlava con il signore, Maria si era messa in petto un rotolo di banconote che l’uomo le aveva allungato. Lo fece con una mossa tanto rapida che a Michele sembrò si mettessea posto il busto. Discutevano sui soldi.


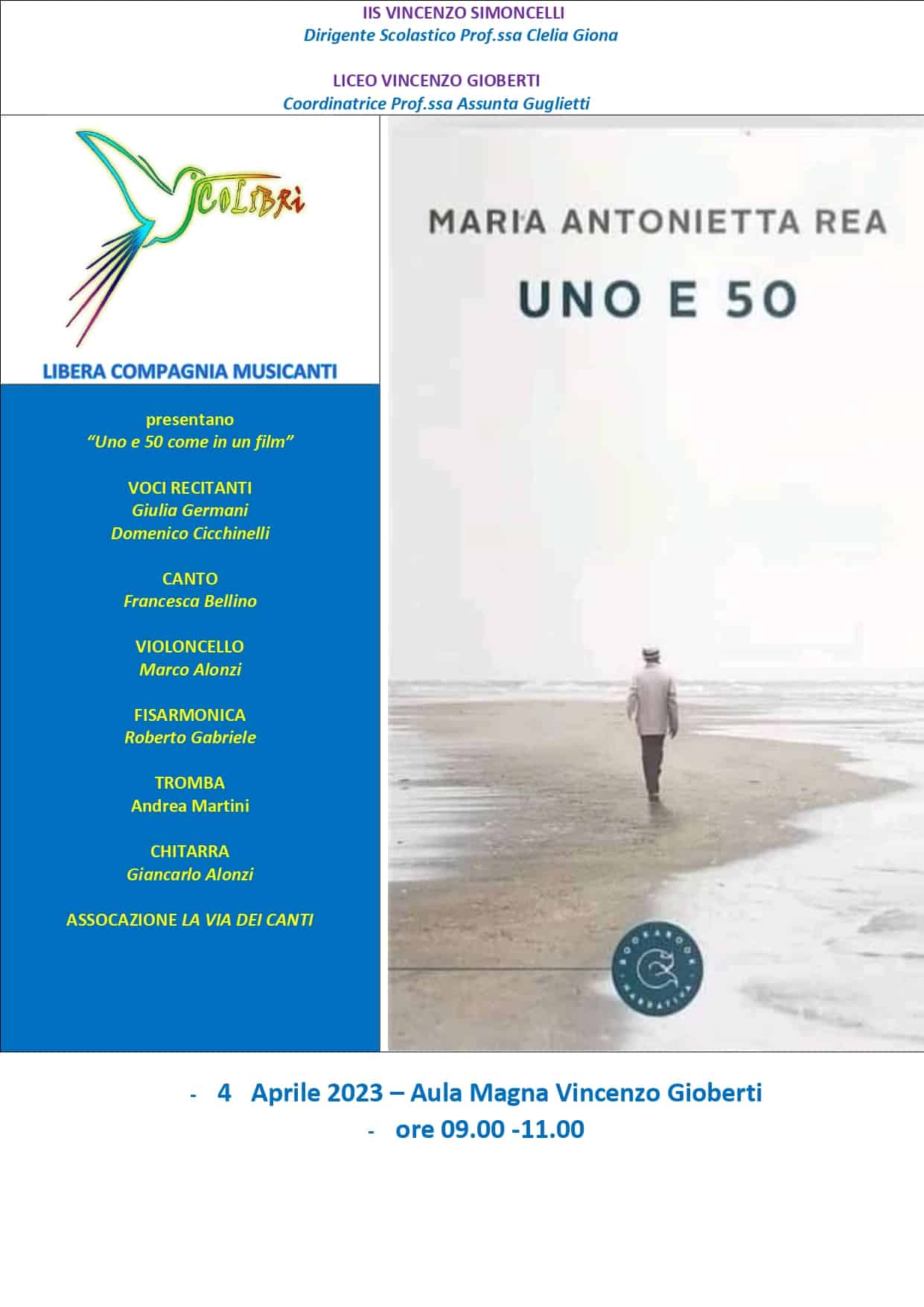





















Bruno la Pietra
Uno e cinquanta potrebbe sembrare la definizione della misura di un’altezza umana.
E forse lo è, almeno nelle intenzioni dell’autrice.
Eppure, leggendo il libro di Antonietta Rea, quel dittico numerico ci si rivela come qualcosa di più di una geometrica identificazione, se ne ricava un simbolico e più pregnante significato come sedimento inevitabile della coinvolgente lettura.
Il titolo identifica in effetti, molto più estesamente che il suo aspetto fisico, le cinquanta vite di un uomo, in un racconto che per fortuna evita, come una coerente opera d’arte impone, lo sguardo compiaciuto e affettuoso che la penna della scrittrice, sua nipote, avrebbe potuto riservargli, privando noi dell’autenticità narrativa e preziosa di questo romanzo meraviglioso.
Michele Rea, con le sue cinquanta e innumerevoli vite, diventa, tra raffinate e straordinarie trame descrittive, figura archetipica e atipica. Si incunea nel mondo degli affetti, degli stravolgimenti storici, delle perversioni relazionali intra famigliari, negli amori possibili e in quelli solo immaginati, con tenacia garbata, con epica francescana, con una humanitas che lo rende per questo figura universale, appunto archetipo di un essere umano a cui dovremmo tutti fare riferimento, proprio in questi nostri tempi di incertezza diffusa e di inconsapevolezza teleologica.
E lo fa sfiorando, grazie al tocco lieve della narratrice, episodi fondamentali della storia a cavallo di due secoli densi di vicende irripetibili. Ci riporta tra brividi di angoscia e stupore alle vicende di Ciaula che scopre la Francia, invece del selenico e argenteo tondo, alle attese speranzose dei derelitti parcheggiati a Ellis Island come fauna produttiva, evoca in maniera asciutta e spietata l’atmosfera della prima guerra mondiale, descrive l’euforia esplosiva e furiosa della rivoluzione d’ottobre, la retorica altisonante e violenta del fascismo italiano, fino a condurci alla disillusione delle contraddizioni asfittiche e decadenti della provincia italiana negli anni della caotica industrializzazione.
Dal punto di vista emotivo Michele Rea interpreta, da una prospettiva pietosa, lo zeitgest novecentesco in maniera encomiabile sradicandolo però da quella storia cruenta e sanguinosa, fino a farne la versione sempre attuale di una eterna e anti-celebrativa Odissea, confermando l’intuizione che la storia (pubblica o privata non importa), fatta di passato e intrecciata col futuro, è sempre memoria e insieme profezia. Ritornanze, rimembranze, ripercussioni, sensazioni, emozioni appaiono come cristalli di quel passato che riflettono a noi una lettura più confortante del vivere.
Certo che formalmente lo scritto è da annoverare come esempio autorevole del bildungsroman di teutonica derivazione (forse un’inconsapevole influenza della alpestre nonna Angiolina), e rifugge senza paura la seduzione modernista dell’anacronismo spiazzante caro alla letteratura novecentesca, oltre che la strutturazione labirintica dei maestri sudamericani.
Eppure, anche dal punto di vista formale, il romanzo svela con il ritmo progressivo, lineare, ordinato e coerente questa sua semplice ma difficile qualità, obiettivo finale della buona letteratura, come ebbe a sottolineare il grande cieco bonaerense nel suo ultimo e splendido volume, il Manoscritto di Brodie: Ho cercato, non so con quanto successo, di redigere racconti lineari. Non mi azzarderò a dire che sono semplici; sulla terra non c’è una sola pagina, una sola parola che lo sia, giacché tutte postulano l’universo, il cui attributo più noto è la complessità. I miei racconti, come quelli delle “Mille e una notte” intendono distrarre o commuovere e non persuadere.
E una commozione straziante e allo stesso vivificante resta saldamente attaccata alle nostre anime dopo questa lettura, come un brandello della divisa sul reticolato di un campo di prigionia di un piccolo soldato italiano.
Bruno La Pietra
christiane tomolillo (proprietario verificato)
Un bellissimo libro che sto leggendo. Sono francese e questa storia mi tocca particolarmente perché mio nonno nato ad Arpino aveva la stessa eta’ di Michele, migrato a Lione anche lui. Alle radici ci si ritorna sempre.. Questa storia di vita splendidamente scritta è molto ricca di eventi, emozionati, e resilienza. La memoria degli avi, corragiosi nonni rimane un tesoro a salvaguardare. Grazie mille Maria Antonietta per la trasmissione e la speranza portata.
Fabiana Lancia (proprietario verificato)
Nel libro di Maria Antonietta Rea la storia di Michele ci prende già dalle prime battute e ci trascina in un passato ancestrale e selvaggio dove la sua figura si muove tra grandi e piccoli eventi mantenendo intatta la sua integrità e il suo candore. Dal paesino sperduto della Terra Del Lavoro alla Grande guerra passando per lo sfruttamento in una vetreria francese e il duro lavoro di mozzo sognando l’America e trovandola poi finalmente in Irlanda , la cattiveria degli altri non riesce a scalfire il suo animo puro .Seguiamo le sue vicissitudini soffrendo con lui quando il suo destino lo pone davanti a enormi sofferenze e ingiustizie e rallegrandoci quando la sua e l’altrui bontà hanno il sopravvento. Una storia che ci insegna che nonostante i soprusi e le avversità l’umanita’ può riscattare se stessa attraverso l’umiltà e la condivisione .
Stefano Pelloni (proprietario verificato)
Una sola parola: stupendo! L’ho letteralmente divorato in due giorni. Scritto divinamente, il libro narra la storia di Michele Rea , una storia fatta di sofferenze, tragedie ma anche di successi . Un esempio di come sia importante la memoria , di quanto sia nostro dovere parlare e narrare di chi ci ha preceduti. In una società odierna dove “tutto è dovuto” è importante fare capire alle nuove generazioni che i nostri genitori, nonni, i nostri avi hanno fatto tanto per noi ed è giusto non dimenticarli mai e non dimenticare il loro sacrifici- Mi sono commosso in più punti ed ho veramente versato lacrime genuine. Brava Maria Antonietta, mi auguro che il tuo libro veda la luce perché lo merita; veramente.
Stefano Maria Pantano
Nei brani disponibili in anteprima l’autrice dimostra familiarità con la scrittura e promette di prendere il lettore per mano fin da subito. È intrigante l’idea della costruzione della storia a partire da questi appunti e già l’incipit è abbastanza smaliziato da non farti scappare. Si fa capire che Michele sia il proprietario del negozio di Belfast da un pezzo di discorso diretto, senza spiegare niente. Il ritmo diventa presto coinvolgente, mantenendo le promesse. Molto buono il finale del brano che strizza forse l’occhio al Baricco di Oceano Mare. I pensieri diventano il ritmo della marea tra frangenti e risacca, interrompendo per un attimo la narrazione. Una storia di radici e di ricostruzione generazionale per ricordare un presente di privazioni e sacrifici a cui questa generazione tendenzialmente molle è meno abituata di un tempo, credendo che tutto le sia dovuto in un vuoto delirio esibizionistico di massa fatto di fotografie in bagno e labbra troppo gonfie che poco hanno da dire.
Lucia Catenacci (proprietario verificato)
Tragedie, ingiustizie e momenti di relativa tregua, accompagnano la vita di Michele che, per la bella persona quale è, riesce sempre a trovare la via “giusta” e riprendere fiducia nella vita.
È un romanzo, le cui vicende narrate con maestria dall’autrice, é sicuramente un libro che deve far parte della propria biblioteca!
Mirella Marchione (proprietario verificato)
Le avventure di Michele Rea hanno qualcosa di epico, nonostante l’apparente “piccolezza” di quest’Uomo: non puoi smettere d leggere, hai bisogno di sapere cosa gli succede. La scrittura è sorprendentemente fresca, vivace, tale da catapultarti in epoche remote, modulata di volta in volta per adattarsi ai cambiamenti epocali in cui Michele si ritrova, suo malgrado, a doversi a sua volta adattare. Insomma, questo romanzo è un piccolo gioiellino. Da non perdere.